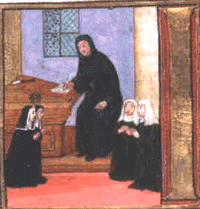
Mirna
Bonazza
"Frammenti" di biblioteche
nella Ferrara di Lucrezia Borgia:
note
sulla circolazione libraria tra i secoli XV e XVI
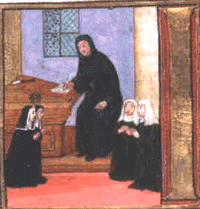 |
Mirna
Bonazza note
sulla circolazione libraria tra i secoli XV e XVI |
Proposito di questo breve saggio è di tracciare un essenziale profilo delle più importanti biblioteche ferraresi, monastiche e di corte, esistenti nel periodo in cui Lucrezia Borgia soggiornò a Ferrara, e immediatamente precedenti alla sua venuta, in relazione a quello straordinario evento che è rappresentato dall’invenzione della stampa e alle sue dirette implicazioni.
L’avvento della stampa rivoluzionò radicalmente il mercato librario modificando le relazioni di trasmissione della cultura. Con l’entrata nel circuito commerciale del libro a stampa le botteghe dei cartolai e degli stampatori, e di conseguenza gli acquirenti, potevano disporre di una vasta scelta di testi di vario argomento a prezzi certamente più economici rispetto a quelli dei manoscritti. Quindi l’abbattimento dei costi, e di concerto una maggiore competitività a livello economico che il nuovo prodotto garantiva, legato ad una divulgazione più immediata e capillare della cultura anche fra i privati, comportarono il successo del libro a stampa che venne accettato senza alcuna reticenza nelle biblioteche di diversa formazione influenzando anche ambienti più elitari, tradizionalmente ritenuti più chiusi.
Certamente, malgrado le forti implicazioni, a cui si accennava, che si possono rilevare fra l’epoca caratterizzata esclusivamente dalla produzione del codice e l’età che vede la nascita e poi lo straordinario sviluppo della produzione tipografica, non si può considerare immediata e netta la spaccatura tra le due tipologie. Questo perché, per diversi decenni, entrambe le produzioni coesisteranno ed il libro a stampa percorrerà gli stessi canali e farà uso delle medesime strutture che avevano precedentemente interessato la circolazione del manoscritto.
Iniziando quindi questo excursus tra le più significative biblioteche dei conventi ferraresi si avrà l’occasione di fare un accenno ad alcune raccolte librarie di privati, per poi giungere ad una più approfondita disamina delle librerie di alcuni esponenti della corte estense con particolare attenzione, ovviamente, ai libri appartenuti a Lucrezia Borgia.
Tra le biblioteche monastiche è importante menzionare quella del convento carmelitano di S. Paolo che doveva rappresentare nella Ferrara del XV secolo la più ricca libreria - e per numero di volumi, e per la sua rilevanza in quanto testimonianza del sapere medievale, per ciò che concerne i codici più antichi costituenti l’originario nucleo della biblioteca, e per la fiorente cultura "moderna" di spirito umanistico - appartenente ad un ordine religioso. Incrementata dal frate Battista Panetti - priore a più riprese negli ultimi trent’anni del secolo XV – il quale svolse una profonda opera di bibliofilo e filologo raccogliendo, emendando, postillando e conservando i codici da lui accuratamente selezionati. Attualmente i codici superstiti - un esiguo numero, solo 46, se si pensa ai 700 che il Panetti riuscì a raggruppare - sono custoditi presso la biblioteca Ariostea, confluitivi a seguito delle soppressioni monastiche avvenute alla fine del secolo XVIII.
Ma Panetti non si limitò a curare con rigore scientifico la tradizione dei testi manoscritti, ebbe anche il merito di impegnarsi attivamente nella produzione editoriale, quindi non solo limitatamente alla pura scelta delle opere, collaborando alla realizzazione di edizioni a stampa, uscite dai tipi di Lorenzo Rossi, nel ruolo di revisore.
Sulla scia dell’entusiasmo che il duca Ercole I mostrava di avere per il teatro, a cui diede un forte impulso, e per la traduzione di opere classiche, data la sua ben nota scarsa propensione al latino, da rappresentare sulla scena, Panetti eseguì la prima traduzione italiana delle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio. L’opera di volgarizzamento, che gli venne commissionata dal duca, si apre con la dedica al signore Estense "Allo prestantissimo Hercule ducha de Ferrara, lo suo divoto oratore frate Baptista da Ferrara". Di questa straordinaria opera ci sono pervenuti due codici: l’esemplare di dedica, autografo del Panetti, conservato presso la Biblioteca Estense di Modena e una copia custodita presso la Biblioteca Ariostea che doveva essere ad uso dei frati del convento di S. Paolo.
Il Panetti nella dedicatoria al duca sottolinea "Non è adunque se non laudabile il tuo desiderio, ex.mo principe, che hai circha le historie, le quale si de grecho come de latino fai in lingua materna interpetrare acioché come homo più presto ne le arme che negli studij exercitato le possi intendere senza obscuritade alcuna."
Altrettanto significativa la biblioteca del monastero olivetano di S. Giorgio - sede anche di un importante scriptorium in cui operò il noto copista frate Guido di Alemannia negli anni successivi alla metà del secolo XV - che si costituì non solo grazie agli acquisti sul mercato librario ma anche con le donazioni di privati e per via ereditaria come nel caso della prestigiosa collezione libraria di Giovanni Aurispa. è noto che nel 1464 per disposizione testamentaria il di lui figlio o pupillo, Paolo Salvatore, che l’anno avanti era entrato nel suddetto monastero, nominò i frati di S. Giorgio suoi eredi universali. Quindi la parte di biblioteca paterna di sua proprietà, costituita da ben 137 codici, confluì nella biblioteca del convento. La raccolta andò poi venduta dagli stessi monaci, i quali non avevano compreso la straordinarietà della libreria che fu giudicata non confacente alle loro necessità di religiosi, e acquistata quasi in toto dall’umanista Ludovico Carbone.
Parte dei codici della biblioteca del cenobio di S. Giorgio, riconoscibili dalle note di possesso e dalle segnature, sono pervenuti con le soppressioni napoleoniche dei conventi, così come altre collezioni provenienti dalle altre congregazioni religiose cittadine, all’allora Biblioteca Civica, non ancora Ariostea.
Sembra essere una sorte alquanto comune la dispersione di cospicue biblioteche realizzate da privati: ne è una testimonianza la prestigiosa collezione libraria appartenuta a Palla di Nofri Strozzi ereditata dal figlio Giovan Francesco e poi smembrata nel 1485. Stesso destino toccò alla biblioteca di Francesco de Lignamine, vescovo di Ferrara negli anni che vanno dal 1446 al 1460, che spicca per l’alto livello qualitativo dei pezzi, ma purtroppo nota solo dagli inventari.
Un ultimo accenno in relazione alle biblioteche conventuali ferraresi di maggior rilievo, mi sia consentito di rivolgerlo alla biblioteca del monastero di S. Cristoforo della Certosa, fondato da Borso d’Este nel 1461 e da lui sostenuto economicamente. E’ infatti attestato, in quello stesso anno, l’acquisto, voluto dal duca, di un consistente numero di codici a favore della Certosa per i quali vennero pagati gli eredi dell’Aurispa. Tuttavia anche presso il convento certosino era operante uno scriptorium, ne è testimonianza diretta un codice - si tratta del commento di Pietro dell’Aquila alle Sentenze di Pier Lombardo - prodotto all’interno del monastero nel 1469 ed acquistato l'anno seguente da Battista Panetti per il convento di S. Paolo, come attesta la sottoscrizione di mano dello stesso. Presente al momento della consegna il miniatore Guglielmo Giraldi, presunto esecutore delle miniature del codice, che proprio in quegli anni intratteneva rapporti professionali con la Certosa.
Dopo aver trattato di biblioteche monastiche è d’obbligo proporre un differente modello, portando alcuni esempi di biblioteche di corte.
La libreria di Ercole nell’inventario redatto nel 1495 da Girolamo Giglioli, assistito da Andrea da le Vieze e da Bartolomeo Nigrisolo, contava 512 pezzi fra libri manoscritti e a stampa.
Anche la corte estense accolse il cambiamento, originato dall’invenzione della stampa, favorevolmente: il duca Ercole I, a differenza del suo predecessore Borso culturalmente troppo distante da questo nuovo strumento di comunicazione del sapere ma anche di promozione d’immagine, comprese perfettamente la forza che il nuovo fenomeno era in grado di produrre nella società incidendo in particolare a livello propagandistico.
è a partire dall’ultimo decennio del secolo XV che si nota un sostanziale incremento dei libri a stampa negli inventari delle biblioteche, e da questa tendenza non si discosta nemmeno la biblioteca di corte.
Una biblioteca ricchissima di opere di ogni genere: di letteratura, di religione, di agiografia, di filosofia, di alchimia, di argomenti ludici. Abbondano gli autori classici e fra di essi è d’uopo menzionare i più importanti: Aristotele, Boezio, Cicerone, Cesare, Cornelio Tacito, Esopo, Lucrezio, Plauto, Plinio, Quintiliano, Orazio, Sallustio, Seneca, Svetonio, Terenzio, Tito Livio, sia in latino che in volgare. Sono presenti i padri della Chiesa: S. Agostino, S. Girolamo, S. Giovanni Crisostomo. Non mancano le cronache, i trattati, i dizionari di latino, le ricette, i testi giuridici, di arte venatoria e di arte magica, libri di canto ma anche di duelli, persino diversi libri di scacchi.
Altrettanto numerose le opere dei grandi del Duecento e del Trecento: Dante, Petrarca, Boccaccio; degli umanisti quali Leonardo Bruni, Pietro Candido Decembrio, Battista Massa d’Argenta, Guarino Veronese, Ercole e Tito Vespasiano Strozzi, Francesco Ariosti, e altri ancora che come questi ultimi furono legati alla corte estense. Ricorrono, più volte citati, altri autori quali Michele Savonarola e, il di lui nipote, il frate domenicano Girolamo Savonarola. Sono elencate, inoltre, un numero cospicuo di opere di tradizione cortese in lingua francese ed un curioso "Messias contra Zudei in todesco". Ma non si possono non notare, poiché spiccano per quantità, i numerosi libri liturgici: breviari, Bibbie, Vangeli, libri d’Ore, salteri, messali. E’ nota infatti la fervente fede religiosa del duca Ercole impegnato, anche in maniera propagandistica, a manifestare con opere religiose - e si fa riferimento non solo alla fondazione di istituzioni monastiche tout court altresì ad un apparato che coinvolge la sua immagine pubblica - la sua profonda pietas.
E’ da sottolineare la presenza nell’inventario di un superstite codice estense, uno dei pochi attualmente conservato presso l’Ariostea: La Spagna ossia Imprese di Carlo Magno, proveniente dalla biblioteca di Borso, che lo aveva commissionato, e confluito nella biblioteca di Ercole I.
Infine non si può non ricordare uno splendido esemplare di dedica donato a Ercole I: si tratta della Vita Beati Joannis a Tauxignano episcopi Ferrariae scritta tra il 1501 e il 1505 da un anonimo, certamente un membro della Congregazione dei Gesuati, alla quale anche l’illustre vescovo di Ferrara appartenne. Interessante è la dedicatoria al duca Ercole I nella quale il gesuato fa esplicita allusione al non ancora celebrato matrimonio, ma atteso, fra il primogenito del duca, Alfonso I, e la figlia del papa, Lucrezia Borgia, esprimendosi in questi termini: "Nunc quom tibi sit Illustris Alphonsus filius tuus primogenitus Alexandro VI Pontifici maximo stricta affinitate coniunctus".
Se di fronte alla biblioteca del duca Ercole non si può che restare incantati per la ricchezza delle sue opere e per la vastità dei suoi contenuti e delle discipline trattate, sicuramente, della biblioteca della di lui consorte, Eleonora d’Aragona, non si potrà che decantare i preziosi esemplari che testimoniano in quale crogiuolo di raffinata cultura doveva essersi formata la principessa, educata alla corte napoletana secondo i dettami della tradizione spagnola.
La cultura spagnola aveva fatto il suo ingresso alla corte estense con l’arrivo a Ferrara nel 1473 della splendida e colta Eleonora, figlia del re di Napoli Ferdinando I d’Aragona, destinata a divenire sposa di Ercole I.
Questa argomentazione ci consente di indagare nel tessuto culturale di queste due dame – Eleonora e Lucrezia – per poter fare così un raffronto diretto fra le loro raccolte librarie.
Eleonora era cresciuta in un clima culturale cosmopolita e plurilinguistico in cui – malgrado la tendenza da parte del padre Ferdinando a privilegiare la creazione di una libreria umanistica ed è in questo senso che egli concentrerà le proprie risorse commissionando a un’équipe di copisti, miniatori e legatori "di corte" la realizzazione di quest’opera - era ancora molto forte l’influsso catalano e castigliano. Il nonno paterno, re Alfonso V, aveva anch’esso respirato questa cultura e si era formato in quel fervido crogiuolo che era la corte aragonese. Difatti la sua libreria di "educando" principe era costituita soprattutto da opere di tradizione romanza scritte in catalano, castigliano e francese, oppure di tradizione medievale ma sempre tradotte, pochissime invece quelle in latino. Il castigliano e il catalano erano le lingue nelle quali parlava e scriveva, mentre non possedeva la padronanza del latino e dell’italiano. Tutto ciò non gli impedirà di operare una profonda trasformazione – e questo mutamento si realizzerà dopo la conquista di Napoli del 1442 - che interesserà ad ampio raggio la produzione delle raccolte librarie della personale biblioteca di corte tanto da annoverarlo tra i principi promotori della cultura umanistica e lettore dei classici modificando radicalmente la propria immagine. La biblioteca napoletana dei re d’Aragona fu interprete di queste due differenti, ma complementari, sfere di influenza: cortese che affondava le sue radici nella tradizione romanza e umanistica specchio di una più moderna espressione della nuova biblioteca di palazzo.
Dall’inventario redatto nel 1493 alla morte di Eleonora d’Aragona emerge la figura di una libreria costituita principalmente da libri liturgico-devozionali – breviari, messali, diurnali, libri d’Ore, i Salmi, l’Antico Testamento, e nello specifico si citano il Genesi e l’Esdra, il Nuovo Testamento, epistole et Evangelij, prediche, manoscritti agiografici, l’opera di Santa Caterina da Siena e di S. Girolamo, i Fioretti di S. Francesco, ed altri libri della medesima tipologia – ma anche da classici quali: Plinio in vulgare a stampa, i Commentari di Cesare, il De consolatione di Boezio.
Figura inoltre l’opera di Fazio degli Uberti "cum lo chomento".
Prevalentemente si tratta di manoscritti, tuttavia sono presenti anche libri a stampa, sia in volgare che in latino ed anche in francese come il già citato Boezio.
Una caratteristica comune, particolarmente evidente, è data dalla preziosità delle legature la prevalenza delle quali ferraresi: splendide creazioni di lusso in raffinati tessuti di raso, di seta, di velluto, accompagnati da fermagli in argento, di cui si specifica quando presenti dorato, in oro, o in ottone, dotate di ricche sopraccoperte in broccato d’oro, in damasco, in velluto, e in raso altrettanto preziose. Se ne menzionano alcune di esecuzione fiorentina "de brasilio" o "de curamo rosso stampato a la damaschina" o ancora "de curamo morello camuzato ala damaschina".
Certamente il lusso e la fastosità delle splendide legature dei libri appartenenti alla biblioteca di Eleonora non possono che ispirarsi alla tradizione aragonese.
Ma è con l’arrivo di Lucrezia Borgia a Ferrara che la cultura letteraria spagnola permea nel tessuto locale con maggiore incisività. Dall’inventario degli anni 1502-1503 dei libri appartenuti a Lucrezia – che, non meno di Eleonora, era discendente di un illustre casato di origine spagnola e in cui quella cultura primeggiava - emerge la presenza di libri in spagnolo.
Il Bertoni - che ci offre l’inventario - segnala l’esistenza di un codice prodotto in Spagna e portato a Ferrara da Lucrezia. Si tratta di un manoscritto "de canzone spagnole de diversi autori, el principio del quale sono li proverbi" di don Domenico Lopez "coperto de coro rosso, con suoi cantonieri et atachagli d’otone". Ed ancora "un libro chiamato el dodexe del cristianno, in lingua valentianna, quadernato in tavole con suoi fornimenti de hotone" del quale si dice "lo tien el Ducha". Si menziona inoltre una Vita Christi in spagnolo.
Tuttavia la libreria della duchessa non si limitava esclusivamente ad una produzione di tradizione iberica. Infatti dall’esame dei libri elencati nell’inventario emerge anche una forte eterogeneità di argomenti nella "biblioteca" personale di Lucrezia che rispecchiano un’indole versatile e una spiccata curiosità intellettuale della duchessa nei confronti dei vari campi del sapere: il suo interesse è rivolto a testi di filosofia, di letteratura, di agiografia, di teologia, scritti in volgare, a stampa o manoscritti.
Malgrado ciò dai loro titoli si comprende la matrice religiosa, anche se sarà a partire dal 1513 che Lucrezia avvertirà con maggiore intensità il richiamo verso la vita spirituale. Sono presenti infatti un libro di "pistole et Evangelj volgari, a stampa", lo Specchio della Fede, sempre a stampa, di Roberto Caracciolo, un libro in volgare "de la lezenda de Santi", le epistole a stampa di Santa Caterina da Siena, e le già succitate opere di carattere religioso in lingua spagnola.
Nella sua libreria sono inoltre presenti Dante "comentato, a stampa", Petrarca "in forma pichola, in carta pechorina scritto a manno", Donato; ma anche un "libro a stampa de l’Aquila volante" che si suppone faccia riferimento all’opera di fra Guido da Pisa anticamente attribuita all’umanista Leonardo Bruni, un Supplemento delle croniche, a stampa, attribuite al padre agostiniano Giacomo Filippo Foresti, un libro de ventura di Lorenzo Gualtieri detto Spirito. Interessante la natura di quest’ultimo libro che tratta della sorte.
I libri della principessa – malgrado non presentino lo stesso livello qualitativo, se li si considera dal punto di vista della confezione della legatura, dei libri di Eleonora d’Aragona - sembrano comunque essere preziosi, dalla descrizione che si ha della legatura e, ove presente, della miniatura, come ad esempio "uno libro de copple a la spagnola in carta bergamina, tuto miniato d’oro, coperto de veluto carmexino, con cantonere et atachagli de argento, in una borsa de camosso rosso". Invero si tratta di un unico esemplare che spicca per la ricchezza dei suoi finimenti e il pregio del tessuto. Altri, che costituiscono la maggioranza, invece meno lussuosi coperti in "coro rosso" o, in numero prevalente, "de coro pavonazo", o di differenti colori con chiodi, cantonali, e fermagli in ottone.
Sicuramente diviene problematico ricostruire, da un così esiguo numero di libri, soltanto quindici, quelle che dovevano essere le letture della giovane sposa di Alfonso I e trarre conseguentemente delle conclusioni realistiche in proposito. Probabilmente doveva trattarsi di un piccolo corredo di libri selezionati che la principessa aveva portato con sé e che ci danno l’idea di quelle che dovevano essere le letture che prediligeva o che aveva in animo di approfondire.
Sono giunte fino a noi le testimonianze relative ai suoi interessi letterari e alla sua curiosità intellettuale: a corte amava circondarsi di letterati che tanto hanno decantato le sue virtù e che hanno lasciato memoria della sua bellezza e delle sue qualità. Nicolò Maria Panizzati compose per lei epigrammi in latino che intitolò Borgias, i quali sono conservati in un unico esemplare manoscritto custodito presso l’Ariostea; Pellegrino Prisciani, astrologo e uomo di corte, che scrisse l’Oratio in nuptiis Alphonsi I Estensis et Lucretiae Borgiae di cui si conserva l’autografo sempre presso l’Ariostea; Celio Calcagnini che in occasione del suo arrivo a Ferrara scrisse un carme latino, l’allora giovane Ludovico Ariosto la immortalò in una ottava dell’Orlando Furioso, anche se il poema una volta terminato verrà dedicato al cardinale Ippolito. Ed ancora la omaggiarono Antonio Tebaldeo, Lilio Gregorio Giraldi, il Trissino a lei particolarmente caro in amicizia. Ma i versi più appassionati le vennero dedicati da Tito Vespasiano Strozzi e dal di lui figlio Ercole nei numerosi epigrammi. Le poesie degli Strozzi furono poi stampate nel gennaio del 1513, a Venezia, da Aldo Manuzio il quale - per dimostrare la sua profonda riconoscenza all’illustre duchessa che si era impegnata nella promessa fattagli di fondare, appena fosse stato possibile, l’Accademia da lui tanto agognata - la omaggiò della dedica dell’edizione.
Non di meno la glorificò Pietro Bembo che con lettera di dedica datata Venezia 1 agosto 1504 le dedicò un dialogo sull’amore intitolato Gli Asolani, poi pubblicato nel marzo del 1505 per i tipi di Aldo Manuzio.
Osannata, glorificata, adulata da sincera e vera passione, ma anche incensata da quel "prepotente" spirito cortigianesco aleggiante nelle corti del Rinascimento e che ne caratterizzò i tempi, Lucrezia, musa ispiratrice dei poeti estensi incarnò nel loro immaginario l’ideale classico.