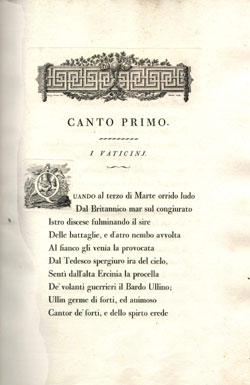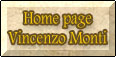|
La poesia di Monti
accompagna dappresso la vita politica ‘cesarea’ fin dall’incoronazione
dell’Imperatore a Re d’Italia, il 26 maggio 1805. Per l’occasione – rispolverando
con sapienza maniere frugoniane e varaniane, già sperimentate con successo
negli anni romani – compone una Visione dedicata “Alla Maestà di Napoleone I” (poi nota come Il beneficio). Monti fu nominato il 10 agosto 1805 “istoriografo del Regno”,
con il compenso di seimila lire. Non gli si chiede certo, come pure
egli teme in un primo memento, di scegliere tra Melpomene e Clio: meglio
per tutti che la Storia venga filtrata dai versi! La sua poesia ‘immaginosa’
avrà da questo momento in poi anche il compito di narrare le gesta politico-militari
di Napoleone. Impegno preso subito molto sul serio da Monti, il quale
nel 1806 dà alle stampe, con dedica “Alla Grande Armata”, le ottave
de La Spada di Federico). Ma soprattutto,
in quello stesso 1806, si apre il cantiere del Bardo della selva nera, l’opera più ambiziosa e letterariamente problematica
di questo àmbito della produzione montiana. Ma
già nel settembre del 1806 l’officina intorno all’Iliade
appare allestita, come testimonia con certezza una nota lettera di Monti
a Foscolo. Mentre l’anno successivo esce per il bresciano Bettoni l’Esperimento di traduzione, trittico omerico promosso da Foscolo, che
riproduce un saggio della versione letterale di Cesarotti, ma soprattutto
accosta le prove dello stesso Foscolo e di Monti. E il confronto delle
lezioni fa emergere clamorosamente il diverso atteggiamento dei due
rispetto al dettato del testo classico, atteggiamento che Monti contribuisce
a chiarire con il saggio Della
difficoltà di ben tradurre la protasi dell’Iliade (“quando si traduce
non è più la lingua del tradotto, a cui si debbano i primi riguardi,
ma quella del traduttore”). Attualizzando la veste del poema omerico,
non solo per l’opzione linguistica, ma anche per la “nobile semplificazione
dello stile” (Visconti) e per certa drammatizzazione insieme monumentale
e patetica, Monti appare già perfettamente consapevole della strada
da percorrere. Una strada che lo porterà ad allestire la più grandiosa
macchina poetica del classicismo napoleonico, accolta subito con un
successo fragoroso, in verità tanto persistente (soprattutto nel canone
scolastico), quanto per lunghi decenni criticamente debole. Da qui fino
alla princeps dell’intera versione (Brescia,
Bettoni, 1810, voll. 3) e poi ancora alla seconda edizione (Milano,
Dalla Stamperia Reale, 1812, voll. 2), l’impegno montiano sarà però
estenuante, con interventi minuti di revisione, protratti anche in piena
fase di stampa. |