Nuovo Piano Urbanistico di Ferrara
Quadro Conoscitivo
ottobre 2003
1. Introduzione
Ferrara sta predisponendo un nuovo strumento urbanistico per diverse ragioni: la necessità di risolvere alcuni nodi del Prg vigente, l’opportunità di collocare, entro un quadro generale di riferimento, le trasformazioni di importanti parti di città già inserite in sei ambiti di riqualificazione urbana (PRU-PRUSST), facendo riferimento alla nuova Legge regionale che ne prevede l’articolazione in Piano Struttura, Piani Operativi e Regolamento Urbanistico Edilizio.
Una prima tappa del processo di pianificazione intrapreso, ha avuto luogo nel marzo 2003 con la presentazione della Bozza del Documento Preliminare, la relativa mostra e le numerose presentazioni e discussioni con gruppi sociali, associazioni di categoria ed il forum di Agenda 21 locale. In quel caso non si trattava ne di un’anticipazione e nemmeno di una sintesi del successivo Documento Preliminare, ma di una prima verifica della struttura logica e del livello di condivisione dell’impostazione generale del lavoro. La scelta di costruire un articolato percorso di partecipazione della società locale alla redazione del nuovo PSC ha così trovato nella presentazione e discussione della bozza un fondamentale momento di confronto e di scambio di idee.
Una seconda tappa è costituita dalla presentazione del Documento Preliminare del PSC di Ferrara. Esso costituisce la base fondamentale
per l’avvio della Conferenza di Pianificazione e per la redazione del PSC. Principale finalità della Conferenza di Pianificazione sarà (art. 14 L.R. 20/2000) "costruire un Quadro Conoscitivo Condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonchè di esprimere valutazioni preliminari in merito agli obiettivi e alle scelte di pianificazione prospettate dal Documento Preliminare".
Il percorso di lavoro svolto in seguito alla presentazione della Bozza ha riguardato principalmente tre questioni: il completamento del Quadro Conoscitivo in tutte le sue parti, integrando quanto possibile gli apporti dei consulenti, oltre che cercando di tenere in dovuto conto le necessarie correzioni e completamenti indicatici durante la discussione della Bozza; la precisazione delle scelte di trasformazione, cercando di chiarirne sempre più la dimensione strutturale oltre che i loro contenuti startegici; infine, il progressivo affinamento della Valutazione di sostenibilità che tenta già di formulare alcuni giudizi preventivi circa le opzioni del Piano.
Tenendo sullo sfondo tali riflessioni, il Documento Preliminare cerca di precisare l’atteggiamento tenuto nei confronti di alcune importanti questioni, chiarendo così la struttura su cui poggia l’intero processo di definizione del Psc.
1. Conoscenza/progetto.
La struttura del lavoro sottende l’idea di un particolare rapporto fra conoscenza, indagine ed attività progettuale. Da un lato, le attività di analisi non rappresentano solamente una fase preliminare del lavoro, ma si sviluppano con una propria autonomia per l’intero percorso di costruzione del Piano Struttura. Dall’altro, l’attività di progettazione, considerata come una particolare forma di indagine, viene avviata fin dalla fase iniziale, contribuendo alla precisazione di temi e problemi e alla conoscenza dei diversi ambiti urbani.
2. Tempo del piano/tempo di trasformazione della città.
Questi due tempi sono stati considerati inscindibili e contestuali all’interno del processo di pianificazione. In questo senso abbiamo cercato di far interagire la formulazione del quadro d’insieme strutturale delle politiche urbane con la necessità di avviare
la progettazione di nodi problematici in alcuni "luoghi sensibili", oggetto di discussioni, in cui è possibile cogliere alcune specifiche "occasioni" di trasformazione urbana. Si è trattato di affrontare contemporaneamente differenti scale di progettazione, tra l’orizzonte generale di riferimento e le esigenze immediate e particolari, tra i tempi del progetto e quelli della trasformazione urbana, costruendo un quadro di coerenze possibili e indagando quali strumenti utilizzare, quali soggetti coinvolgere e quali procedure seguire.
3. Ambiente come questione trasversale.
La continua interazione tra uomo e ambiente, tra la vita di una comunità e il suo spazio, promuove l’integrazione disciplinare e si oppone alle settorialità entro cui si tende spesso a ridurre la questione ambiente. Per questa ragione abbiamo incrociato le riflessioni relative al funzionamento ambientale con quelle relative al funzionamento dei diversi sistemi territoriali, sovrapponendo le diverse conoscenze e i diversi saperi in modo da stabilire fra loro legami e relazioni virtuose. L’indagine relativa all’ambiente non è stata confinata, quindi, ad una specifica parte o scala del lavoro.
4. Area vasta tra descrizione e progetto.
Cercare di riconoscere il ruolo svolto da Ferrara in un contesto più ampio ha significato contemporaneamente interrogarsi su quale posto occupi nell’area padana, quali scenari sia possibile immaginare e quali siano le strategie necessarie al loro perseguimento.
Per questa ragione abbiamo affidato alla riflessione sull’area vasta il compito di creare un’interfaccia tra gli sforzi di descrizione e conoscenza della città e del territorio di Ferrara e le esplorazioni progettuali e di tenere costantemente in tensione descrizione e progetto, interpretazione ed immaginazione.
5. Ascolto e partecipazione come principio di lavoro.
L’ultima questione riguarda la partecipazione alla costruzione del piano della società locale che viene intesa come soggetto attivo con cui condividere continuamente interpretazioni e scelte entro un processo di pianificazione che si configura non tanto come un programma prestabilito di cui siano chiare fin dall’inizio tutti gli obiettivi, quanto piuttosto come un percorso che si articola durante le varie fasi di lavorazione.
2. Immagini
La necessità di accompagnare la redazione dei piani con attività di ascolto e partecipazione è ormai condivisa. La nuova legge urbanistica regionale richiede di concertare con le associazioni economiche e sociali gli obiettivi strategici e di sviluppo e garantire "la consultazione dei cittadini e delle associazioni in ordine ai contenuti degli strumenti (di pianificazione)".
La redazione del Psc è di Ferrara è segnata, fin dall’inizio, da alcune diverse attività di ascolto e partecipazione.
La "settimana dell’ambiente".
Consapevoli che a Ferrara relativamente alle questioni ambientali è maturato un sapere diffuso e radicato nella società locale, quale iniziale operazione di partecipazione, tra il 19 e il 22 giugno 2002, abbiamo incontrato le associazioni che si occupano di questo tema, organizzando al MusArc una "settimana dell’ambiente". Un ciclo di incontri operativi, nel corso del quale abbiamo cercato di delineare un’immagine condivisa dell’ambiente ferrarese, provando a chiarire quali sono i luoghi o i temi più problematici, e una prima "mappa dell’ambiente". Questa prima attività è stata seguita da un seminario pubblico, tenuto il 20 settembre 2002, nel corso del quale si è cercato da un lato di osservare come questi temi siano trattati oggi in altre esperienze di pianificazione e dall’altro di discutere alcuni specifici aspetti e problemi del territorio ferrarese.
Incontri bilaterali con le forze economiche. Immagini ed azioni.
Attraverso una serie d’incontri con le forze economiche locali (associazioni imprenditoriali e di categoria, sindacati, ecc.) invece, avendo come riferimento il Documento degli obiettivi, si è discusso della struttura socio-economica di Ferrara, provando a delineare alcune prime immagini della situazione attuale e cercando di definire alcuni possibili scenari e prime azioni per il futuro.
Passeggiate con le circoscrizioni.
La costruzione di una "carta dei beni comuni".
Successivamente, per riflettere in forma collettiva e condivisa intorno all’idea di bene comune, e a partire dall’idea che oggi sia indispensabile per il "tecnico" riconoscere e valorizzare la competenza degli abitanti riguardo al proprio ambiente di vita (conoscenza ordinaria, non professionale, non tecnica, ma "esperta" perché derivante dall’esperienza quotidianamente) abbiamo chiesto alle Circoscrizioni di fare delle passeggiate guidandoci alla "scoperta" dei luoghi e delle aree considerate "beni collettivi" della comunità. A partire da queste passeggiate stiamo costruendo una "mappa dei beni comuni", dei luoghi collettivi e che costituiscono base identitaria della società.
Forum Agenda 21. Confronto sulle proposizioni guida e il Poster Plan.
Quale ulteriore attività, abbiamo invitato il Forum di Agenda 21 Locale a discutere alcune prime ipotesi del Psc.
Sabato 9 novembre 2002 abbiamo presentato l’indice del piano e introdotto le ipotesi fondamentali che ne stanno alla base illustrando il "poster plan".
Sabato 23 novembre 2002 abbiamo invece lavorato in gruppi sulle varie "proposizioni guida". I diversi soggetti sociali hanno discusso con noi queste prime ipotesi del Psc, mirando in particolare ad alcuni obiettivi: articolarle e precisarle alla luce della propria esperienza; confrontarle e verificarle rispetto al piano d’azione di Agenda 21; eventualmente condividerle elaborando uno o più documenti.
Da queste giornate sono emerse diverse considerazioni ed un rapporto fatto di "cose da fare e cose da non fare".
Bozza del Documento Preliminare: una mostra e numerosi incontri.
Tra le attività di ascolto e partecipazione hanno assunto un ruolo importante gli incontri e le discussioni svolte durante la mostra della Bozza del Documento Preliminare.
Più di 1.000 persone in due mesi (la più alta affluenza da quando è stato aperto il MusArch), oltre 25 incontri con gruppi di cittadini, associazioni di categoria, ordini professionali: la sede del MusArch, dove erano esposti i lavori della Bozza del Documento Preliminare, per circa tre mesi ha assunto il ruolo di Urban Center, in cui settimanalmente si incontravano pezzi della società ferrarese a discutere delle coindizioni della città e del territorio e delle prospettive di trasformazione.
Nel loro insieme, queste diverse attività hanno posto in evidenza come in molti contesti (e tra questi sicuramente Ferrara), a proposito delle questioni urbane, territoriali e ambientali vi sia un sapere diffuso e radicato nella società locale. Un sapere che può costituire la base essenziale per attivare non solo sporadiche forme di partecipazione, ma un vero e proprio Urban Center inteso come un luogo stabile di confronto collettivo.
Le attività di analisi e progettazione, di ascolto e partecipazione, ci hanno proposto diverse interpretazioni di Ferrara.
L’incontro con i vari soggetti sociali ci ha permesso di definire alcune immagini della città, dei suoi caratteri fisici, sociali ed economici, tanto più utili quanto più ci consentono di mettere in relazione e riassumere i diversi aspetti della realtà, la complessità della situazione contemporanea in alcuni quadri sintetici ed immagini che cercano di cogliere i caratteri salienti di Ferrara.
1. Ferrara città della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico-ambientale.
Una prima immagine che Ferrara propone di sé può forse essere individuata nell’idea che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e ambientale debbano essere caratteristica centrale di ogni politica urbana. Questa prima immagine sembra essere talmente consolidata da poter dire che l’idea di "salvaguardare e valorizzare quel grande patrimonio di storia e d’arte che le generazioni passate ci hanno tramandato" possa diventare sempre più "patrimonio culturale di tutti i cittadini ferraresi". Si tratta di un’immagine nata da una lunga storia di ricerche e dibattiti che, se da un lato ha rischiato di distinguere troppo nettamente la città tra una parte "storica" da conservare e tutelare (la città murata) e una più ampia e indistinta parte "contemporanea", entro cui si individuano solo delle possibili "aree-risorsa", dall’altro deve dimostrare la capacità di rinnovarsi continuamente, portando ad una politica di tutela e valorizzazione sempre più ampia ed articolata, capace di guardare al futuro della città e non solo al suo passato.
2. Ferrara città friendly.
Un’altra immagine possibile è quella che vede Ferrara autoproporsi come "città verde", abitabile, friendly, città italiana di provincia che offre un buon ambiente di vita quotidiana, buona vivibilità del centro, la bellezza delle mura, la qualità del verde pubblico e una buona rete di piste ciclabili, ecc. Entro questa immagine, la qualità/abitabilità dello spazio urbano, associata alla presenza di vecchie e nuove funzioni culturali e di servizio (musei, università, ecc.) e al possibile sviluppo di attività economiche post-industriali ritenute compatibili con la salvaguardia del centro storico e dell’ambiente naturale, sembra una caratteristica peculiare attorno a cui prospettare una nuova stagione di "sviluppo sostenibile". Dal centro storico alle parti urbane esterne alle mura, questa immagine può rifondare una visione unitaria della città.
3. Ferrara città in trasformazione.
Una terza immagine può essere identificata nelle descrizioni di Ferrara che colgono la transizione da una struttura socio-economica legata alla prima industrializzazione ad una nuova modernità più composita ed equilibrata nella base produttiva legata ad un possibile sviluppo terziario e ad un’economia post-industriale. La città appare costituita da diverse parti: ciò che rischia di assumere la forma di un carattere composito ed eterogeneo attende da un lato un quadro di riferimento unitario e dall’altro il riconoscimento delle specifiche identità delle singole parti dotate di sufficiente complessità interna da non essere più considerate semplici appendici di un unico centro. Seguendo questa immagine, Ferrara oggi appare quasi come un cantiere, un composito aggregato urbano in trasformazione, soggetto a cambiamenti reali o solo ipotizzati ma comunque già chiaramente delineati: dal nuovo ospedale alla nuova "metropolitana", dai processi di riconversione del polo chimico all’"asse dei musei", dalla nuova sede dell’Eridania al progressivo sviluppo dei poli universitari. Accanto, e sovrapposta, alla tranquilla città di provincia, si trova cioè una dinamica città media che sta vivendo il passaggio da città industriale-moderna a città terziaria-postmoderna, e che sta prefigurando la sua nuova modernità, alla ricerca di un quadro di riferimento complessivo.
4. Ferrara composita città-territorio.
Sempre più spesso la natura di una città di essere "centro di servizi" si confronta con una dimensione vasta del territorio basata sulla mobilità ed accessibilità da un lato e dall’altro sulla concorrenzialità e complementarietà fra centri diversi. Questa visione impone sia uno sguardo sull’intero territorio comunale, per comprendere la natura dei fenomeni che riguardano le singole frazioni al fine della costruzione di un’armatura urbana più solida e strutturata, sia una valutazione della rete di relazioni che legano Ferrara alle altre realtà urbane. Lo scopo è comprendere il ruolo e le potenzialità delle nuove centralità emergenti, dalle concentrazioni commerciali alle nuove attrezzature, come le strutture ospedaliere, che svolgono un ruolo a scala metropolitana. Si può presumenre che si costituisca un’immagine di reticoli e costellazioni che metta a fuoco il funzionamento complesso dell’area vasta. Sembra possibile cogliere queste immagini, ma forse altre ancora potranno nascere osservando le trasformazioni urbane, i processi socio-economici, le auto-rappresentazioni proposte, non sempre in maniera esplicita, dai diversi soggetti sociali (studiosi e professionisti, enti, associazioni di categoria, gruppi sociali, ecc.).
Esse non sono ovviamente tra loro sempre in competizione o contraddizione reciproca, ma può essere utile riconoscere compatibilità e incompatibilità, possibili relazioni oltre che elementi d’inevitabile frizione. Si tratta di capire che queste immagini "parlano" dei diversi soggetti sociali che si muovono in città, delle loro rappresentazioni della realtà e soprattutto (per chi si accinge a definire un nuovo strumento urbanistico) delle loro aspettative ed aspirazioni, del futuro che cercano di costruire. Ogni nuovo strumento urbanistico si deve confrontare con questa stratificazione di immagini mentre cerca di delineare un progetto di nuovo assetto della città, che aspiri a sua volta a diventare parte dell’immaginario collettivo, ad essere non solo formalmente "adottato" ma anche diventare "patrimonio culturale di tutti i cittadini ferraresi".
3. Un atlante di Ferrara e del suo territorio
Oggi si riconosce un ruolo sempre più importante alla conoscenza e descrizione dei caratteri della città e del territorio, dei loro meccanismi di funzionamento, degli elementi di stabilità e resistenza alla trasformazione. Da un lato, i consistenti e pervasivi processi di cambiamento che hanno investito la città ed il territorio sembrano aver messo in luce l’inadeguatezza delle conoscenze accumulate nei decenni precedenti, rendendo necessarie nuove campagne di indagine, dall’altro, la sensibilità nei confronti delle questioni ambientali ha sospinto ad osservare con occhi nuovi gli stessi territori, mettendo in azione inediti strumenti d’analisi. Anche gli apparati legislativi hanno registrato queste sollecitazioni: un insieme di nuove leggi urbanistiche regionali, e tra queste la legge regionale n. 20/2000 dell’Emilia Romagna, sottolineano l’importanza del "quadro conoscitivo" all’interno dell’elaborazione dei nuovi strumenti urbanistici. L’attenzione posta sulla conoscenza come momento "fondativo" e "strutturale" e la contemporanea scomposizione in fasi temporali dello strumento di pianificazione (piano strutturale seguito da piani operativi) hanno indotto a pensare anche alla necessità di costruire apparati conoscitivi dinamici, continuamente aggiornabili e verificabili. La forte enfasi posta sulla possibilità di convogliare tutti gli sforzi di indagine e conoscenza entro un SIT (sistema informativo territoriale) nasce, anche, da queste premesse. In linea con questa tendenza, nel costruire l’apparato analitico-descrittivo ("quadro conoscitivo") si è cercato da un lato di predisporre un insieme di materiali che restituiscano descrizioni ed immagini del territorio di Ferrara immediatamente utilizzabili ed anche progressivamente aggiornabili, dall’altro di passare da un insieme di ricerche-indagini-analisi atte ad argomentare le scelte di piano, alla costruzione di una serie di immagini-descrizioni del territorio attorno a cui organizzare la discussione tra i soggetti che partecipano alla definizione, implementazione e gestione del piano. L’insieme di questi materiali possono anche essere opportunamente organizzati e gestiti attivando un nuovo centro di documentazione e confronto sulla città, un "Urban Center" che metta questo patrimonio a disposizione di tutti. Questo insieme di considerazioni ci ha portato a riconoscere la necessità di articolare la conoscenza e descrizione del territorio ferrarese muovendo da più punti di vista:dall’alto ma anche dall’interno, sguardi zenitali e "tecnici", ma anche sguardi dal basso costruiti assieme alla società locale, arrivando a comporre una sorta di atlante, un repertorio di carte e immagini che cerca di restituire la complessità del territorio, un apparato verbo-visivo che non pretende di "rispecchiare" la realtà, ma di illustrarne alcuni caratteri salienti evocandone anche funzionamento, tempi e modalità d’uso. Questo atlante è costituito da una sequenza di mappe, di "stratigrafie" che provano a smontare la complessità del territorio nominandone gli elementi, e da testi che non illustrano semplicemente le tavole, ma cercano di mettere a punto una riflessione sulla città, avanzando alcune ipotesi interpretative. In questo senso, testi ed immagini hanno anche una loro relativa autonomia. Abbiamo ordinato l’indagine conoscitiva in alcune parti riconducibili ad altrettante "geografie" funzionali, formali e temporali.
Geografie 1: come è fatta Ferrara
Osservandola "dall’alto", adottando un punto di vista quasi esterno alla città, l’attenzione viene catturata dalla morfologia degli insediamenti e del paesaggio.
Cercando di leggere e decifrare la forma della città e del territorio, la carta topografica diventa una sorta di "medium", una rappresentazione da scomporre a sua volta in diversi strati così da interrogarla su specifici temi e questioni come la forma di insediamenti, tracciati, acque, rilievi, ecc.
Differenti e specifiche forme di organizzazione del territorio possono essere evidenziate dalla lettura incrociata e dalle mutue relazioni di questi strati, più che dalla loro semplice sovrapposizione. Così, ad esempio, se incrociare la morfologia del suolo con il reticolo delle acque consente di chiarire il delicato equilibrio idraulico su cui si regge questo territorio, incrociare la trama stradale con i tessuti edificati e gli spazi aperti mostra quali differenti principi insediativi configurino Ferrara, quali parti, pezzi e frammenti compongano la città.
Dimensione
Il territorio  comunale di Ferrara si estende per 400 chilometri quadrati entro cui si riscontrano diversi tipi di strutture insediative e di paesaggi, testimonianze di usi ed economie differenti. La superficie comunale copre una così vasta parte di territorio da poter comprendere, per sommatoria, quelle di tre grandi capoluoghi come Torino, Bologna e Napoli.
Il ruolo di Ferrara di "città capitale" di un ampia provincia, che si estende al di là dei suoi confini amministrativi, legato a ragioni storico-geografiche dovute ai caratteri del territorio, ha contribuito a consolidare una gerarchia territoriale caratterizzata da ville, villaggi, e più raramente da paesi e piccole città. Alcune importanti autonomie locali, quali Argenta, Comacchio, Cento, Bondeno, Codigoro, Copparo etc., completano l’armatura urbana a scala estesa scandita da distanze rilevanti. In questa situazione il rapporto tra pieni e vuoti, tra città e campagna, ha assunto un significato assai diverso, quasi paradigmatico, rispetto al resto della regione e ad altre situazioni del nostro paese e sembra assurgere a valore da tutelare. L’attenuazione di queste differenze è, però, spesso considerato un rischio, perché può indurre la perdita di identità e riconoscibilità non solamente per Ferrara, ma anche per l’intero suo territorio. comunale di Ferrara si estende per 400 chilometri quadrati entro cui si riscontrano diversi tipi di strutture insediative e di paesaggi, testimonianze di usi ed economie differenti. La superficie comunale copre una così vasta parte di territorio da poter comprendere, per sommatoria, quelle di tre grandi capoluoghi come Torino, Bologna e Napoli.
Il ruolo di Ferrara di "città capitale" di un ampia provincia, che si estende al di là dei suoi confini amministrativi, legato a ragioni storico-geografiche dovute ai caratteri del territorio, ha contribuito a consolidare una gerarchia territoriale caratterizzata da ville, villaggi, e più raramente da paesi e piccole città. Alcune importanti autonomie locali, quali Argenta, Comacchio, Cento, Bondeno, Codigoro, Copparo etc., completano l’armatura urbana a scala estesa scandita da distanze rilevanti. In questa situazione il rapporto tra pieni e vuoti, tra città e campagna, ha assunto un significato assai diverso, quasi paradigmatico, rispetto al resto della regione e ad altre situazioni del nostro paese e sembra assurgere a valore da tutelare. L’attenuazione di queste differenze è, però, spesso considerato un rischio, perché può indurre la perdita di identità e riconoscibilità non solamente per Ferrara, ma anche per l’intero suo territorio.
Grana
All’interno del  vasto territorio comunale, gli insediamenti si caratterizzano per la loro relativa compattezza. I fenomeni di diffusione e dispersione insediativa sono relativamente ridotti, il paesaggio rurale, pur sottoposto a processi di trasformazione, si presenta ancora poco urbanizzato. Rispetto ad altre aree della valle padana, ad altri territori caratterizzati da un’industrializzazione e urbanizzazione diffusa, Ferrara presenta ancora insediamenti compatti e si differenzia dal modello insediativo che ha connotato la via Emilia, la costa adriatica, molte parti del Veneto e del nord-est più in generale. Alla porosità dei territori della dispersione, Ferrara oppone un’alternanza tra pieni e vuoti, tra spazi urbani e rurali, tra parti più che tra singoli elementi, singoli edifici e singoli appezzamenti di campagna. La grana che caratterizza il territorio ferrarese definisce, così, una geografia di punti di contatto e di attrito, un reticolo di aree e superfici di confine, di ambienti di transizione che risultano di grande importanza per il funzionamento ecologico del territorio e che pongono specifici problemi di compatibilità ed incompatibilità. vasto territorio comunale, gli insediamenti si caratterizzano per la loro relativa compattezza. I fenomeni di diffusione e dispersione insediativa sono relativamente ridotti, il paesaggio rurale, pur sottoposto a processi di trasformazione, si presenta ancora poco urbanizzato. Rispetto ad altre aree della valle padana, ad altri territori caratterizzati da un’industrializzazione e urbanizzazione diffusa, Ferrara presenta ancora insediamenti compatti e si differenzia dal modello insediativo che ha connotato la via Emilia, la costa adriatica, molte parti del Veneto e del nord-est più in generale. Alla porosità dei territori della dispersione, Ferrara oppone un’alternanza tra pieni e vuoti, tra spazi urbani e rurali, tra parti più che tra singoli elementi, singoli edifici e singoli appezzamenti di campagna. La grana che caratterizza il territorio ferrarese definisce, così, una geografia di punti di contatto e di attrito, un reticolo di aree e superfici di confine, di ambienti di transizione che risultano di grande importanza per il funzionamento ecologico del territorio e che pongono specifici problemi di compatibilità ed incompatibilità.
Un territorio da leggere in Braille. Altimetria
Il territorio di Ferrara è 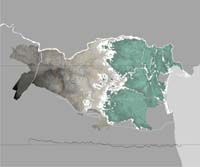 assai difficile da rappresentare. A prima vista la sua morfologia sembra piatta e priva di qualità paesaggistiche, ma, come suggerisce Moreno Po, il ferrarese "va letto in Braille, toccato con le mani, perché é sottile… puoi solo toccarlo, non lo puoi capire immediatamente, non lo riesci a cogliere attraverso rappresentazioni tradizionali".
Una lettura attenta, sostenuta dal sapere di geologi, idrogeologi e storici del paesaggio, rivela un territorio ricco di forme, costruito su una trama di paleoalvei, su cui l’uomo ha sovrapposto, nel tempo, diverse modalità di funzionamento del sistema idraulico, modificando il reticolo delle acque in base alle diverse esigenze e modelli di sviluppo. Questa pianura fortemente manufatta richiede, per essere letta, di decifrarne la geomorfologia, di ricostruirne le trasformazioni idrauliche, la cui storia si intreccia e sovrappone con quella dei conflitti tra poteri: trattenere l’acqua per l’irrigazione e contemporaneamente mantenere asciutti i terreni, consentire la navigazione dei fiumi e proteggere le città dalle piene sono tra le principali questioni attorno a cui si è costruito questo territorio che svela la sua natura di straordinario supporto "storicamente determinato".
Se, a prima vista, il territorio appare interamente pianeggiante, in realtà, è un piano corrugato, ricco di "valli" e "crinali", articolato in "terre alte" e "terre basse", una sorta di telo non perfettamente teso nel quale proprio le scarse pendenze in gioco, per lo più inferiori allo 0,5
per mille, costituiscono un grosso ostacolo allo smaltimento delle acque meteoriche. Nonostante Ferrara disti più di 40 chilometri dal mare, una parte del suo territorio comunale, così come la metà dell’intero territorio provinciale, è collocata al di sotto del livello del mare. Per questa ragione, lo scolo delle acque necessita in tutta la provincia ferrarese del lavoro di settantacinque impianti idrovori, di cui tredici nel solo territorio comunale di Ferrara. La pendenza generale del territorio verso est e la condizione di pensilità dei fiumi attuali e dei paleoalvei principali, assieme ad altre strutture (talora artificiali), suddividono il territorio in vari comparti altimetrici di forma concava, i quali presentano spesso difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche. Significativa è la generale differenza di quota dell’area situata a ovest del paleoalveo del Po di Primaro, che risulta mediamente più alta di quella a est in quanto soggetta alle alluvioni del Reno, e fino al XVIII secolo alle relative bonifiche per colmata, nei cui confronti il suddetto paleoalveo esercitava una funzione di sbarramento. Piccole pendenze e dislivelli di pochi metri, a volte di frazioni di metro, costituiscono differenze sostanziali in questo delicato equilibrio idraulico, tanto da avere fortemente condizionato la localizzazione degli insediamenti urbani che si sono concentrati lungo gli argini dei fiumi ancora esistenti o ormai scomparsi, la cui altimetria garantiva un sicuro riparo dalle acque. assai difficile da rappresentare. A prima vista la sua morfologia sembra piatta e priva di qualità paesaggistiche, ma, come suggerisce Moreno Po, il ferrarese "va letto in Braille, toccato con le mani, perché é sottile… puoi solo toccarlo, non lo puoi capire immediatamente, non lo riesci a cogliere attraverso rappresentazioni tradizionali".
Una lettura attenta, sostenuta dal sapere di geologi, idrogeologi e storici del paesaggio, rivela un territorio ricco di forme, costruito su una trama di paleoalvei, su cui l’uomo ha sovrapposto, nel tempo, diverse modalità di funzionamento del sistema idraulico, modificando il reticolo delle acque in base alle diverse esigenze e modelli di sviluppo. Questa pianura fortemente manufatta richiede, per essere letta, di decifrarne la geomorfologia, di ricostruirne le trasformazioni idrauliche, la cui storia si intreccia e sovrappone con quella dei conflitti tra poteri: trattenere l’acqua per l’irrigazione e contemporaneamente mantenere asciutti i terreni, consentire la navigazione dei fiumi e proteggere le città dalle piene sono tra le principali questioni attorno a cui si è costruito questo territorio che svela la sua natura di straordinario supporto "storicamente determinato".
Se, a prima vista, il territorio appare interamente pianeggiante, in realtà, è un piano corrugato, ricco di "valli" e "crinali", articolato in "terre alte" e "terre basse", una sorta di telo non perfettamente teso nel quale proprio le scarse pendenze in gioco, per lo più inferiori allo 0,5
per mille, costituiscono un grosso ostacolo allo smaltimento delle acque meteoriche. Nonostante Ferrara disti più di 40 chilometri dal mare, una parte del suo territorio comunale, così come la metà dell’intero territorio provinciale, è collocata al di sotto del livello del mare. Per questa ragione, lo scolo delle acque necessita in tutta la provincia ferrarese del lavoro di settantacinque impianti idrovori, di cui tredici nel solo territorio comunale di Ferrara. La pendenza generale del territorio verso est e la condizione di pensilità dei fiumi attuali e dei paleoalvei principali, assieme ad altre strutture (talora artificiali), suddividono il territorio in vari comparti altimetrici di forma concava, i quali presentano spesso difficoltà di drenaggio delle acque meteoriche. Significativa è la generale differenza di quota dell’area situata a ovest del paleoalveo del Po di Primaro, che risulta mediamente più alta di quella a est in quanto soggetta alle alluvioni del Reno, e fino al XVIII secolo alle relative bonifiche per colmata, nei cui confronti il suddetto paleoalveo esercitava una funzione di sbarramento. Piccole pendenze e dislivelli di pochi metri, a volte di frazioni di metro, costituiscono differenze sostanziali in questo delicato equilibrio idraulico, tanto da avere fortemente condizionato la localizzazione degli insediamenti urbani che si sono concentrati lungo gli argini dei fiumi ancora esistenti o ormai scomparsi, la cui altimetria garantiva un sicuro riparo dalle acque.
Un territorio da leggere in Braille. Idrografia
A questa morfologia  fortemente esclusiva corrisponde una precisa geografia insediativa che, ancora oggi, privilegia questi lievissimi rilievi, su cui centri, nuclei e case sparse si stabiliscono, quasi fossero crinali di un paesaggio collinare. Anche il reticolo delle strade di collegamento tra i centri privilegia i paleoalvei o i dossi dei fiumi attivi, costituendo anche un’importante rete di emergenza in caso di allagamenti. D’altro canto, questi sono anche gli unici terreni che si prestavano alla coltivazione dei cereali e della vite: i dossi che d’estate emergevano dalle valli producevano fieno molto apprezzato, così come le dune sabbiose verso il mare erano coltivate a bosco o a vigna. Tutto il resto del territorio è esito di ingenti investimenti e di diverse tecnologie che, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del 1800, hanno permesso la progressiva bonifica delle terre più basse, comprese le valli che per molto tempo lo hanno caratterizzato.
Tutto ciò ci consente di affermare che, l’acqua ha svolto e continua a svolgere un ruolo rilevante nei confronti del territorio e del paesaggio anche quando, come nel caso delle aree di bonifica o dei paleoalvei, il tempo o l’azione dell’uomo ne ha quasi negata e cancellata la presenza. Ciò fa si che molti degli elementi che caratterizzano questo paesaggio siano, quindi, fortemente legati all’acqua: rilievi, dossi, paleoalvei e arginature da un lato, localizzazione dei centri abitati, forma dei campi e vegetazione dall’altro. fortemente esclusiva corrisponde una precisa geografia insediativa che, ancora oggi, privilegia questi lievissimi rilievi, su cui centri, nuclei e case sparse si stabiliscono, quasi fossero crinali di un paesaggio collinare. Anche il reticolo delle strade di collegamento tra i centri privilegia i paleoalvei o i dossi dei fiumi attivi, costituendo anche un’importante rete di emergenza in caso di allagamenti. D’altro canto, questi sono anche gli unici terreni che si prestavano alla coltivazione dei cereali e della vite: i dossi che d’estate emergevano dalle valli producevano fieno molto apprezzato, così come le dune sabbiose verso il mare erano coltivate a bosco o a vigna. Tutto il resto del territorio è esito di ingenti investimenti e di diverse tecnologie che, soprattutto a partire dagli ultimi decenni del 1800, hanno permesso la progressiva bonifica delle terre più basse, comprese le valli che per molto tempo lo hanno caratterizzato.
Tutto ciò ci consente di affermare che, l’acqua ha svolto e continua a svolgere un ruolo rilevante nei confronti del territorio e del paesaggio anche quando, come nel caso delle aree di bonifica o dei paleoalvei, il tempo o l’azione dell’uomo ne ha quasi negata e cancellata la presenza. Ciò fa si che molti degli elementi che caratterizzano questo paesaggio siano, quindi, fortemente legati all’acqua: rilievi, dossi, paleoalvei e arginature da un lato, localizzazione dei centri abitati, forma dei campi e vegetazione dall’altro.
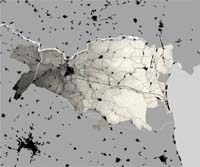 |
Un territorio da leggere in Braille. Insediamenti |
Materiali del paesaggio.
La vegetazione
A far apparire "rugosa" la superficie del territorio di Ferrara contribuisce, anche, la presenza della sua vegetazione. Non si tratta di grandi boschi, di grandi masse alberate, ma piuttosto di filari di platani lungo le principali strade storiche, di boschi ripariali lungo i corsi dei fiumi, di pioppeti e frutteti, di sequenze di salici bianchi e siepi lungo alcuni canali, ed infine di grandi alberi sparsi. La vegetazione, come i movimenti del suolo, ha un carattere discreto, esercita un’attenta selezione dei luoghi, articola il territorio in diversi paesaggi:
-il paesaggio del Po, alcuni residui di bosco ripario (di cui il bosco di Porporana costituisce forse l’esempio più rilevante), caratterizzati da una copertura arborea composita a farnie, carpini bianchi, olmi, pioppi bianchi, pioppi neri e salici bianchi, caratteristici della foresta planiziale padana, ma anche da numerosi pioppeti golenali d’impianto, che in parte hanno sostituito l’originaria vegetazione, e dalle scarpate erbose dei grandi argini che segnano l’orizzonte come una maestosa opera di land art.
-Il paesaggio e i manufatti delle bonifiche che, attraverso i secoli, hanno quasi interamente ridisegnato il quadro ambientale del territorio ferrarese, dilatando gli spazi e definendo un paesaggio artificiale ed artefatto nel quale prevale l’uniformità di vasti spazi, apparentemente livellati, di grandi campi aperti, quasi privi di alberature, di abitazioni e di veri centri abitati. I principali elementi paesaggistici sono i canali, gli argini, le scoline ed infine le idrovore. La consistente presenza di acqua e di umidità fa si che, tra gli elementi fondamentali di questo paesaggio, vada considerata anche la nebbia.
-Il paesaggio delle "terre vecchie" disegnato da canali sinuosi come il Primaro o il Volano bordati da canne di palude, da pioppi neri e salici bianchi, da coltivi di proporzioni contenute e da antiche residenze padronali, case coloniche, pievi isolate e piccoli nuclei edilizi. Le "terre vecchie" solitamente sono caratterizzate da un’agricoltura intensiva, dove i campi rettangolari sono ancora a volte intervallati da filari di alberi, da carrarecce e capezzagne.
Oltre a questi ambiti, si possono nominare i diversi elementi della vegetazione che vegetazione. Non si tratta di grandi boschi, di grandi masse alberate, ma piuttosto di filari di platani lungo le principali strade storiche, di boschi ripariali lungo i corsi dei fiumi, di pioppeti e frutteti, di sequenze di salici bianchi e siepi lungo alcuni canali, ed infine di grandi alberi sparsi. La vegetazione, come i movimenti del suolo, ha un carattere discreto, esercita un’attenta selezione dei luoghi, articola il territorio in diversi paesaggi:
-il paesaggio del Po, alcuni residui di bosco ripario (di cui il bosco di Porporana costituisce forse l’esempio più rilevante), caratterizzati da una copertura arborea composita a farnie, carpini bianchi, olmi, pioppi bianchi, pioppi neri e salici bianchi, caratteristici della foresta planiziale padana, ma anche da numerosi pioppeti golenali d’impianto, che in parte hanno sostituito l’originaria vegetazione, e dalle scarpate erbose dei grandi argini che segnano l’orizzonte come una maestosa opera di land art.
-Il paesaggio e i manufatti delle bonifiche che, attraverso i secoli, hanno quasi interamente ridisegnato il quadro ambientale del territorio ferrarese, dilatando gli spazi e definendo un paesaggio artificiale ed artefatto nel quale prevale l’uniformità di vasti spazi, apparentemente livellati, di grandi campi aperti, quasi privi di alberature, di abitazioni e di veri centri abitati. I principali elementi paesaggistici sono i canali, gli argini, le scoline ed infine le idrovore. La consistente presenza di acqua e di umidità fa si che, tra gli elementi fondamentali di questo paesaggio, vada considerata anche la nebbia.
-Il paesaggio delle "terre vecchie" disegnato da canali sinuosi come il Primaro o il Volano bordati da canne di palude, da pioppi neri e salici bianchi, da coltivi di proporzioni contenute e da antiche residenze padronali, case coloniche, pievi isolate e piccoli nuclei edilizi. Le "terre vecchie" solitamente sono caratterizzate da un’agricoltura intensiva, dove i campi rettangolari sono ancora a volte intervallati da filari di alberi, da carrarecce e capezzagne.
Oltre a questi ambiti, si possono nominare i diversi elementi della vegetazione che  compongono questo specifico paesaggio: pioppeti, filari di platani lungo le strade, vegetazione ripariale, radi filari di pioppi italici lungo i bordi di alcuni campi, qualche albero isolato, ecc.
Questa prima mappatura dei materiali del paesaggio ferrarese, ci ha consentito di riconoscere alcune "figure", alcune
principali forme che, per la loro forza espressiva, per la loro stabilità, la stretta relazione che intrattengono con le condizioni geomorfologiche del suolo o anche per l’importante ruolo pubblico-collettivo, possano essere considerate "strutturali": la vegetazione ripariale e i pioppeti concentrati soprattutto lungo il Po, le grandi strade extraurbane alberate che, sorta di "gallerie verdi", connotano soprattutto la parte orientale del territorio comunale, la rete del verde urbano molto articolato al suo interno, ma sistema unitario se considerato nell’insieme del paesaggio ferrarese, i diversi elementi eccezionali sparsi brevi filari di pioppi italici, grandi alberi isolati, ecc. che, se pur non molto frequenti, si stagliano sull’orizzonte contribuendo a definire le linee di fuga dello sguardo, a "misurare" uno spazio altrimenti dominato dalle sole ondulazioni del suolo (alvei e paleoalvei, dossi e catini interfluviali, terrapieni e ventagli di rotta).
Inoltre, è stata avviata una più approfondita indagine conoscitiva dei materiali del paesaggio selezionando alcune aree campione significative della pluralità di situazioni insediative ed ambientali che caratterizzano il territorio di Ferrara.
Attraverso un rilievo diretto, non più mediato dalla cartografia o dalle foto aree, si vuole pervenire ad una descrizione più precisa e attenta dei materiali dello spazio aperto, delle loro relazioni e del loro ruolo ecologico-ambientale. compongono questo specifico paesaggio: pioppeti, filari di platani lungo le strade, vegetazione ripariale, radi filari di pioppi italici lungo i bordi di alcuni campi, qualche albero isolato, ecc.
Questa prima mappatura dei materiali del paesaggio ferrarese, ci ha consentito di riconoscere alcune "figure", alcune
principali forme che, per la loro forza espressiva, per la loro stabilità, la stretta relazione che intrattengono con le condizioni geomorfologiche del suolo o anche per l’importante ruolo pubblico-collettivo, possano essere considerate "strutturali": la vegetazione ripariale e i pioppeti concentrati soprattutto lungo il Po, le grandi strade extraurbane alberate che, sorta di "gallerie verdi", connotano soprattutto la parte orientale del territorio comunale, la rete del verde urbano molto articolato al suo interno, ma sistema unitario se considerato nell’insieme del paesaggio ferrarese, i diversi elementi eccezionali sparsi brevi filari di pioppi italici, grandi alberi isolati, ecc. che, se pur non molto frequenti, si stagliano sull’orizzonte contribuendo a definire le linee di fuga dello sguardo, a "misurare" uno spazio altrimenti dominato dalle sole ondulazioni del suolo (alvei e paleoalvei, dossi e catini interfluviali, terrapieni e ventagli di rotta).
Inoltre, è stata avviata una più approfondita indagine conoscitiva dei materiali del paesaggio selezionando alcune aree campione significative della pluralità di situazioni insediative ed ambientali che caratterizzano il territorio di Ferrara.
Attraverso un rilievo diretto, non più mediato dalla cartografia o dalle foto aree, si vuole pervenire ad una descrizione più precisa e attenta dei materiali dello spazio aperto, delle loro relazioni e del loro ruolo ecologico-ambientale.
Materiali del paesaggio. L’acqua
principali forme che, per la loro forza espressiva, per la loro stabilità, la stretta relazione che intrattengono con le condizioni geomorfologiche del suolo o anche per l’importante ruolo pubblico-collettivo, possano essere considerate "strutturali": la vegetazione ripariale e i pioppeti concentrati soprattutto lungo il Po, le grandi strade extraurbane alberate che, sorta di "gallerie verdi", connotano soprattutto la parte orientale del territorio comunale, la rete del verde urbano molto articolato al suo interno, ma sistema unitario se considerato nell’insieme del paesaggio ferrarese, i diversi elementi eccezionali sparsi brevi filari di pioppi italici, grandi alberi isolati, ecc. che, se pur non molto frequenti, si stagliano sull’orizzonte contribuendo a definire le linee di fuga dello sguardo, a "misurare" uno spazio altrimenti dominato dalle sole ondulazioni del suolo (alvei e paleoalvei, dossi e catini interfluviali, terrapieni e ventagli di rotta).
Inoltre, è stata avviata una più approfondita indagine conoscitiva dei materiali del paesaggio selezionando alcune aree campione significative della pluralità di situazioni insediative ed ambientali che caratterizzano il territorio di Ferrara.
Attraverso un rilievo diretto, non più mediato dalla cartografia o dalle foto aree, si vuole pervenire ad una descrizione più precisa e attenta dei materiali dello spazio aperto, delle loro relazioni e del loro ruolo ecologico-ambientale.
Strutture del paesaggio
L’ambiente ferrarese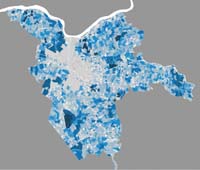 è fortemente caratterizzato dal mondo agricolo: qui il paesaggio (eccettuando forse solo le lievi increspature altimetriche del suolo, le alberature stradali e la residua vegetazione riparia presente tra l’altro solo nei corsi d’acqua principali) coincide quasi esclusivamente con le forme dettate dall’uso agricolo del suolo. Volendo prestare attenzione alle qualità ambientali e paesaggistiche dello spazio aperto, diventa allora ancora più necessario osservare con attenzione il sistema produttivo agricolo, cercando di metterne in evidenza gli elementi strutturali (stabili, che cambiano lentamente) e però anche, al contempo, i recenti processi di trasformazione che stanno modificando radicalmentela struttura economica (scomparsa delle piccole aziende) ed il paesaggio percepito (riduzione della superficie a frutteto).
Le imprese. In base ai dati del quinto censimento generale dell’agricoltura del 2000, nel comune di Ferrara sono presenti 2.107 aziende agricole (il 20 % delle 10.935 aziende censite in Provincia).
Tra il 1970 e il 2000, l’elemento più rilevante è costituito dalla riduzione del numero di aziende che da 3.287 si sono ridotte a 2.107, con una diminuzione pari a circa il 36%. Nel 2000 la superficie agricola totale in comune di Ferrara ha raggiunto i 32.000 ettari, risultato di una progressiva diminuzione che dal 1970 al 2000 ha portato praticamente alla scomparsa di 1.286 ettari di territorio agricolo. è fortemente caratterizzato dal mondo agricolo: qui il paesaggio (eccettuando forse solo le lievi increspature altimetriche del suolo, le alberature stradali e la residua vegetazione riparia presente tra l’altro solo nei corsi d’acqua principali) coincide quasi esclusivamente con le forme dettate dall’uso agricolo del suolo. Volendo prestare attenzione alle qualità ambientali e paesaggistiche dello spazio aperto, diventa allora ancora più necessario osservare con attenzione il sistema produttivo agricolo, cercando di metterne in evidenza gli elementi strutturali (stabili, che cambiano lentamente) e però anche, al contempo, i recenti processi di trasformazione che stanno modificando radicalmentela struttura economica (scomparsa delle piccole aziende) ed il paesaggio percepito (riduzione della superficie a frutteto).
Le imprese. In base ai dati del quinto censimento generale dell’agricoltura del 2000, nel comune di Ferrara sono presenti 2.107 aziende agricole (il 20 % delle 10.935 aziende censite in Provincia).
Tra il 1970 e il 2000, l’elemento più rilevante è costituito dalla riduzione del numero di aziende che da 3.287 si sono ridotte a 2.107, con una diminuzione pari a circa il 36%. Nel 2000 la superficie agricola totale in comune di Ferrara ha raggiunto i 32.000 ettari, risultato di una progressiva diminuzione che dal 1970 al 2000 ha portato praticamente alla scomparsa di 1.286 ettari di territorio agricolo.
Paesaggio e struttura agraria
|
Colture |
Superficie coltivata (ha) |
% sup. coltivata sul totale |
| |
1982 |
1990 |
2000 |
1982 |
1990 |
2000 |
|
Cerealicole |
10836 |
10948 |
12338 |
33,3 |
33,3 |
38,5 |
|
Ortive |
1003 |
727 |
247 |
3 |
2,3 |
0,8 |
|
Foraggere |
1260 |
934 |
1415 |
3,9 |
2,8 |
4,4 |
|
Industriali |
5671 |
7598 |
8093 |
17,5 |
23 |
25,3 |
|
Totale seminative |
18.770 |
20.261 |
22.093 |
57,7 |
61,4 |
69 |
|
Frutticole (melo, pero, pesco) |
9009 |
8861 |
5720 |
27,7 |
26,8 |
17,9 |
|
Altre frutticole (altra frutta, vite) |
597 |
194 |
487 |
1,8 |
0,6 |
1,5 |
|
Totale frutticole |
9.606 |
9.055 |
6.207 |
29,5 |
27,4 |
19,4 |
|
Tot. sup. agr. utilizzata |
28.376 |
29.316 |
28.300 |
87,2 |
88,8 |
88,4 |
|
Boschi e pioppeti |
494 |
298 |
226 |
1,5 |
0,9 |
0,7 |
|
Tare |
3660 |
3405 |
3474 |
11,3 |
10,3 |
10,9 |
|
Totale |
4.154 |
3.703 |
3.700 |
100 |
100 |
100 |
Colture agricole. Comune di Ferrara: 1982-1990-2000
|
Classi di sup. (ha) |
Numero aziende |
Superficie (ha) |
| |
1982 |
2000 |
1982 |
2000 |
1982 |
2000 |
1982 |
2000 |
|
< 1,99 |
676 |
390 |
22,7 |
18,5 |
588 |
355 |
1,8 |
1,1 |
|
2,00 - 4,99 |
708 |
468 |
23,8 |
22,3 |
2.392 |
1.625 |
7,4 |
5 |
|
5,00 - 9,99 |
679 |
500 |
22,9 |
23,7 |
4.808 |
3.553 |
14,8 |
11,2 |
|
10,00 - 19,99 |
513 |
401 |
17,3 |
19 |
7.148 |
5.966 |
22 |
18,7 |
|
> 20,00 |
394 |
348 |
13,3 |
16,5 |
17.568 |
20.501 |
54 |
64 |
|
Totale |
2.970 |
2.107 |
100 |
100 |
32.504 |
32.000 |
100 |
100 |
Numero di aziende agricole e relativa superficie per classi dimensionali. Comune di Ferrara: 1982-2000
Alla luce dei dati fino ad ora esaminati emerge che i cambiamenti strutturali avvenuti (diminuzione del numero di aziende accompagnata da una leggera perdita della superficie totale) indicano fenomeni di accorpamento e ristrutturazione aziendale. La dinamica evolutiva dell’ultimo trentennio ha generato infatti soprattutto una diminuzione del numero di aziende comprese tra gli 1 ed i 10 ettari e per contro l’aumento di quelle di maggiore dimensione.
Il lavoro. Gli occupati in agricoltura in comune di Ferrara risultano oggi 3.563 a fronte di una popolazione attiva complessiva pari a 36.196 persone. Questo dato considerato in assoluto può apparire poco rilevante, ma se raffrontato al dato medio regionale (8,6%) e nazionale (8,2%), testimonia una precisa vocazione agricola del Comune di Ferrara rispetto ad altre aree del Paese.
In merito al tema occupazionale è opportuno inoltre sottolineare due aspetti: il primo è costituito dal part-time e l’altro invece l’invecchiamento della manodopera familiare. Osservando i dati in nostro possesso, relativi alle giornate di lavoro prestato in agricoltura dalla popolazione attiva dal 1982 al 2000, si assiste ad un calo molto evidente non solo della manodopera del conduttore (-31,5%) e dei suoi familiari (-47,4 %) ma anche della manodopera fissa (-78 %), ed avventizia (-85 %).
L’uso del suolo.
La superficie aziendale totale nel comune di Ferrara ammonta a 32.000 ettari complessivi. Di questi, circa l’88,5 % (28.300 ettari) costituiscono la superficie agricola effettivamente utilizzata (la SAU) mentre i rimanenti 3.700 ettari compongono "la tara" (terreni delle aziende agricole ma occupati da fabbricati, cortili, strade poderali, ecc). Le colture più diffuse sono i costituite dai cereali, con una quota pari al 38,5 %, le colture industriali (bietola, soia, girasole) con il 25,3 % e i fruttiferi con il 17,9 %. Tra i seminativi domina il granturco con il 28,3 % della SAU (pari a 8.019 etari) seguito dalla soia con l’12,7% della SAU (3.584 ettari) e dalla barbabietola da zucchero con il 10,5 % della SAU (pari a 2.977 ettari). Il frumento tenero si attesta intorno al 7,9% della SAU (2.240 ettari), mentre il frumento duro rappresenta il 5,8 % della SAU (pari a 1.638 ettari). Molto importanti per l’agricoltura di questo comune sono infine i frutteti che, seppur colpiti da una forte riduzione, coprono ancora il 22% della SAU (6.207 ettari), ed infine le foraggere con il 5% della SAU (1.415 ettari). Questa situazione ovviamente non è rimasta immutata nel tempo. In particolare, nell’ultimo ventennio si è assistito ad una forte riduzione delle frutticole (melo, pero, pesco) che dal 27,7 % del 1982 sono passati al 26,8 % del 1990 e quindi al 17,9 % del 2000. Le colture industriali invece nello stesso periodo aumentano la loro presenza, passando dal 17,5 % del 1982 al 23,0 % del 1990 e quindi al 25,3 % del 2000. Con molta probabilità, l’aumento di queste colture industriali (soprattutto soia e girasole) è da imputare alle compensazioni dei prezzi previsti dalla politica agricola comunitaria (Pac). Andamento diverso hanno avuto invece i cereali, che nel periodo 1982 – 1990 non hanno subito alcuna variazione di superficie mentre solo nel decennio 1990 – 2000 hanno registrato un incremento di superficie passando dal 33,2% del 1990 al 38,5 % della superficie totale nel 2000. Anche in questo caso l’incremento della superficie a cereali (soprattutto frumento duro e mais) è da imputare con molta probabilità alle compensazioni dei prezzi previsti dalla Politica agricola comunitaria.

Carta Pedologica
Il settore zootecnico. Negli ultimi anni il comparto zootecnico ha mostrato alcuni segnali di crisi (specie nel settore bovino) legati principalmente all’applicazione della politica agricola comunitaria, all’aumento dei costi di produzione nonché alla concorrenza degli altri paesi europei. Si è registrato un calo in tutti i settori zootecnici sia in termini di numero di aziende che in termini di capi allevati, arrivando all’attuale presenza di sole 27 aziende zootecniche che allevano bovini, per un totale di 1.642 capi (di cui 592 vacche da latte). Nel periodo 1982 - 2000, si è registrato un calo drastico sia del numero di aziende (-82,5%) che del numero di capi totali (-77 %). La medesima sorte è toccata al comparto suinicolo: in questo caso il calo del numero di aziende è stato ancora più drastico (-89,5%) mentre il calo del numero di capi è stato più contenuto (-61%). Un calo particolare ha colpito inoltre il settore avicolo, rappresentato oggi da 7.144 capi distribuiti su 311 aziende ripartiti tra polli da carne e galline ovaiole, per una media di circa 23 capi/azienda: quest’ultimo dato chiarisce che siamo di fronte a piccoli allevamenti finalizzati all’autoconsumo famigliare. Proprio questi compositi caratteri della struttura agricolo, e soprattutto le sue recenti trasformazioni, ci stanno spingendo a compiere ulteriori indagini. In particolare, riconoscendo nel frutteto (e nelle colture arboree in genere) un elemento fortemente caratterizzante il paesaggio ferrarese, attraverso un confronto tra la carta tecniche regionale redatta alla fine degli anni settanta, l’ortofotocarta a colori del 1998 ed infine un rilievo diretto sul campo, stiamo esaminando la consistenza delle colture arboree, riflettendo sulla loro drastica diminuzione. Ovviamente un piano urbanistico non può (soprattutto da solo) invertire tendenze economico-produttive che trovano ragione in più ampi processi sovracomunali. Può e deve però portare a riconoscere l’insostituibile ruolo del mondo agricolo nella costruzione di un "bel paesaggio", di quel ambiente che può diventare risorsa per tutta la comunità.
Morfologia del costruito
Osservando più da  vicino la struttura insediativa di Ferrara, gli spazi e i luoghi di cui è fatta, le modalità di aggregazione dello spazio aperto, dello spazio costruito e le loro relazioni con le strade, possiamo riconoscerne l’articolazione in alcuni diverse parti, tessuti e frammenti. E’ possibile leggere regolarità ed irregolarità, somiglianze e differenze tra i diversi tessuti insediativi attraverso un’analisi non esclusivamente tipologica, ma capace di considerare una pluralità di aspetti: il rapporto tra edificio e strada, il principio insediativo, la densità edilizia, le configurazioni della rete stradale, il trattamento degli spazi aperti, l’altezza degli edifici, ecc... Risulta evidente che, il riconoscimento di alcune "specie di spazi", come suggerisce Georges Perec, costituisce un’operazione di semplificazione della realtà: anche universi di oggetti e di spazi complessi possono, in fondo, essere ricondotti ad alcuni tipi prevalenti, ad un numero limitato di forme e, a loro volta, ciascuna di queste forme può essere descritta nominando un numero limitato di regole e caratteri. E’ evidente che osservare e descrivere Ferrara, prestando attenzione ai suoi caratteri morfologici, diventa tanto più importante oggi se pensiamo che una quota rilevante degli interventi futuri possa riguardare le parti già edificate, se consideriamo che un ruolo importante per la gestione delle trasformazioni urbane, soprattutto attraverso il nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio, sia affidato alle regole d’intervento nei tessuti "consolidati", che dovranno interpretare correttamente i caratteri di questo specifico paesaggio urbano riconoscendone i diversi elementi costitutivi. Un’indagine di questo tipo restituisce un’immagine di Ferrara composita, eterogenea e molteplice, in cui, agli isolati compatti del centro medievale, si affiancano il tessuto più poroso dell’Addizione Erculea, il quartiere Arianuova, l’intervento Ina-Casa di viale XXV Aprile e il rione Giardino, parti di "città pubblica" caratterizzati dalla ripetizione di alcuni tipi edilizi, principalmente edifici in linea anche di una certa consistenza, e da vasti spazi aperti, brani di case a schiera con giardino privato, gruppi di palazzine caratterizzati da alta densità ed, infine, sequenze di case minime lungo strada. Tra tutti questi diversi pezzi, a volte resti del processo di selezione prodotto dal tempo, altre volte ritagli di progetti più ambiziosi, altre ancora frammenti di un’intenzionalità speculativa, si insinuano gruppi di case isolate su lotto organizzate in tessuti dai tracciati più o meno regolari e caratterizzati da spazi aperti prevalentemente privati o condominiali. Questa molteplicità di parti, ciascuna chiaramente riconoscibile nella sua configurazione spaziale, possiede, però, una diversa capacità di organizzare la città, contribuendo solo in alcuni casi a definirne la struttura, a garantirne un corretto funzionamento e una sufficiente dotazione di servizi. Ad esempio, alcuni grandi quartieri di edilizia pubblica, come i quartieri di
via Krasnodar a sud o del Barco a nord, si distinguono dalla sequnza individualistica di casette e palazzine e connotano alcuni ambiti urbani, garantendo ad ampie parti di città una considerevole presenza di spazi aperti pubblici, di servizi ed attrezzature. vicino la struttura insediativa di Ferrara, gli spazi e i luoghi di cui è fatta, le modalità di aggregazione dello spazio aperto, dello spazio costruito e le loro relazioni con le strade, possiamo riconoscerne l’articolazione in alcuni diverse parti, tessuti e frammenti. E’ possibile leggere regolarità ed irregolarità, somiglianze e differenze tra i diversi tessuti insediativi attraverso un’analisi non esclusivamente tipologica, ma capace di considerare una pluralità di aspetti: il rapporto tra edificio e strada, il principio insediativo, la densità edilizia, le configurazioni della rete stradale, il trattamento degli spazi aperti, l’altezza degli edifici, ecc... Risulta evidente che, il riconoscimento di alcune "specie di spazi", come suggerisce Georges Perec, costituisce un’operazione di semplificazione della realtà: anche universi di oggetti e di spazi complessi possono, in fondo, essere ricondotti ad alcuni tipi prevalenti, ad un numero limitato di forme e, a loro volta, ciascuna di queste forme può essere descritta nominando un numero limitato di regole e caratteri. E’ evidente che osservare e descrivere Ferrara, prestando attenzione ai suoi caratteri morfologici, diventa tanto più importante oggi se pensiamo che una quota rilevante degli interventi futuri possa riguardare le parti già edificate, se consideriamo che un ruolo importante per la gestione delle trasformazioni urbane, soprattutto attraverso il nuovo Regolamento Urbanistico ed Edilizio, sia affidato alle regole d’intervento nei tessuti "consolidati", che dovranno interpretare correttamente i caratteri di questo specifico paesaggio urbano riconoscendone i diversi elementi costitutivi. Un’indagine di questo tipo restituisce un’immagine di Ferrara composita, eterogenea e molteplice, in cui, agli isolati compatti del centro medievale, si affiancano il tessuto più poroso dell’Addizione Erculea, il quartiere Arianuova, l’intervento Ina-Casa di viale XXV Aprile e il rione Giardino, parti di "città pubblica" caratterizzati dalla ripetizione di alcuni tipi edilizi, principalmente edifici in linea anche di una certa consistenza, e da vasti spazi aperti, brani di case a schiera con giardino privato, gruppi di palazzine caratterizzati da alta densità ed, infine, sequenze di case minime lungo strada. Tra tutti questi diversi pezzi, a volte resti del processo di selezione prodotto dal tempo, altre volte ritagli di progetti più ambiziosi, altre ancora frammenti di un’intenzionalità speculativa, si insinuano gruppi di case isolate su lotto organizzate in tessuti dai tracciati più o meno regolari e caratterizzati da spazi aperti prevalentemente privati o condominiali. Questa molteplicità di parti, ciascuna chiaramente riconoscibile nella sua configurazione spaziale, possiede, però, una diversa capacità di organizzare la città, contribuendo solo in alcuni casi a definirne la struttura, a garantirne un corretto funzionamento e una sufficiente dotazione di servizi. Ad esempio, alcuni grandi quartieri di edilizia pubblica, come i quartieri di
via Krasnodar a sud o del Barco a nord, si distinguono dalla sequnza individualistica di casette e palazzine e connotano alcuni ambiti urbani, garantendo ad ampie parti di città una considerevole presenza di spazi aperti pubblici, di servizi ed attrezzature.
 |
Morfologia dei tracciati |
Parti di città
Strutture insediative
Osservando la città abbiamo riconosciuto alcuni  tipi di spazi: tipi di spazi:
Cortina compatta, caratterizzata da edilizia continua formata da isolati compatti con affaccio diretto su strada e piccoli spazi aperti all’interno.
Cortina porosa, caratterizzata da edilizia continua formata da grandi isolati con affaccio diretto su strada e spazi aperti interni di considerevole dimensione occupati da orti, giardini e parchi.
Griglia regolare, caratterizzate da edifici isolati collocati secondo una regola programmata di iterazione, disposti su lotti vincolati dai tracciati, con piccoli spazi aperti privati.
Griglia irregolare, caratterizzata da edifici isolati secondo una regola programmata di iterazione su lotti vincolati a tracciati irregolari, con piccoli spazi aperti privati.
Aggregazioni libere, caratterizzata da edifici svincolati dai tracciati, disposti su grandi spazi aperti pubblici.
Grandi oggetti, caratterizzati da edifici-contenitori isolati e di grandi dimensioni che non instaurano particolari rapporti
Recinti, caratterizzati da edifici tra loro simili, prevalentemente artigianali-industriali, iterati entro un perimetro circoscritto e talvolta recintato.
Filamenti, caratterizzati da edifici isolati su lotto o con un affaccio diretto sullo spazio pubblico, allineati lungo una strada.
Attorno al nucleo urbano più denso, alla Ferrara composita ma ancora relativamente compatta e solo marginalmente disseminata sul territorio esterno, sono riconoscibili altre diverse forme insediative, scandite dalle grandi estensioni della campagna.
Sviluppati principalmente lungo le strade che seguono i fiumi, i paleoalvei, i piccoli "dossi" o comunque i terreni più alti, troviamo una serie assai numerosa di piccoli centri. Ognuno di questi ha una sua specifica identità, non costituisce solamente una frazione di Ferrara, quanto piuttosto uno specifico paese. Osservandone, però, i reciproci rapporti e soprattutto mettendoli in relazione con i grandi elementi geografico-paesaggistici è possibile riconoscere delle interessanti aggregazioni. Questi diversi piccoli centri, allineandosi lungo strade, fiumi o paleoalvei, di fatto, formano più complessi ed articolati sistemi insediativi. Ad esempio, ci sembra possibile riconoscere, lungo il Po, il sistema Casaglia-Ravalle-Porporana e quello Francolino-Pescara-Sabbioni, lungo il Volano, prima il sistema Cocomaro di Focomorto-Cona-Codrea-Quartesana, poi i due centri Contrapò-Baura ed infine la sequenza Viconovo-Albarea-Villanova-Denore ed, infine, lungo il Primaro, l’articolato sistema Fossanova-Gaibanella-S.Egidio-Gaibana-Marrara-Monestirolo.
Infine i due centri S. Martino e S. Bartolomeo, collocati nel mezzo di vaste bonifiche, si sviluppano principalmente lungo un asse stradale, alternando residenza e servizi e comprendendo ai margini attività artigianali-industriali.
Geografie 2: come funziona Ferrara
Riflettere sull’idea di funzionamento della città e del territorio, sull’idea che, come una macchina o un organismo, siano fatti di parti ed oggetti organizzati in sistemi di relazione, significa interrogarsi sulla quantità di servizi ed attrezzature presenti in un dato contesto, e, ancor di più, sulle logiche della loro localizzazione, della loro distribuzione spaziale e soprattutto sui ritmi d’uso, sui diversi tempi di vita che attraversano ogni giorno la città: il tempo del bambino scandito dai ritmi scolastici, quello del commerciante scandito dall’orario dei negozi o quello del giovane che vive la città di sera, ecc. Una serie di semplici mappe che rappresentano la distribuzione dei diversi servizi, e più in generale degli "attrattori" di popolazione, possono essere osservate anche per la capacità di evocare flussi e percorsi, ritmi e pulsazioni della vita urbana, immaginando le diverse popolazioni che, mettendo in relazione questi diversi luoghi, garantiscono nei diversi momenti del giorno vitalità, e quindi sicurezza, allo spazio urbano e al territorio. Queste mappe costituiscono, anche, una prima individuazione di luoghi che rivestono un importante significato per la società ferrarese: un ospedale, una scuola o una fabbrica non sono solo delle attrezzature tecniche che devono erogare un servizio, ma diventano progressivamente anche dei luoghi urbani, edifici ai quali vengono attribuiti dei valori, spazi che vengono caricati di un senso comune, che entrano nella memoria collettiva diventando parte inalienabile della città. Questi luoghi sono variamente distribuiti sul territorio e disegnano differenti "geografie" ed organizzazioni spaziali relativamente ai diversi temi. Ad esempio, mentre alcuni servizi (scuole dell’obbligo, consultori familiari, ecc.) sono omogeneamente distribuiti sull’intero territorio comunale, altri (università, ospedale, ecc.) giustamente definiscono dei poli, dei luoghi di centralità. Geografie diverse sono riconoscibili anche tra le varie parti della città, tra il centro antico, in cui alcuni servizi pubblici si trovano a stretto contatto e quasi si sovrappongonol’un l’altro, i quartieri residenziali, in cui i servizi diventano quasi dei punti, degli elementi regolarmente distribuiti, ed i centri del forese, caratterizzati ovviamente da più semplici disposizioni di attrezzature e servizi allineati lungo le strade principali, dove formano, comunque, interessanti sequenze di presidio del territorio. In definitiva questi luoghi, e le pratiche d’uso ad essi connesse, contribuiscono a disegnare la città, dando vita a successioni di punti regolarmente distribuiti, a sequenze, ad assi tematici (come una strada di negozi) oppure ad aree e nodi di concentrazione (come l’area dei musei, il centro politico-amministrativo, l’area artigianale). Se questi servizi sono dei materiali fondamentali nella definizione dello spazio urbano (la città è tale anche perché vi si trovano, variamente distribuite, numerose attività), allora devono essere trattati come "questione urbana"; non come semplice localizzazione di un servizio ma come strategia fondamentale nella definizione di un efficiente, e contemporaneamente vivibile, ambiente urbano. Uno spazio civile nel quale, come ai tre principi di Serendip, possa capitare di "scoprire qualcosa per caso mentre ne sto cercando un’altra", un ambiente che permetta percorsi programmati ma anche libere "derive", che consenta di vagare facendo casualmente piacevoli e inattese scoperte, connettendo tra loro cose e funzioni diverse.
In questa prospettiva può essere osservata anche la rete stradale, per verificare non solo la capacità di "smatire" il traffico - come se questo fosse sempre e solo una quantità da "evacuare", da espellere e non anche una misura del ruolo di una città - ma anche se consente una corretta lettura della città, distinguendo, ad esempio, gli assi di attraversamento dalle strade di accesso, le strade urbane, lungo cui ci si aspetta di trovare una pluralità di funzioni, la convivenza di diverse modalità di trasporto ed un traffico intenso ma lento, dalle strade di quartiere e di accesso alle residenze. Considerando che l’aumento del volume di traffico è una delle caratteristiche specifiche di questa fase di sviluppo, di conseguenza, la corretta gestione della mobilità e dell’accessibilità è una condizione indispensabile per garantire efficienza ed elevate prestazioni in una struttura urbana che voglia svolgere in pieno il proprio ruolo di centro di servizi.
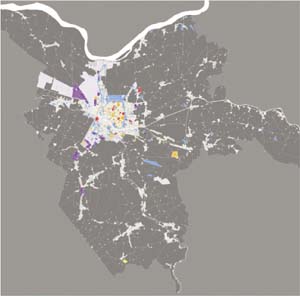 |
Centralità. Distribuzione delle attrezzature e dei servizi pubblici e privati. |
Il funzionamento della città.
Attrezzature e servizi
Oggi a Ferrara, come in molte altre città, non si riscontra una grave mancanza di servizi pubblici e il territorio risulta relativamente ben servito. Nondimeno, si rileva la necessità di una continua ricalibratura dei servizi offerti sulle reali esigenze della popolazione. In questo senso, le trasformazioni sociali che hanno investito la città contemporanea ed anche Ferrara, richiedono nuove indagini ma soprattutto spingono la politica urbanistica, e del welfare state in generale, ad indagare nuove risposte sul ruolo che, ad esempio, assume oggi un centro civico, sulle potenzialità del volontariato e del terzo settore nella realizzazione di una città più amichevole, di fronte ad una società dell’individuo, sul ruolo di una politica dei servizi urbani che cerchi di delineare nuove forme di comunità.
Attrezzature sportive
Oltre alle attrezzature coperte (palestre e piscine) e ai campi da calcio, la principale risorsa sportivo/ricreativa della città è il circuito delle mura storiche, che costituisce, per i ferraresi, una vera e propria "palestra all’aperto", uno spazio polivalente in cui camminare, correre, andare in bicicletta. Già oggi complementare agli spazi verdi e agli impianti sportivi del parco urbano, può acquisire un ruolo ancora più significativo attraverso una maggiore integrazione con una rete di percorsi e piste ciclabili che consenta di considerare anche la campagna e le rive dei fiumi come straordinari luoghi collettivi.
Scuole superiori e Università
Le scuole superiori e le sedi universitarie definiscono aree fortemente specializzate all’interno del tessuto urbano che gli studenti, i docenti e il personale tecnico-ammini-strativo collegano con altre parti della città (fermate degli autobus, stazione ferroviaria, ecc.) attraverso i loro percorsi di spostamento. Se da un lato queste aree rinviano all’idea di "distretto scolastico" o comunque di "zone monofunzionali", dall’altro tendono però a caratterizzare alcune parti urbane attraverso lo sviluppo di alcuni servizi (bar, mense, copisterie, librerie, ecc.), che servono questa specifica "popolazione", attorno a cui si sviluppa un preciso settore economico.
 |
Centralità. Distribuzione delle attrezzature e dei servizi pubblici e privati: area urbana |
Turismo
Il flusso dei turisti disegna un’altra importante geografia urbana costituita dal centro monumentale (Duomo, Castello, Palazzo del Municipio), dall’area dei musei (Pinacoteca Nazionale, Museo de Pisis, ecc.), da alcune preminenze puntuali (la Certosa, la casa di Biagio Rossetti, ecc.), ed ancora una volta dalla cerchia delle mura stesse.
I turisti connettono questi luoghi ad altre parti urbane dove sono localizzati alberghi, ristoranti e parcheggi, dando luogo ad un ulteriore sistema di funzionamento della città.
Attività commerciali
Consultando gli ultimi dati disponibili (Provincia di Ferrara – Tecnicoop –Trasformazioni recenti della rete commerciale al dettaglio in sede fissa, variazioni 1998-2001) Ferrara, anche dopo le profonde trasformazioni degli anni novanta, appare ancora caratterizzata da una buona presenza di esercizi commerciali (il settore commerciale rappresenta circa il 21% degli addetti nel comune) e, anche per questo motivo, mantiene il suo ruolo di polo attrattore per un ampio territorio circostante. Queste strutture commerciali sono variamente distribuite ed organizzate, contribuendo a definire altrettanti interessanti spazi urbani. Nel centro antico, ad esempio, i negozi tendono ad allinearsi lungo alcuni assi, formando numerose e tra loro differenti, strade commerciali. Emergono ovviamente con tutta evidenza l’asse via Garibaldi - via Mazzini, quello corso Porta Reno – corso Martiri della Libertà, alcuni tratti di via Ripagrande – via Mayr e le parti più centrali di viale Cavour – corso Giovecca, via San Romano - via Canonica - via Bersaglieri del Po. Sempre nel centro antico si nota anche con chiarezza la concentrazione di attività nelle piccole vie a ridosso del centro monumentale. Così articolate, insieme agli uffici pubblici e privati, queste attività commerciali rendono il centro di Ferrara uno spazio piacevole e sicuro, un vero e proprio "centro commerciale all’aperto" . I tessuti dell’Addizione Erculea sono caratterizzati, invece, dalle sequenze di negozi che si attestano rispettivamente su corso Porta Po, via Arianuova e via XXV Aprile. Oltre le mura riconosciamo poi altri interessanti "paesaggi del commercio": il diverso ritmo dei negozi lungo via Bologna connota una vera e propria strada urbana e lungo via Modena si alternano situazioni differenti, a tratti più urbani si succedono tratti su cui si affacciano attività produttive ed artigianali. La concentrazione di negozi negli ipermercati, la distribuzione puntuale delle attività di vendita nelle aree artigianali ed infine le sequenze di negozi lungo strada che, alternati ad altri servizi ed attrezzature (uffici postali, banche, chiese, ecc.) formano in molti centri del forese (S. Bartolomeo, Francolino, Porotto, Cona, ecc.) quasi delle main street, completano questa articolata geografia delle attività commerciali che, garantendo vivacità e vitalità alla città, vanno considerate come una vera e propria risorsa urbana. (Provincia di Ferrara – Tecnicoop –Trasformazioni recenti della rete commerciale al dettaglio in sede fissa, variazioni 1998-2001) Ferrara, anche dopo le profonde trasformazioni degli anni novanta, appare ancora caratterizzata da una buona presenza di esercizi commerciali (il settore commerciale rappresenta circa il 21% degli addetti nel comune) e, anche per questo motivo, mantiene il suo ruolo di polo attrattore per un ampio territorio circostante. Queste strutture commerciali sono variamente distribuite ed organizzate, contribuendo a definire altrettanti interessanti spazi urbani. Nel centro antico, ad esempio, i negozi tendono ad allinearsi lungo alcuni assi, formando numerose e tra loro differenti, strade commerciali. Emergono ovviamente con tutta evidenza l’asse via Garibaldi - via Mazzini, quello corso Porta Reno – corso Martiri della Libertà, alcuni tratti di via Ripagrande – via Mayr e le parti più centrali di viale Cavour – corso Giovecca, via San Romano - via Canonica - via Bersaglieri del Po. Sempre nel centro antico si nota anche con chiarezza la concentrazione di attività nelle piccole vie a ridosso del centro monumentale. Così articolate, insieme agli uffici pubblici e privati, queste attività commerciali rendono il centro di Ferrara uno spazio piacevole e sicuro, un vero e proprio "centro commerciale all’aperto" . I tessuti dell’Addizione Erculea sono caratterizzati, invece, dalle sequenze di negozi che si attestano rispettivamente su corso Porta Po, via Arianuova e via XXV Aprile. Oltre le mura riconosciamo poi altri interessanti "paesaggi del commercio": il diverso ritmo dei negozi lungo via Bologna connota una vera e propria strada urbana e lungo via Modena si alternano situazioni differenti, a tratti più urbani si succedono tratti su cui si affacciano attività produttive ed artigianali. La concentrazione di negozi negli ipermercati, la distribuzione puntuale delle attività di vendita nelle aree artigianali ed infine le sequenze di negozi lungo strada che, alternati ad altri servizi ed attrezzature (uffici postali, banche, chiese, ecc.) formano in molti centri del forese (S. Bartolomeo, Francolino, Porotto, Cona, ecc.) quasi delle main street, completano questa articolata geografia delle attività commerciali che, garantendo vivacità e vitalità alla città, vanno considerate come una vera e propria risorsa urbana.
Uffici
Gli uffici pubblici e privati (sedi di amministrazioni locali, studi professionali, banche, ecc.) presentano una distribuzione parzialmente diversa rispetto a quella dei negozi, soprattutto per quanto riguarda il centro antico. Qui, infatti, gli uffici non sono concentrati solo nella parte medievale ma coprono in modo quasi omogeneo anche l’addizione erculea. Inoltre, se da un lato si può dire che pure queste attività si allineano lungo alcune strade, dall’altro sembra però forte la tendenza a distribuirsi su tutto il centro antico. Ovviamente uffici pubblici e privati sono riconoscibili anche all’esterno delle mura, ma la loro articolata presenza nel centro antico, sommata a quella di negozi, musei ed università, se è vero che crea alcuni problemi nella gestione del traffico e della mobilità, tuttavia ci dice che Ferrara ha un centro dinamico e attivo, del quale considerare con grande attenzione la qualità di vita dei residenti, pur consentogli di continuare a svolgere un importante ruolo urbano. Proprio per questa capillare distribuzione di negozi, attività artigianali, uffici pubblici e studi professionali, il centro antico costituisce un luogo in cui non solo si abita ma anche si produce, rappresentando una delle principali "aree produttive"della città, attirando ogni giorno un elevato numero di addetti. (sedi di amministrazioni locali, studi professionali, banche, ecc.) presentano una distribuzione parzialmente diversa rispetto a quella dei negozi, soprattutto per quanto riguarda il centro antico. Qui, infatti, gli uffici non sono concentrati solo nella parte medievale ma coprono in modo quasi omogeneo anche l’addizione erculea. Inoltre, se da un lato si può dire che pure queste attività si allineano lungo alcune strade, dall’altro sembra però forte la tendenza a distribuirsi su tutto il centro antico. Ovviamente uffici pubblici e privati sono riconoscibili anche all’esterno delle mura, ma la loro articolata presenza nel centro antico, sommata a quella di negozi, musei ed università, se è vero che crea alcuni problemi nella gestione del traffico e della mobilità, tuttavia ci dice che Ferrara ha un centro dinamico e attivo, del quale considerare con grande attenzione la qualità di vita dei residenti, pur consentogli di continuare a svolgere un importante ruolo urbano. Proprio per questa capillare distribuzione di negozi, attività artigianali, uffici pubblici e studi professionali, il centro antico costituisce un luogo in cui non solo si abita ma anche si produce, rappresentando una delle principali "aree produttive"della città, attirando ogni giorno un elevato numero di addetti.
Attività produttive
Oltre al centro antico, che dal punto di vista economico si è andato specializzando in attività commerciali e di servizio, le attività più  propriamente produttive disegnano, nel territorio comunale di Ferrara, alcune diverse geografie ed evocano differenti reti e modalità di funzionamento. Ad esempio, sembra possibile distinguere alcuni "recinti" e aree specializzate, come il petrolchimico, che si relazionano sia con la città sia con un network più ampio (Porto Marghera, Mantova e Ravenna); alcune"zone miste", come le aree artigianali, che, non ospitando unicamente attività produttive ma anche commerciali, attirano sempre più oltre ai lavoratori anche acquirenti diventando in tutto e per tutto parte della città. Sono riconoscibili alcune vie lungo cui si sono sviluppate attività commerciali tali da formare delle vere e proprie"strade-mercato", in cui si susseguono attività di vendita, assistenza e riparazione (dalle gomme per auto ai mobili antichi, dai materassi ai computer) entro uno spazio a misura d’automobile. In questi ambiti, infatti, la dimensione delle varie attività, le distanze tra i vari ingressi, lo spazio aperto costituito essenzialmente da parcheggi, le quantità e dimensioni delle merci solitamente acquistate rendono quasi indispensabile l’uso dell’automobile. Nel forese, invece, si possono distinguere piccole aree produttive, e, in particolare, le attività legate al "distretto della frutta" che caratterizzano tutto il territorio comunale e il sistema produttivo specializzato nella coltivazione e lavorazione della frutta: questo sistema, ovviamente, è costituito non solo dai capannoni-frigorifero, ma anche da vaste aree coperte di frutteti e da aziende agricole specializzate in questo tipo di attività economica. Infine, si riconoscono alcuni grandi oggetti isolati, come lo zuccherificio a Pontelagoscuro, che evocano altre reti di relazioni e altri frammenti di storia del territorio. propriamente produttive disegnano, nel territorio comunale di Ferrara, alcune diverse geografie ed evocano differenti reti e modalità di funzionamento. Ad esempio, sembra possibile distinguere alcuni "recinti" e aree specializzate, come il petrolchimico, che si relazionano sia con la città sia con un network più ampio (Porto Marghera, Mantova e Ravenna); alcune"zone miste", come le aree artigianali, che, non ospitando unicamente attività produttive ma anche commerciali, attirano sempre più oltre ai lavoratori anche acquirenti diventando in tutto e per tutto parte della città. Sono riconoscibili alcune vie lungo cui si sono sviluppate attività commerciali tali da formare delle vere e proprie"strade-mercato", in cui si susseguono attività di vendita, assistenza e riparazione (dalle gomme per auto ai mobili antichi, dai materassi ai computer) entro uno spazio a misura d’automobile. In questi ambiti, infatti, la dimensione delle varie attività, le distanze tra i vari ingressi, lo spazio aperto costituito essenzialmente da parcheggi, le quantità e dimensioni delle merci solitamente acquistate rendono quasi indispensabile l’uso dell’automobile. Nel forese, invece, si possono distinguere piccole aree produttive, e, in particolare, le attività legate al "distretto della frutta" che caratterizzano tutto il territorio comunale e il sistema produttivo specializzato nella coltivazione e lavorazione della frutta: questo sistema, ovviamente, è costituito non solo dai capannoni-frigorifero, ma anche da vaste aree coperte di frutteti e da aziende agricole specializzate in questo tipo di attività economica. Infine, si riconoscono alcuni grandi oggetti isolati, come lo zuccherificio a Pontelagoscuro, che evocano altre reti di relazioni e altri frammenti di storia del territorio.
Rete stradale e mobilità
Oggi la rete stradale di Ferrara appare formata da tratti disomogenei, disegnati ed utilizzati in modo contraddittorio e non sempre coerente. Un’esigenza prioritaria, ai fini di alleggerire l’attraversamento del centro storico, viene considerato il completamento della circonvallazione interna, come previsto dal Prg vigente. Infatti, le uniche strade alternative oggi sono caratterizzate da una grande diversificazione dei tipi di sezione e dalla congestione dei nodi. In alcune ore della giornata il numero delle persone che abita le diverse parti della città ed il numero delle persone che queste parti di città solamente attraversano tendono ad equivalersi. Diverse popolazioni (il lavoratore pendolare, chi frequenta la città per fare acquisti, chi la abita, lo studente, chi deve andare in centro per affari, ecc.), si contendono lo stesso spazio urbano ed in particolare la stessa rete stradale che, per sua natura, si configura come risorsa rigida e rara.
Si riconoscono almeno due tipi di città, una "nomade" e una "stanziale", con i relativi conflitti, sovrapposizioni, in qualche caso anche convivenze.
Infatti, alcune attività perlopiù legate allo stare ed all’albitare, tendono ad erodere lo spazio di altre attività prevalentemente legate all’attraversamento ed al passaggio, rendendo palese questo conflitto soprattutto in alcune strade costrette a svolgere più ruoli, come, ad esempio, strade di collegamento tra la città ed il forese ed insieme strade-mercato.
I mezzi pubblici sono poco usati e presentano, quindi, ampi margini di incremento, diversamente dalla bicicletta che, utilizzata non solo lungo le piste ciclabili ma in maniera più flessibile e duttile, svolge un ruolo molto importante in città. Se un tempo "luoghi urbani" e "reti di relazione" tendevano a coincidere, oggi invece, anche a Ferrara, la progressiva disgregazione tra luoghi urbani e spazi di relazione costituisce, a nostro avviso, un tema attorno a cui avviare nuove ipotesi e specifiche esplorazioni progettuali. Diversi progetti e nuove opere già in avanzata fase di realizzazione (nuova circonvallazione ovest, metropolitana di superficie, ridisegno della sezione del Volano, ecc.) tendono comunque già a delineare alcune rilevanti novità con cui il Psc ha cercato di dialogare già nella fase della bozza del sistema della mobilità, presentata nei capitoli successivi.
 |
Parcheggi e accessibilità al centro |
Funzionamento ambientale del territorio
Decifrare il funzionamento della città e del territorio implica un atteggiamento responsabile e consapevole, attento ai rischi insiti nelle trasformazioni del sistema insediativo e nelle dinamiche ambientali. La disattenzione e l’ingenerosità che hanno caratterizzato le trasformazioni di città e territori in questi decenni obbligano ad avere oggi una maggiore conoscenza della consistenza, localizzazione e grado di vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale, delle condizioni di sostenibilità degli insediamenti rispetto alla quantità e qualità delle acque superficiali e sotterranee, della criticità idraulica ed idrogeologica del territorio, del livello di impermeabilizzazione dei suoli, dell’approvvigionamento idrico e della capacità di smaltimento dei reflui e, infine, dell’inquinamento dell’aria causato da polveri, emissioni chimiche o onde elettromagnetiche. La maggiore conoscenza di ognuno di questi elementi diventa essenziale per poter ricercare futuri possibili, per immaginare ragionevoli strategie e azioni per una trasformazione sostenibile del territorio: aria, acqua, suolo e sottosuolo e lo stato di rischio connesso a queste risorse sono, perciò, i materiali con cui far funzionare correttamente le nostre città ed i nostri territori e immaginare nuove prospettive di sviluppo sostenibile, in grado di garantire migliori standards di sicurezza e benessere ambientale. Le mappe che seguono rappresentano lo "stato di salute" del territorio di Ferrara e sono state costruite assieme ai consulenti per i temi geologici, idrogeologici, con l’aiuto di Arpa, dei Consorzi di bonifica, di Acosea e della Provincia di Ferrara. Esse costituiscono una sintesi degli studi più approfonditi elaborati da ciascun consulente e che costituiscono altrettante appendici del Quadro Conoscitivo.
Oltre a descrivere la situazione esistente, cercano di esprimere già alcuni primi giudizi, valutando il grado di vulnerabilità di alcune risorse e indicando, a volte implicitamente, le misure necessarie per una corretta messa in sicurezza del territorio, che costituisce uno dei caratteri strutturali di questo piano inteso come strumento urbanistico che si vuole confrontare con il tempo lungo delle trasformazioni e con la loro sostenibilità.
Aria
 |
Alcune prime valutazioni sulla qualità dell’aria relative in particolare ai livelli di benzene e polveri fini hanno segnalato:
- benzene, media annuale rilevata dalla centralina fissa di Corso Giovecca. Il trend evidenzia un deciso calo delle concentrazioni, passando da valori insostenibili a valori medi di sostenibilità (+3). L’indicatore mette, quindi, in risalto un netto miglioramento della qualità ambientale, con inversione della tendenza negativa, anche se una particolare attenzione dovrà essere rivolta all’indicatore, in quanto non è ancora in linea con i limiti proposti a livello europeo entro il 2010 (5 g/Nmc).
- polveri fini. Il trend relativo all’indicatore PM10 evidenzia una situazione di insostenibilità che varia da un valore basso (-2) ad un valore medio (-3), confermando un andamento negativo.
|
 |
Acqua
Incrociando l’analisi dell’allagabilità da fiumi e da canali con la carta geotecnica, abbiamo costruito una carta del rischio di allagabilità del territorio ferrarese.
1. Allagabilità da fiumi
Lo studio dell’allagabilità da fiumi ha aggiornato con nuovi dati e calcoli un analogo studio effettuato per il PRG del 1994. Per rotte di Po sono state infatti adottate la portata e le quote definite dal PAI-Po per eventi con tempi di ritorno di 200 anni e di 50 anni; per rotte di Panaro sono state considerate una condizione di piena rigurgitata dal Po e una condizione di massima piena propria del fiume; per rotte di Reno le portate e le quote definite dal PAI-Reno per tempi di ritorno 100 e di 25 anni.
|  |
Carta dei rischi di allagabilità e caratteri geotecnici |
I tre fiumi sono stati poi suddivisi in tratti e per ciascuno di questi sono stati considerati due scenari: uno di gravità elevata e uno di gravità media, in funzione delle diverse possibilità sopracitate (e quindi della quantità d’acqua che potrebbe essere riversata da una rotta). Mediante l’analisi della CTR, il territorio soggiacente è stato suddiviso in celle e sono state analizzate le modalità con cui queste verrebbero allagate.
Per rotte di Po sono state infatti adottate la portata e le quote definite dal PAI-Po per eventi con tempi di ritorno di 200 anni e di 50 anni; per rotte di Panaro sono state considerate una condizione di piena rigurgitata dal Po e una condizione di massima piena propria del fiume; per rotte di Reno le portate e le quote definite dal PAI-Reno per tempi di ritorno 100 e di 25 anni. I tre fiumi sono stati poi suddivisi in tratti e per ciascuno di questi sono stati considerati due scenari: uno di gravità elevata e uno di gravità media, in funzione delle diverse possibilità sopracitate (e quindi della quantità d’acqua che potrebbe essere riversata da una rotta). Mediante l’analisi della CTR, il territorio soggiacente è stato suddiviso in celle e sono state analizzate le modalità con cui queste verrebbero allagate.
Per la carta di sovrapposizione è stato preso in esame lo scenario di gravità media, assegnando valore 5 alla fascia di larghezza 300 m dal piede arginale del Po, e valori decrescenti da 4 a 1 per le altre aree allagabili.
2. Allagabilità da canali
Per lo studio del pericolo di allagamento da canali è stata innanzitutto analizzata l’attuale situazione dei bacini dei vari collettori principali della rete di scolo. Sono quindi state realizzate tre carte di allagabilità. La prima segue un criterio storico e riassume le previsioni fatte in occasione dei PRG del 1974 e del 1994. La seconda segue pure un criterio storico e segnala gli allagamenti che si sono verificati nel 1996, in corrispondenza degli eventi del 12 maggio e del 9-10 dicembre, nonché la durata della permanenza delle acque (meno di 2 giorni, fra i 2 e i 4 giorni, oltre 4 giorni).
Per la definizione dello stato attuale è stata invece costruita, con la collaborazione dei tre consorzi di bonifica, la terza carta, che applica un criterio di gravità, in quanto gradua, nelle varie parti del territorio, il livello di tale pericolosità. Essa è riferita, dal punto di vista temporale, al momento del completamento degli eventuali interventi migliorativi finora finanziati; tiene altresì conto dei benefici che si ripercuotono nel territorio comunale intervenendo in zone della rete anche esterne al territorio stesso.
3. Geotecnica
Per lo studio geologico annesso al PRG del 1974 è stata realizzata anche un’indagine generale delle caratteristiche geotecniche generali del territorio, con annessa carta geotecnica fondamentale alla scala 1: 25.000: lo scopo era quello dielaborare una zonizzazione schematica, ai fini dell’edificabilità.
Per tale indagine sono stati utilizzati i dati storici pubblicati, quelli censiti presso enti e ditte specializzate (90 colonne stratigrafiche, 100 sondaggi penetrometrici statici) e sono stati effettuati 112 trivellazioni distribuite sul territorio secondo una maglia di 4 Kmq, campionando sino a 10 m di profondità; in 85 di questi punti di prova è stata misurata la resistenza alla punta dei terreni con un penetrometro dinamico leggero (massa battente di 20 kg).
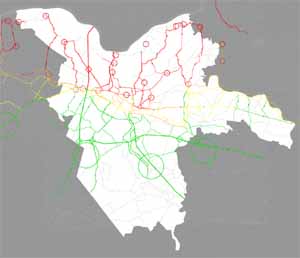 |
| Vie di fuga Po |
Attraverso la determinazione del limite liquido, limite plastico ed umidità naturale, i terreni sono stati suddivisi in cinque classi, in funzione del grado di compressibilità e consistenza che i vari terreni presentavano nel sondaggio stesso. La carta di zonizzazione geotecnica, ottenuta per interpolazione grafica fra i punti di sondaggio, rappresenta quindi volumi (per una altezza di dieci metri) di terreno a comportamento geotecnico simile.
Il quadro derivante dall’incrocio delle tre suddette tematiche mette in evidenza alcune situazioni problematiche. Le aree maggiormente penalizzate risultano
- quelle comprese tra il Po e il dosso Po di Ferrara - Po di Volano; in questa fascia a condizioni geotecniche differenziate (ma anche scadenti, specie nel settore a NE), si affiancano maggiori pericoli di allagabilità da canali e da fiumi; da notare che, considerando le attuali velocità di subsidenza, il settore più fortemente penalizzato sarebbe stato quello a NW della città, fin quasi a Pontelagoscuro,
- la zona tra il Torniano e La Stanga, al confine con il territorio di Poggio Renatico, sia per le condizioni geotecniche, sia per problemi di allagabilità da Reno e da canali
- l’area a nord di Passo Segni, per problemi di allagabilità da Reno e per condizioni geotecniche
- l’area di Valliprove, a W di S. Nicolò, sia per problemi di allagabilità sia per le condizioni geotecniche
- gli alvei di piena del Po di Ferrara, del Po di Primaro e del Po di Volano, per problemi di allagabilità da fiumi e da canali (le golene alte - a minor grado di penalizzazione - sono infatti assai poche)
- l’area a SE di Pacchenia, per scadenti condizioni geotecniche e, in subordine, per problemi di allagabilità da canali.
Con riguardo alle stesse tematiche risultano invece in condizioni particolarmente buone
- la zona a est di Gaibanella
- la fascia tra Contrapò e Quartesana
- le aree a est di Quartesana
- il settore verso Vigarano Mainarda
- la fascia a S di Porotto, sull’asse della Via Ladino
- la fascia tra Denore e Parasacco nonchè (con riserva) la fascia tra S. Martino e S. Bartolomeo.
Suolo
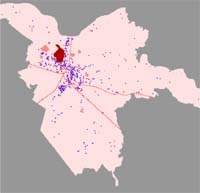 |
Indice di pericolo di inquinamento
delle acque sotterranee
|
Da un punto di vista idrogeologico, in relazione quindi all’acqua sotterranea, la evoluzione del territorio comunale di Ferrara è frutto di una complessa rete di interazioni fra la realtà geologica e lo sviluppo antropico ed economico dell’area. I processi geomorfologici e sedimentologici che hanno agito sul territorio hanno determinato la distribuzione dei corpi sedimentari acquiferi e delle falde idriche in essi contenute. Il Po e la rete di canali determinano la distribuzione dei battenti idraulici di ricarica e di alimentazione delle falde. L’indagine idrogeologica è stata eseguita sulle due aree che possono essere considerate a maggior fragilità territoriale in relazione alle caratteristiche del sottosuolo, alla tipologia di uso del territorio ed alle previsioni del piano: la zona Nord fra la cinta della mura e Pontelagoscuro e la zona Sud fra via Bologna e Cona. Lo studio è consistito in attività di raccolta, misura sperimentale, elaborazione e restituzione cartografica di dati ed informazioni idrogeologiche al fine di produrre degli elaborati cartografici che costituiscano sia una rappresentazione territoriale delle caratteristiche idrogeologiche del territorio sia una valutazione della attitudine del territorio medesimo a sostenere i potenziali impatti territoriali derivanti dalle trasformazioni urbanistiche di progetto. Tutti gli elaborati cartografici prodotti restituiscono informazioni georeferenziate e sono basati su un database dei dati primari e su un sistema informativo su piattaforma ESRI (ArcView); tutte le informazioni sono pertanto completamente interfacciate, da un punto di vista territoriale, con il sistema informativo dell’amministrazione comunale. Lo scopo è stato quello di dare un ranking al territorio in relazione all’attitudine a sostenere interferenze di tipo qualiquantitativo sul sistema delle falde idriche; in particolare sono considerate l’attitudine a sostenere l’impatto di inquinamenti (vulnerabilità all’inquinamento), a sostenere impermeabilizzazioni del terreno con conseguente diminuzione del potere di ravvenamento della falda ed, infine, a sostenere emungimenti di acqua sotterranea. Sono state anche individuate, per quanto riguarda la zona di Ferrara sud, le aree dove il livello di falda è più vicino al piano campagna e quindi dove maggiore è il rischio di allagamento o di innesco di effetti indesiderati sulle sottostrutture. Vengono qui di seguito sinteticamente riportate le caratteristiche idrogeologiche salienti delle 2 porzioni indagate di territorio comunale. La distribuzione territoriale delle caratteristiche idrogeologiche analizzate, in relazione all’uso del territorio, è mostrata tramite una serie di elaborati cartografici; nella presente nota di inquadramento dello studio idrogeologico verranno nello specifico commentati 3 di questi elaborati, considerati più rappresentativi.
Zona Ferrara Nord: un acquifero sabbioso assai produttivo ma a rischio
La zona, di circa 39 Km è delimitata a Nord dal fiume Po, ad Est si estende poco oltre via Calzolai, lambendo gli abitati di Francolino e Malborghetto di Boara, a Sud praticamente si ferma alla cinta muraria di Ferrara e ad Ovest non si discosta molto dal tracciato dell’Autostrada A13 Bologna-Padova. Quest’area contiene probabilmente le strutture antropiche e naturali cruciali per la comunità Ferrarese. A Nord infatti il più importante fiume italiano regola e impone, con i suoi cicli di piena e di magra, le attività dei Consorzi di Bonifica per quello che riguarda le irrigazioni agricole e lo scolo, ma anche i prelievi di acqua ad uso idropotabile, industriale e la navigazione interna. L’asse mediano Nord-Sud è sede della ferrovia che collega Bologna a Venezia, più ad Ovest decorre l’Autostrada A-13 mentre a Sud è situato il centro storico della città ed in posizione centrale il grande insediamento multisocietario di circa 250 ettari (di estensione comparabile a quello del centro storico di Ferrara) che il canale Boicelli divide dal parco industriale Solvay e dalla Cartiera Burgo. Inoltre nella stessa area hanno sede la discarica di Cà Leona di proprietà AGEA in gran parte dismessa, una discarica di inerti in Via Canapa, lo Zuccherificio SFIR di Pontelagoscuro e infine il campo pozzi e i depuratori di ACOSEA, la società che fornisce acqua potabile all’intera città. E’ facile osservare come sia un precario equilibrio a garantire la convivenza tra recettori altamente sensibili (fiume, campo pozzi ACOSEA, canali e centri abitati) e fonti potenzialmente molto pericolose quali stabilimenti chimici e discariche. L’area è morfologicamente limitata da 2 barriere rappresentate dall’argine meridionale del Po a Nord e dal paleoalveo del Po di Ferrara a Sud (ambedue con quote comprese fra i 10 e 12 m s.l.m.); tali 2 rilievi sono dominanti. Fra i 2 si evidenzia una zona rilevata nell’area del petrolchimico, presumibilmente da mettere in relazione ad un paleoalveo minore. Tale evidenza geologica rappresenta uno dei fattori-chiave di lettura del rischio idrogeologico nell’area. Sono 2 le falde idriche oggetto di studio: la falda più superficiale (che chiameremo freatica) ospitata e fluente nei livelli relativamente più permeabili della copertura e la falda ospitata e fluente nelle sabbie würmiane, che chiameremo I falda in pressione. Per la ricostruzione del campo di moto delle 2 falde suddette sono state effettuate specifiche campagne (rispettivamente freatimetriche per la falda superficiale e piezometriche per la falda in pressione) durante le quali sono stati anche rilevati i livelli idrici dei canali principali (in connessione idraulica con la falda superficiale) e del fiume Po (in possibile comunicazione con la falda in pressione). Le campagne sono state effettuate nei mesi di Dicembre 2002 e Giugno 2003 (condizioni di piena e di magra da un punto di vista idrologico). L’elaborato 9a mostra il campo di moto della I falda in pressione relativo al mese di Dicembre 2002 (fase di piena). Le curve (isopiezometriche) indicano la quota piezometrica assoluta della falda; l’effetto alimentante del Po domina l’andamento del flusso con un verso medio regionale di deflusso in direzione SSE; la piezometria locale è fortemente influenzata dal regime di prelievi attuato all’interno del complesso
Sottosuolo
industriale e da quelli per scopo acquedottistico. In questo quadro, infatti, spiccano 2 notevoli depressioni a flusso radiale centripeto: si tratta del cono di pompaggio ACOSEA e di quello a scopo duplice Solvay (messa in sicurezza d’emergenza della falda e prelievo a scopo industriale). La carta costituisce un elaborato essenziale per la valutazione dei rischi idrogeologici nell’area, in un’ottica di previsione e prevenzione dei rischi; la relazione fra livello del Po, localizzazione della centrale di sollevamento Acosea e polo multisocietario, evidenza come i pozzi ad uso potabile siano ubicati a monte del flusso regionale di falda rispetto alla localizzazione dei centri di pericolo inquinanti ma, al tempo stesso, vi sia esigenza di un monitoraggio di difesa dei pozzi medesimi rispetto al territorio circostante. L’Indice di Pericolo di inquinamento (Elaborato n°6), valutato per tutto il territorio comunale, mette in evidenza la fragilità territoriale della zona Ferrara Nord. Il suddetto Indice è rappresentato dalla distribuzione dei CDP (Centri di Pericolo), cioè di tutte le attività o infrastrutture in grado di ingenerare contaminazione delle acque sotterranee. Si è operato un censimento di tutte le attività potenzialmente inquinanti supportato dai seguenti uffici territoriali: Ufficio Urbanistica ed Ufficio Ambiente del Comune di Ferrara, ARPA Emilia-Romagna (Dipartimento di Ferrara), Vigili del Fuoco di Ferrara. Ai fini della definizione delle zone considerate "pericolose" è stata anche condotta un’analisi fotointerpretativa comparata relativa alle foto aeree degli anni 1937-1945-1954-1987-1994. La interpretazione successiva ha permesso di evidenziare lo sviluppo del territorio e di mettere in evidenza, particolarmente nell’area nord di Pontelagoscuro, "aree fragili" dove sono avvenute pratiche non controllate come smaltimenti e movimenti terra o che hanno indotto tale pratica in seguito ai bombardamenti avvenuti durante il secondo conflitto mondiale oppure in relazione alla pratica delle attività di macerazione della canapa. Dal resoconto sintetico dell’analisi territoriale effettuata risulta un’area particolarmente dinamica come attività produttiva ed al contempo degradata e fragile da un punto di vista urbanistico, con coesistenza di attività produttive, aree di smaltimento e discariche. La complessità idrogeologica del territorio di Ferrara Nord nasce quindi dalla coesistenza di una buona produttività di falda, di interesse acquedottistico e certamente con possibilità di futuri incrementi, e di una elevato valore del potenziale di impatto. La mediazione che fornisce la potenzialità del territorio di difendersi da tali impatti è data dalla vulnerabilità dell’acquifero cioè dalla facilità con cui un inquinante, sversato alla superficie, può arrivare a contaminare la falda. Nell’elaborato n°11 viene mostrata la vulnerabilità dell’acquifero freatico. Il grado di vulnerabilità/infiltrabilità dell’acquifero freatico è in relazione alla distribuzione dei litosomi sabbiosi o sabbio-limosi sub-superficiali, per cui abbiamo una vulnerabilità da elevata a media, con tempi d’arrivo di un inquinante non superiori a 16 giorni, lungo il paleo alveo del Po di Ferrara a Sud, lungo il paleoalveo da Ravalle ad Ovest e in una fascia estesa compresa fra Mizzana e Pontelagoscuro, fascia che abbraccia interamente l’area dello stabilimento multisocietario. Nella rimanente parte del territorio la vulnerabilità è prevalentemente bassa, arrivando ad un grado molto basso a Nord di Cassana-Porotto, nella parte occidentale, ed a Sud di Possessione Cà Grande nella parte orientale. Mediamente la falda freatica appare vulnerabile all’inquinamento e lo è particolarmente proprio al di sotto delle aree più antropizzate o industrializzate. La discarica di Cà Leona è localizzata in un’area prevalentemente a vulnerabilità bassa.
Zona via Bologna direttrice per Cona
Interazione fra territorio e falda freatica
Le problematiche idrogeologiche della "zona via Bologna-Cona" sono sopratutto legate alla dinamica della falda freatica, il cui campo di moto, come vedremo, è soprattutto influenzato dalla morfologia e dalla distribuzione dei paleoalvei dossivi e dei canali irrigui e di bonifica più che dalla struttura geologica profonda. Nella "zona via Bologna-Cona" la falda oggetto di studio è la falda più superficiale (che chiameremo freatica); l’interesse deriva dal fatto che è la dinamica di tale falda che può interferire con la trasformazione urbanistica del territorio, condizionandone lo sviluppo e dettandone i vincoli progettuali. La dinamica della falda freatica è controllata dall’ubicazione dei "paleoalvei" del sistema deltizio del Po, corpi sabbiosi nastriformi rilevati di pochi metri rispetto al territorio circostante. L’area è infatti limitata in modo netto da due barriere morfologiche rappresentate, a Nord, dal Paleoalveo del Po di Ferrara e dalla sua continuazione nel paleoalveo del Po di Volano (fra Ferrara centro e Cona), ad Ovest da una zona elevata corrispondente alle passate rotte del fiume Reno ed alla sorta di "delta" con cui veniva fatto sfociare nella Sammartina (ad Ovest di Chiesuol del Fosso e, successivamente, a Sud di Bastia). Al centro della zona si può notare un’altra barriera morfologica in corrispondenza del paleoalveo del Po morto di Primaro attualmente percorso dal fiume Primaro. La zona si estende per circa 6 km da Nord a Sud e per circa 27 km da Est ad Ovest per una superficie totale di circa 162 kmq. Sono state prodotte 2 restituzioni del campo di moto della falda freatica, in situazioni idrologiche differenziate (Febbraio 2003-Luglio 2003). Gli elaborati sono basati su misure eseguite in pozzi domestici di grande diametro attingenti alla falda freatica (quindi con profondità non superiore a 10 m); sono stati misurati anche i canali principali in connessione con la falda freatica (Po di Volano, Po morto di Primaro, Collettore principale di Cona, Scolo Rinaldi, Scolo Civetta, Scolo S. Martino). È importante considerare che la falda freatica, nella zona studiata, non è certamente interpretabile come un corpo d’acqua continuo ma piuttosto come un insieme di corpi idrici, separati e fluenti nei litosomi sabbiosi e sabbio-limosi, separati da plaghe argillose o limoso-argillose ove è più corretto parlare di zona di saturazione e non di falda vera e propria. La morfologia della falda è irregolare, presentando comunque una direzione di deflusso media da Nord-Nord Ovest verso Sud-Sud Est, controllata quindi dagli "alti" morfologici del Po di Ferrara e del vecchio Reno. In generale, quindi, la falda ha un livello maggiore in corrispondenza dei paleoalvei e tende a scorrere verso i bassi relativi rappresentati dai catini interfluviali in corrispondenza della "Sammartina" (quote di 5.0-4.4 m s.l.m) e della zona tra Cocomaro di Cona e la superstrada Ferrara-Mare (2.5-2.0 m s.l.m.).
Le caratteristiche del campo di moto rimangono immutate con la stagione anche se si nota, in estate, un abbassamento generalizzato del livello (con una risalita solo in vicinanza delle principali dorsali irrigue). La distribuzione della vulnerabilità all’inquinamento dell’acquifero freatico riflette la distribuzione dei corpi sabbiosi: i valori di vulnerabilità elevata sono distribuiti prevalentemente in corrispondenza dei paleoalvei principali e secondari (paleoalveo del Po di Ferrara, Paleoalveo del Po di Primaro, Paleoalveo del Po di Volano, Paleoalveo del Vecchio Reno) e in altre aree circoscritte. I valori invece di vulnerabilità bassa e molto bassa si identificano in corrispondenza delle zone topograficamente più depresse, sedi dei bacini interfluviali (Sammartina e la zona a SW di Cona). Le zone più vulnerabili sono quelle dove maggiormente intensa è la ricarica per infiltrazione zenitale e quindi dove maggiori possono essere gli effetti negativi indotti da progettazioni che comportino impermeabilizzazione. Importante, per le caratteristiche specifiche della zona studiata, era la valutazione dell’attitudine della zona a subire allagamenti in relazione alla distanza della tavola d’acqua dal piano di campagna ed in particolare alla minima distanza a cui tale superficie fisica può andare incontro durante le stagioni. Al diminuire della soggiacenza, e quindi al diminuire dello spessore della zona insatura, aumenta il rischio di allagamento del territorio, a parità di altri fattori di tipo altimetrico, climatico e geologico.
Il valore minimo di soggiacenza registrato è pari a 0.44 m da p.c. I valori più bassi di allagabilità sono localizzati nella parte nord-occidentale dell’area, in relazione alle risalienze morfologiche dovute alla presenza del paleo-alveo del Po di Ferrara e del paleo-delta del Reno. Le zone più depresse a SW ed a SE risultano le più allagabili; i massimi valori si registrano all’estremo angolo SE dell’area dove si registra una soggiacenza minima inferiore ad 1 m. In corrispondenza del paleoalveo del Primaro la classe di allagabilità si abbassa in relazione alla risalienza morfologica. La soggiacenza media minima del territorio risulta pari a 1.43 m da p.c.; la soggiacenza media massima registrata in Luglio risulta pari a 2.13 m da p.c. Ai fini di una fruibilità urbanistica e di supporto alla pianificazione territoriale degli elaborati idrogeologici realizzati, di concerto con gli altri tecnici incaricati delle valutazioni, la cartografia di "vocazione idrogeologica alle trasformazioni del territorio" è stata realizzata tramite discretizzazione in Elementi Quadrati Finiti (EQF) di 100 m di lato con ranking del territorio in 5 classi a differente idoneità. In tal modo si sono create le condizioni per un interfacciamento ottimale fra previsioni del piano e verifica della fattibilità idrogeologica.
Subsidenza.
Isocinetiche di abbassamento del suolo |
 | 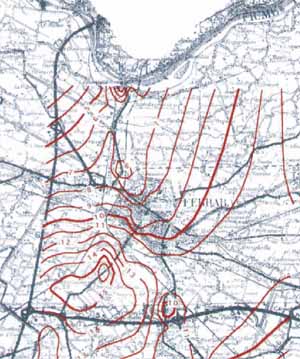 |
| fig.1 1957-73 | fig. 2 1970-90 |
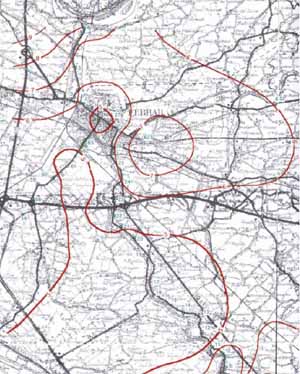 |
| fig.3 1990-99 |
I fenomeni di subsidenza accertati nel territorio comunale sono di carattere sia naturale che artificiale. Per i primi le velocità di abbassamento sono generalmente valutabili in meno di 1 mm/anno, i secondi hanno manifestato velocità anche superiori a 10 mm/anno. Per lo studio del fenomeno sono stati utilizzati dati di livellazioni geometriche di precisione. L’indagine della sua evoluzione passata si è basata:
- sul confronto tra i dati del primo impianto della Rete Altimetrica Nazionale di precisione dell’Istituto Geografico Militare Italiano, istituita tra il 1885 e il 1902 e i dati della Nuova Rete Altimetrica Fondamentale realizzata dallo stesso ente nel secondo dopoguerra;
- sul confronto tra le quote della Nuova Rete Altimetrica Fondamentale e le misure eseguite dallo stesso IGMI negli anni ‘70 (fig. 1 - isocinetiche di abbassamento per il periodo 1957-73);
- sul confronto tra le misure eseguite dall’IGMI negli anni ‘70 e quelle eseguite negli anni 1986-90 (fig. 2 - isocinetiche di abbassamento per il periodo 1970-90).
Nel secondo e terzo confronto sono rilevabili, in particolare, notevoli velocità di abbassamento tra Ferrara e Pontelagoscuro (oltre 11 mm/anno nel periodo 1953-73) e a sud di Ferrara (oltre 13 mm/anno nel periodo 1953-90).
Studi idrogeologici avevano individuato, per la zona tra Ferrara e Pontelagoscuro, una forte depressione della superficie piezometrica (Bondesan e Talassi, 1987) e provato l’esistenza di un diretto legame, nell’intero territorio comunale, tra lo sfruttamento degli acquiferi e l’abbassamento del suolo. Le tendenze attuali sono definibili sulla base del confronto tra le misure eseguite dall’IGM negli anni 1986-90, nonché dall’AGIP e dalla Provincia intorno al 1980, e le misure effettuate nel 1999 dall’ARPA (fig. 3 - isocinetiche di abbassamento per il periodo 1990-99). Esse segnalano un generale rallentamento del fenomeno, mentre restano ancora elevate (da 6 a 8 mm/anno) le velocità di abbassamento tra Ferrara e Pontelagoscuro.
Con riferimento a quest’ultima carta, si propone la seguente graduazione (livelli di penalizzazione) da utilizzare soprattutto per orientare eventuali estrazioni di acqua dal sottosuolo o localizzare attività capaci di inquinare il terreno:
1 - settori con velocità di abbassamento minori di 5 mm/anno (e aree non indagate);
2 - fasce con velocità di abbassamento comprese fra 5 e 6 mm/anno;
3 - fasce con velocità di abbassamento comprese fra 6 e 7 mm/anno;
4 - fasce con velocità di abbassamento comprese fra 7 e 8 mm/anno;
5 - settori con velocità di abbassamento di oltre 8 mm/anno.
Non è possibile prevedere sensibili attenuazioni del fenomeno per il futuro. Appare indispensabile, collaborando con gli altri organi preposti, continuare il monitoraggio del fenomeno (anche verificando il rispetto dei caposaldi di livellazione), nonché controllare e limitare le attività che potrebbero produrre ulteriori abbassamenti, quali eccessive estrazioni d’acqua o di altri fluidi dal sottosuolo, forti e prolungate modificazioni della falda freatica, dispersione nel suolo di inquinanti.
Potenzialità archeologiche urbane
La carta delle potenzialità archeologiche urbane è uno strumento di censimento, tutela e valorizzazione del bene archeologico sepolto che permette di prevedere, con una certa attendibilità, il rischio di rinvenire stratigrafie archeologiche nel corso di lavori sul sottosuolo.
In mancanza di un tale strumento l’intervento della Soprintendenza si realizzava, quasi sempre, a posteriori con fermi lavori o con un rallentamento delle attività di cantiere, sia con danno economico per gli operatori che con la perdita di molti beni archeologici.
La carta delle potenzialità archeologiche permette invece di conoscere con buona approssimazione la "consistenza" della stratigrafia archeologica dell’area interessata ad un progetto e di pianificarne l’intervento di scavo prima dell’apertura del cantiere, con evidenti risparmi economici e di tempistica e ottenendo contemporaneamente una efficace tutela e conoscenza del bene archeologico.
La necessità di dotare anche Ferrara di tale strumento di gestione e tutela - già adottato e reso operativo in molte città emiliano-romagnole, come ad esempio Modena, Forlì, Faenza, Lugo, Forlimpopoli, Cesena- è emersa con evidenza nell’ambito degli studi propedeutici alla realizzazione del Nuovo Piano Urbanistico.
Punto di partenza del lavoro è il censimento delle presenze archeologiche conosciute che vengono individuate e cartografate. Ad ogni sito archeologico si associa una scheda che registra tutti i dati utili.
Tale scheda presuppone un’analisi, elaborata a più livelli, dell’evidenza archeologica sia dal punto di vista del grado di conservazione nell’ambito della stratificazione urbana che delle differenti fasi cronologiche. E’ così possibile realizzare carte tematiche organizzate secondo vari temi. Il lavoro sarà completato con la definizione di almeno tre differenti sezioni della città in cui evidenziare la potenzialità dei diversi livelli archeologici, in modo tale da conoscerne profondità ed eventuali variazioni di quota. è uno strumento di censimento, tutela e valorizzazione del bene archeologico sepolto che permette di prevedere, con una certa attendibilità, il rischio di rinvenire stratigrafie archeologiche nel corso di lavori sul sottosuolo.
In mancanza di un tale strumento l’intervento della Soprintendenza si realizzava, quasi sempre, a posteriori con fermi lavori o con un rallentamento delle attività di cantiere, sia con danno economico per gli operatori che con la perdita di molti beni archeologici.
La carta delle potenzialità archeologiche permette invece di conoscere con buona approssimazione la "consistenza" della stratigrafia archeologica dell’area interessata ad un progetto e di pianificarne l’intervento di scavo prima dell’apertura del cantiere, con evidenti risparmi economici e di tempistica e ottenendo contemporaneamente una efficace tutela e conoscenza del bene archeologico.
La necessità di dotare anche Ferrara di tale strumento di gestione e tutela - già adottato e reso operativo in molte città emiliano-romagnole, come ad esempio Modena, Forlì, Faenza, Lugo, Forlimpopoli, Cesena- è emersa con evidenza nell’ambito degli studi propedeutici alla realizzazione del Nuovo Piano Urbanistico.
Punto di partenza del lavoro è il censimento delle presenze archeologiche conosciute che vengono individuate e cartografate. Ad ogni sito archeologico si associa una scheda che registra tutti i dati utili.
Tale scheda presuppone un’analisi, elaborata a più livelli, dell’evidenza archeologica sia dal punto di vista del grado di conservazione nell’ambito della stratificazione urbana che delle differenti fasi cronologiche. E’ così possibile realizzare carte tematiche organizzate secondo vari temi. Il lavoro sarà completato con la definizione di almeno tre differenti sezioni della città in cui evidenziare la potenzialità dei diversi livelli archeologici, in modo tale da conoscerne profondità ed eventuali variazioni di quota.
Geografie 3: come sta cambiando Ferrara
Le mappe e i dati che seguono cercano di dare una prima risposta a come siano cambiati Ferrara e il suo territorio negli ultimi decenni, quali "geografie della trasformazione" sia possibile riconoscere, quali siano le dimensioni degli interventi e degli operatori che le hanno sostenute.
Ovviamente questi sono strumenti indiziari attraverso cui cercare di ricostruire i processi di trasformazione della città e di riconoscerne obiettivi, tempi e strategie degli operatori.
Lo strato dei caratteri fisici, le forme dello spazio, i vuoti e pieni del tessuto urbano da cui muove questa lettura temporale, non solo hanno avuto origine in epoche differenti ed evolvono seguendo ritmi diversi, ma sottendono specifiche storie e possono essere visti come una stratificazione temporale di regole, tecnologie e progetti che politici e costruttori, committenti e promotori, intellettuali e progettisti hanno, di volta in volta, messo in atto. Questa parte del lavoro si basa su alcune operazioni di ricerca. Una prima serie di tavole illustra le trasformazioni che è possibile cogliere sovrapponendo ai dati della carta tecnica regionale del 1985 rappresentati in nero, il nuovo edificato evidenziato in rosso. Queste mappe sono accompagnate da una prima elaborazione dei dati relativi alle concessioni edilizie che consentono alcune riflessioni, sebbene presentino dei margini di imprecisione (non tutte le opere progettate e le concessioni rilasciate giungono ad effettiva costruzione) e quindi non possano essere ritenuti coincidenti e perfettamente comparabili con le rappresentazioni cartografiche. Un’ulteriore indagine si fonda sull’analisi e verifica del Piano Regolatore Generale vigente, per verificarne il grado di attuazione e riassumerne le principali ipotesi, sia per quanto riguarda le aree edificabili che le attrezzature e gli standard.
Trasformazioni
Una prima "geografia delle trasformazioni" si riferisce allo spazio edificato e emerge osservando gli edifici costruiti negli ultimi quindici anni, rappresentati indifferentemente rispetto alle loro funzioni ma precisamente per quanto riguarda la loro forma.
Attraverso questa prima rappresentazione del territorio ferrarese "colonizzato" da nuovi insediamenti, possiamo riconoscere diverse modalità di costruzione e trasformazione che interessano aree contigue alla città esistente, ma anche nuovi insediamenti isolati nel territorio, i quali possono essere letti come consolidamento del capoluogo ma anche come contenuto ampliamento delle frazioni.
Da un lato riconosciamo la nuova edificazione ai bordi della città, soprattutto a sud-est, prevalentemente caratterizzata dall’addizione di nuove parti di città che si attaccano al tessuto esistente, pur mantenendo una propria autonomia formale.
Accanto a ciò si riconosce un fenomeno meno consistente di incremento attraverso l’aggiunta di singoli edifici, prevalentemente nel territorio esterno al centro abitato, nelle frazioni e lungo le strade principali.
Infine, è riconoscibile, all’interno del tessuto insediativo esistente, un fenomeno di consolidamento, attraverso cui nuovi edifici tendono a completare e densificare brani di città incompiuti. Da questa lettura traspaiono, anche, la dimensione ed i caratteri dei nuovi tessuti edilizi, le misure e modalità di intervento praticate nel territorio ferrarese come, ad esempio, quartieri esito di progetti unitari, di progetti di lottizzazione, oppure edifici isolati esito di singole concessioni edilizie.
Tutto ciò allude al peso e alla frequenza con cui i diversi operatori, Acer, Cooperative, imprese edili, ecc., si sono attivati nell’edificazione della città recente.
Tenendo sullo sfondo questa prima analisi delle trasformazioni abbiamo cercato di pervenire ad una maggiore articolazione dei tessuti e degli spazi della città costruita negli ultimi decenni, un’analisi tecnicamente pertinente dei diversi principi insediativi, tipi edilizi, rapporti di copertura, spazi aperti, funzioni, che caratterizzano questi interventi. Una seconda "geografia delle trasformazioni" si delinea indagando un analogo processo di trasformazione che caratterizza le reti stradali, rilevando quante strade e in che modo siano state costruite negli ultimi quindici anni e quali parti della città e del territorio di Ferrara siano stati coinvolti. Prevalgono, in questo caso, interventi di aggiunta di piccoli pezzi, di rettifiche o varianti di tracciati precedenti, piuttosto che nuove significative realizzazioni. Si riconoscono, nella maggior parte dei casi, strade di lottizzazione che si agganciano alla trama esistente o brevi tratti che si insinuano nel territorio agricolo; pezzi tra loro prevalentemente separati, ma ciò nondimeno riconducibili ad una più complessiva strategia di dilatazione della rete esistente.
Questi processi di trasformazione portano ad interrogarsi sul ruolo svolto dai diversi enti pubblici (locali e non) nei processi di trasformazione della città e del territorio, sulla reale capacità d’intervento dei diversi operatori pubblici, sulla quantità e qualità delle opere realizzate.
Metamorfosi
La trasformazione della città, però, non è legata solamente alla nuova costruzione e alla colonizzazione di nuove parti di territorio. A Ferrara sono riconoscibili altre, diverse e importanti modalità di trasformazione come ad esempio quell’insieme di processi minuti che possiamo definire di metamorfosi e che troppo spesso vengono considerati quasi irrilevanti ma che, nella loro iterazione, costituiscono fenomeni di consistente cambiamento della città. I negozi del centro storico convertiti in garages, i vecchi fienili trasformati in residenze e le vecchie fabbriche in uffici o grandi magazzini, costituiscono altrettanti processi di trasformazione che, per la loro pervasività, acquistano senza alcun dubbio rilevanza strutturale.
Fabbricati residenziali
Tra il 1985 e il 2001 sono state rilasciate concessioni edilizie per un totale di 3.322.087 mc di nuovi fabbricati residenziali, pari ad una media annuale di 195.417mc, e di 345.517 mc di ampliamenti, pari ad una media annuale di 20.325 mc. Da questi primi dati emerge da un lato la discontinuità di richieste e rilasci di concessioni, che fa registrare, ad esempio, un picco nel 1988 con 328.147 mc di opere progettate e per converso il 1995 con soli 95.624 mc, andamenti che possono essere messi in relazione con più generali processi di pianificazione urbanistica (adozione di nuovi piani, ecc.), dall’altro alcune modifiche nel tipo e nella dimensione degli alloggi: ad esempio, dalla metà degli anni novanta si registra un aumento degli alloggi di piccole dimensioni (da 46 a 75 mq) che superano anche quelli compresi tra 76 e 95 mq.
|
Fabbricati non residenziali
Per ciò che riguarda le opere edilizie non residenziali (comprendenti capannoni industriali ma anche attrezzature pubbliche, ecc.), osservando sempre il periodo che va dal 1985 al 2001, oltre all’andamento irregolare può essere interessante notare il valore degli ampliamenti che, stando alla superficie coperta, raggiungono in media ogni anno la metà (14.003 contro 31.264) del valore dei nuovi fabbricati. Più interessante può apparire, però, il dato relativo alle destinazioni d’uso degli edifici, dal quale si può cogliere un segnale dell’articolazione della struttura economica di Ferrara: se il 46% dei nuovi fabbricati è destinato ad attività industriali e artigianali (potrebbe essere interessante, tra l’altro, scomporre questo primo dato), un altro 25% è destinato a commercio e riparazione beni e un non trascurabile 10% alle attività agricole. L’articolazione dei tessuti residenziali nel piano regolatore vigente.
|
| Usi degli edifici non residenziali dal 1985 al 2001 | Fabbricati non residenziali. Volumi e superfici |
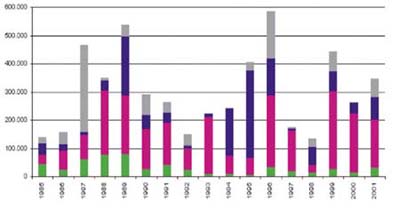 |
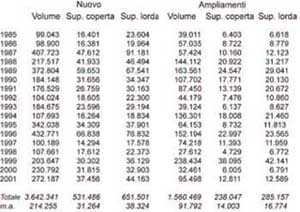 |
 |
Altro |
 |
Commercio e riparazione beni |
 |
Industria e artigianato |
 |
Agricoltura |
| |
Trasformazione dei tracciati
Progetti di trasformazione: il piano regolatore vigente.
Sullo sfondo delle  trasformazioni che nel corso di questi ultimi quindici anni hanno investito la città di Ferrara e il suo territorio, si collocano scelte, progetti e politiche urbane, tra cui l’ultimo piano regolatore generale, che hanno cercato di affrontare diverse questioni come la presenza di un patrimonio di aree dismesse industriali non periferiche, la necessità di accogliere funzioni terziarie in forte crescita adeguando il tessuto edilizio e la rete infrastrutturale, e l’idea di ridefinire la forma urbis attraverso nuove addizioni residenziali. In particolare, il ridisegno della forma urbana, nel Piano Regolatore vigente, viene ottenuto anche attraverso l’attribuzione di indici fondiari differenti alle varie parti della città. La fascia di insediamenti lungo il Volano, l’asse di via Bologna e la grande area dismessa dell’Eridania emergono come i nuovi condensatori, aree da assoggettare a ristrutturazione urbanistica e fondiaria, con indici di 4-5 mc/mq, dove possono localizzarsi soprattutto le funzioni proprie di una nuova economia post-industriale. A queste aree viene contrapposto il tessuto minuto di case e palazzine con giardino, cui viene attribuito un indice compreso tra 3 e 2 mc/mq. Piccoli condensatori vengono previsti anche in alcune frazioni per rafforzarne l’identità urbana. Allo stesso modo, nel piano viene esercitata una distinzione dei caratteri e dei livelli di strutturazione dei diversi tessuti insediativi, disegnando una città in cui alle aree di impianto storico del nucleo entro le mura, dei borghi, delle corti coloniche e delle ville rurali, a cui vengono riconosciute integrità e coerenza tipiche di parti storiche, e agli insediamenti di edilizia pubblica, a cui viene riconosciuto un grado di strutturazione significativo, vengono contrapposti i tessuti composti di case, villini e palazzine dove si registra, invece, l’assenza di un legame fra i tessuti urbani e i tipi edilizi, prevedendo, quindi, una decisa politica di ristrutturazione urbanistica. A quest’ultima categoria viene fatto appartenere anche il quartiere Arianuova poiché, pur chiaramente pianificato, risulta caratterizzato da tipi edilizi non sempre congruenti con il tessuto urbano. trasformazioni che nel corso di questi ultimi quindici anni hanno investito la città di Ferrara e il suo territorio, si collocano scelte, progetti e politiche urbane, tra cui l’ultimo piano regolatore generale, che hanno cercato di affrontare diverse questioni come la presenza di un patrimonio di aree dismesse industriali non periferiche, la necessità di accogliere funzioni terziarie in forte crescita adeguando il tessuto edilizio e la rete infrastrutturale, e l’idea di ridefinire la forma urbis attraverso nuove addizioni residenziali. In particolare, il ridisegno della forma urbana, nel Piano Regolatore vigente, viene ottenuto anche attraverso l’attribuzione di indici fondiari differenti alle varie parti della città. La fascia di insediamenti lungo il Volano, l’asse di via Bologna e la grande area dismessa dell’Eridania emergono come i nuovi condensatori, aree da assoggettare a ristrutturazione urbanistica e fondiaria, con indici di 4-5 mc/mq, dove possono localizzarsi soprattutto le funzioni proprie di una nuova economia post-industriale. A queste aree viene contrapposto il tessuto minuto di case e palazzine con giardino, cui viene attribuito un indice compreso tra 3 e 2 mc/mq. Piccoli condensatori vengono previsti anche in alcune frazioni per rafforzarne l’identità urbana. Allo stesso modo, nel piano viene esercitata una distinzione dei caratteri e dei livelli di strutturazione dei diversi tessuti insediativi, disegnando una città in cui alle aree di impianto storico del nucleo entro le mura, dei borghi, delle corti coloniche e delle ville rurali, a cui vengono riconosciute integrità e coerenza tipiche di parti storiche, e agli insediamenti di edilizia pubblica, a cui viene riconosciuto un grado di strutturazione significativo, vengono contrapposti i tessuti composti di case, villini e palazzine dove si registra, invece, l’assenza di un legame fra i tessuti urbani e i tipi edilizi, prevedendo, quindi, una decisa politica di ristrutturazione urbanistica. A quest’ultima categoria viene fatto appartenere anche il quartiere Arianuova poiché, pur chiaramente pianificato, risulta caratterizzato da tipi edilizi non sempre congruenti con il tessuto urbano.
 |
 |
 |
| addizioni |
consolidamenti |
incrementi |
Complessivamente il piano regolatore vigente prevedeva un’espansione residenziale in zone omogenee C per una superficie di 4.037.083 mq; di questi ne sono stati attuati 2.841.365 mq (pari al 70%), parzialmente attuati risultano invece essere 412.826 mq (pari al 10%), mentre rimangono ancora da attuare aree per una superficie complessiva di 782.891 mq (pari al 20%).
 |
 |
 |
| L'articolazione dei tessuti residenziali nel Piano Regolatore vigente |
Le altezze previste dal Piano Regolatore vigente |
Gli insediamenti residenziali previsti e realizzati dal Piano Regolatore vigente |
| |
 |
 |
| Gli insediamenti produttivi previsti e realizzati dal Piano Regolatore vigente |
I servizi previsti e realizzati dal Piano Regolatore vigente |
|
Per quanto riguarda le aree produttive, risultano parzialmente attuate aree per una superficie di 2.760.735 mq, mentre rimangono da attuare 965.881 mq. La capacità edificatoria residua del piano vigente risulta quindi cospicua: 78 ettari destinati ad aree residenziali e 97 ettari ad attività produttive. L’attuazione degli standard previsti nelle aree di espansione residenziale (zone C) e produttive (zone D) ha seguito, ovviamente, l’andamento attuativo dei relativi ambiti di P.R.G., quantitativamente rilevante, almeno sotto il profilo contrattuale, nel centro urbano, più debole nei centri del forese. Di conseguenza, si è andata ulteriormente divaricando la dotazione di servizi fra il centro e le frazioni, soprattutto quelle più lontane. Qualitativamente, salvo poche eccezioni, prevalentemente nei comparti più ampi, gli standard di verde, e più in generale gli spazi pubblici attuati o in corso di attuazione, risultano notevolmente frazionati e marginali rispetto agli insediamenti ed incapaci di costituire tessuti e reti di connessione dimostrando l’inefficacia degli strumenti normativi e gestionali posti a tutela della qualità insediativa. La mancata adozione del Piano di Attuazione dei Servizi e i vincoli procedurali imposti dalla legislazione in materia di opere pubbliche hanno in generale addossato al Comune la realizzazione delle infrastrutture di scala urbana, rendendo difficoltoso il coordinamento temporale e funzionale con l’attuazione degli insediamenti privati, tutto delegato alla programmazione finanziaria di settore. E’ imponente la realizzazione in corso delle infrastrutture viabilistiche, sia da parte comunale che da parte di altri enti pubblici, tanto che possiamo affermare che il quadro infrastrutturale di settore è sostanzialmente in via di completamento e per alcuni aspetti, quali la ferrovia suburbana, addirittura più avanzato delle originarie previsioni di P.R.G. Risultano invece in generale inattuati i vincoli preordinati all’acquisizione di aree per standard di quartiere (zone G) e per grandi servizi di scala urbana e territoriale (zone F). Risorse importanti sono state impiegate per l’attrezzatura, il miglioramento e la qualificazione delle aree a servizi acquisite in passato: basti pensare ai lavori di restauro delle Mura e del relativo vallo, all’arredo del Parco Urbano, al restauro dei parchi Massari e Pareschi da parte del Comune; alla realizzazione del Polo Scientifico Tecnologico e della Facoltà di Architettura da parte dell’Università. Non si è tuttavia proceduto a nuove rilevanti acquisizioni di aree, se si fa eccezione per l’esproprio, di importanza strategica, del vallo sud delle Mura e per l’acquisto, anch’esso importante, del giardino delle Duchesse. I bassi valori applicati alle monetizzazioni di standard nelle zone A e B non hanno consentito di reperire risorse sufficienti, data la vigente disciplina degli espropri, per effettuare le necessarie acquisizioni. Il medesimo basso livello tariffario e la mancata adozione del Piano di Attuazione dei Servizi non hanno d’altra parte incentivato l’utilizzo dei meccanismi perequativi e di traslazione delle cessioni di standard che pure sono previsti dalla normativa di attuazione. Nel contempo, le incertezze nelle politiche di dismissione dei beni del Demanio statale hanno ritardato notevolmente l’acquisizione di aree strategiche nel centro storico e nella zona sud del centro urbano. In conclusione, è possibile affermare che nel periodo di attuazione del vigente P.R.G. si è assistito ad un aumento della dotazione di standard di vicinato nel centro urbano, pur con caratteristiche qualitative insoddisfacenti, mentre i grandi servizi di scala urbana hanno visto un rilevante processo di riqualificazione dell’esistente, pur con aumenti limitati sotto il profilo quantitativo.
Accanto alla lettura del piano regolatore vigente, delle sue ipotesi e del suo grado di attuazione, abbiamo ritenuto importante provare a ricostruire anche il quadro delle scelte di trasformazione in un’area più vasta. Attraverso il mosaico dei piani regolatori vigenti del territorio che circonda Ferrara, abbiamo cercato di costruire uno sfondo sul quale poter collocare le opzioni del Documento Preliminare del PSC, un quadro con il quale quest’ultimo deve necessariamente confrontarsi per cogliere le coerenze o le incompatibilità. Abbiamo selezionato quattro temi: le espansioni residenziali, le espansioni per insediamenti produttivi, le nuove infrastrutture, ed infine le opzioni sul paesaggio. Per ciascuno di questi temi abbiamo costruito una mappa che rappresenta lo stato di fatto e le previsioni future riportate nei piani regolatori o nei piani sovraordinati.
Alcune immagini dell’area vasta ferrarese
Seguendo le dinamiche di molti altri territori, anche Ferrara negli ultimi decenni registra un calo di abitanti associato però ad un contemporaneo aumento dei nuclei famigliari e ad un processo di invecchiamento della popolazione. Condizioni queste che portano la politica urbanistica a non poter essere solo soluzione a posteriori di problemi dati, com’era nel caso del sovraffollamento ad esempio, ma a dover essere soprattutto una politica attiva: immaginare interventi residenziali ed urbani capaci di attrarre nuove popolazioni, predisporre un ambiente di vita attraente, immaginare il futuro, lavorare sul lato dell’offerta piuttosto che su quello della domanda. Dal punti di vista economico-sociale, l’area ferrarese può oggi essere ritenuta parte di un più ampio sistema territoriale definibile come "grande delta" (Ravenna, Ferrara, Rovigo) che però per altri versi si spinge verso l’interno della pianura padana comprendendo Mantova e Cremona. Un’ambito territoriale che sta seguendo suoi specifici processi di sviluppo, differenziandosi dagli andamenti che hanno caratterizzato da un lato l’asse pedemontano lombardo-veneto (Bergamo-Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Treviso-Udine) e dall’altro il sistema della via Emilia. In particolare, il sistema economico-produttivo di Ferrara si caratterizza per l’emergere di una sorta di "equilibrio produttivo", che sostituisce alla classica dicotomia grande industria-agricoltura, una più variegata struttura economica dove assumono un peso rilevante diversi settori produttivi (media e piccola impresa, grande distribuzione, turismo, artigianato e servizi, istruzione superiore) ed emergono quindi anche nuovi attori sociali e si formano nuove popolazioni. L’andamento positivo registrato negli ultimi anni a Ferrara, soprattutto nel settore industriale e in quello dei servizi e del commercio, ha spinto verso un riequilibrio della composizione della struttura produttiva, nella quale si registra anche l’aumento di occupati nel settore alberghiero e dei pubblici esercizi, segnale del trend positivo del settore turistico. Fra il 1999 e il 2000 la crescita occupazionale è stata più marcata a Ferrara (+1,2%) che nella media regionale e nazionale (+0,7%), consentendo di raggiungere tassi di disoccupazione che si avvicinano alla media regionale. Soprattutto l’occupazione nel settore terziario (e in esso della forza lavoro femminile) ha fatto segnare interessanti dinamiche positive, che si inseriscono in un più ampio fenomeno di terziarizzazione registrato da quasi tutto il Nord-Est del paese. Anche l’Università negli anni più recenti ha contribuito a garantire positivi trend di sviluppo a Ferrara, mostrando soprattutto una buona capacità attrattiva non solo nei confronti della popolazione locale, ma anche nei riguardi della popolazione residente al di fuori della provincia. Questa capacità di attrazione dell’Ateneo, legata alla crescita della domanda di istruzione universitaria, può costituire anche un elemento di contrasto dell’attuale calo demografico, consentendo negli anni una buona dinamica della popolazione giovane. Da questi dati non emergono gravi carenze economico-sociali o gravi problemi regressi da risolvere. Piuttosto emerge l’immagine di Ferrara come città non specializzata ma equilibrata tra diversi settori produttivi (e quindi anche tra diverse popolazioni): un equilibrio ovviamente sempre instabile, raggiunto attraversando alterne vicende, e che oggi fa di Ferrara una città "plurale", caratterizzata da una buona "biodiversità" sociale. Date queste condizioni (di relativo benessere) non sembra più possibile seguire una politica urbanistica unicamente di tipo "problem solving", ma diventa necessario sempre di più una politica attiva rivolta al futuro, una politica volta ad attrarre popolazioni ed investimenti offrendo non solo case ma un ambiente di vita, un milieu completo e complesso fatto di case, servizi, attrezzature, infrastrutture e verde.
Ciò vuol dire che queste ricerche sulle condizioni economiche diventano parte di una riflessione relativa al ruolo di Ferrara nell’area vasta, ragionando non solo in termini fisico-spaziali ma anche funzionali, ragionando sulle possibili interrelazioni che Ferrara può attivare con un suo ampio intorno. Pensando che forse non è tanto interessante cercare sinergie con centri inseriti in altri contesti territoriali (come la via Emilia o l’area centrale veneta) quanto piuttosto con città come Ravenna, Rovigo, Mantova, ecc., che presentano maggiori affinità e contribuiscono a formare una sorta di grande territorio intermedio padano. Sviluppare reti di relazione tematiche (Università, chimica, turismo, energia, gestione dei servizi pubblici, ecc.) sapendo che in futuro non ci saranno da soddisfare solamente i bisogni dei cittadini residenti ma anche di un più variegato spettro di popolazioni temporanee (studenti, visitatori, professionisti che svolgono lavori temporanei, ecc.) che da un lato costituiscono una spesa ma dall’altro creano ricchezza collocando Ferrara in una rete più ampia. Se stando ai dati demografici e occupazionali, non si registrano forti differenze con gli altri poli regionali, emerge però chiaramente che Ferrara non ha nel suo immediato intorno (data anche l’ampia dimensione del territorio comunale) una cintura di comuni metropolitani, non ha portato allo sviluppo di una agglomerazione più larga, chiaramente individuabile invece attorno a numerosi poli di sviluppo veneti ed emiliani (Verona, Padova, Modena, Reggio). Già oggi però per converso, Ferrara intrattiene numerose relazioni con altri centri urbani, definendo alcune "costellazioni" tematiche (le reti della chimica, del turismo, dell’Università), reti di collaborazione e coesione che possono formare un dinamico sistema territoriale. Pensando che oggi non ha senso seguire a forza modelli di sviluppo estranei, ma diventa interessante coltivare le proprie specificità: non inseguire chimeriche specializzazioni ma prestare attenzione all’equilibrio tra i settori produttivi (economico-sociali), pensando ad una città che "cresce insieme", che fa della sua articolazione una forza.
|