 |
|
PSC di Ferrara. RELAZIONE bozza
|
Indice della relazione
0. Ruoli e campi d'azione del Piano Strutturale Comunale
1. Sul posto e ruolo occupati da Ferrara: immagini d'area vasta
2. Sull'idea di qualità diffusa come "bene comune": tre proposizioni guida
3. Il funzionamento della città: prestazioni e dimensionamento
4. Luoghi e azioni del piano
5. Forme e procedure di gestione della città
6. Alcune opportunità di costruire la città del futuro
|
PREMESSA
Questa relazione costituisce parte integrante del Piano Strutturale Comunale della
città di Ferrara.
Il Piano Strutturale Comuale è uno degli strumenti di governo del territorio che
previsti dalla recente riforma urbanistica regionale (legge regionale 20/2000)
assieme al Regolamento Urbanistico Edilizio ed ai Piani Operativi.
Come solitamente accade, il processo che porta alla definizione di uno strumento
urbanistico generale è lungo e complesso. A maggior ragione in questo caso dove si
è trattato di associare, alle questioni proprie della pianificazione, anche gli aspetti
problematici derivati dall'applicazione di una nuova ed innovativa disciplina del
territorio.
Le novità introdotte dalla legge regionale sono molteplici, ed articolate sono le
risposte che ad esse si possono dare.
Nel Piano Strutturale Comunale di Ferrara si è scelto di percorrere alcune strade:
- quella di una partecipazione continua ed assidua della comunità locale
alla costruzione del piano;
- quella di modelli di gestione e attuazione che puntano alla flessibilità e
alla governabilità dei processi utilizzando appieno le opportunità offerte dal doppio
livello di pianificazione (e quindi dai Piani Operativi);
- quella di un meccanismo perequativo con l'obiettivo di redistribuire parte
della rendita fondiaria e acquisire le aree destinate ai servizi.
Il percorso di costruzione del Piano Strutturale ha avuto inizio con il Documento
degli Obiettivi (presentato in Giunta nel marzo 2002) nel quale si delineava la
proposta metodologica per la costruzione del piano e alcune prime suggestioni sul
territorio ferrarese.
La fase successiva è stata caratterizzata dal parallelo lavoro di costruzione del
Quadro Conoscitivo, del Documento Preliminare e di una prima Valsat (valutazione
ambientale strategica delle scelte di piano). In questa fase la partecipazione alla
costruzione del piano ha assunto diverse forme: le settimane dell'ascolto, i seminari
tematici, gli incontri all'Urban Center. Alla conclusione dei lavori, gli strumenti
prodotti hanno costruito la base su cui prefigurare l'Accordo di Pianificazione con
la Provincia che rappresenta il primo atto di approvazione delle scelte del piano.
Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione dell'Accordo di Pianificazione, ha
verificato i contenuti del Documento Preliminare esprimendo alcune valutazioni che
hanno assunto il valore di "atti di indirizzo" per la elaborazione del Piano Strutturale
riportate di seguito.
1) La scelta di privilegiare la riqualificazione dei tessuti esistenti e il
recupero delle aree dismesse (lavorare sulla città esistente), le connessioni
ambientali, il potenziamento e la valorizzazione del Parco Urbano, la
creazione di reti ecologiche, la valorizzazione ambientale delle aree agricole
periurbane, l'individuazione delle aree con funzioni di compensazione a
tutela degli insediamenti a elevato impatto ambientale già esistenti, il
riconoscimento del carattere strutturale (quindi da riconoscere nel PSC) del
rilievo paesaggistico della vegetazione (quali alberature, siepi e piantate..),
costituiscono i presupposti metodologici generali del nuovo piano strutturale
in corso di elaborazione.
2) Gli elaborati complessivi alla base dell'accordo di pianificazione,
pur sufficienti a delineare i caratteri della strategia per la formazione del PSC,
presentano ancora una carenza di indicazioni e di obiettivi per le aree non
interessate dalle principali strategie annunciate dal Documento preliminare,
pur rappresentando parti importanti del territorio del forese. Il PSC dovrà
delineare una strategia volta a contrastare e invertire la tendenza alla perdita
di ruolo, vitalità e identità delle frazioni del territorio, arrestarne il declino
demografico, consolidarne la struttura dei servizi una volta individuata
e accertata l'esigenza specifica. Residenza e servizi si devono reggere a
vicenda. Il PRG del 1995 aveva previsto una ampia potenzialità di sviluppo
dei centri del forese, con grandi capacità edificatorie ancora in larga parte
inutilizzate, mettendo in luce una sostanziale debolezza degli strumenti
di attuazione del Piano. E' utile che il nuovo piano analizzi e reinvesta le
capacità edificatorie fin qui non utilizzate finalizzandole a un nuovo disegno
delle frazioni e a un più stretto rapporto con la dotazione dei servizi, e per
colmare il deficit di infrastrutture primarie ancora presente, introducendo
più efficaci strumenti gestionali.
3) L'aspirazione alla crescita dei centri del forese non interessati dalla
direttrice di sviluppo Est Ovest può essere sostenuta da una valorizzazione
delle risorse presenti: le potenzialità ambientali e paesaggistiche delle riviere
del Po, del Po di Volano e del Po di Primaro, le attività legate all'agricoltura
(produzione, conservazione e trasformazione, agriturismo), l'artigianato
presente nei centri del forese che deve avere la possibilità di crescere senza
trasferire in città.
4) Il PSC dovrà affrontare il tema dell'accesso alla casa, individuando
modalità e risorse per localizzare e promuovere edilizia economica e popolare
di qualità e per rendere accessibile anche ai redditi medio bassi il mercato
delle abitazioni in affitto.
5) Il PSC e il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) dovranno
promuovere una edilizia di qualità basata su elevati parametri di risparmio
idrico e energetico.
6) Particolare attenzione dovrà dedicare il PSC alla definizione del
ruolo e del carattere delle aree cerniera tra le mura e il Volano, coniugando
la definizione delle funzioni coerenti con il ruolo indicato nel Documento
preliminare con le esigenze di una forte attenzione alle modalità operative
con le quali si realizzano le trasformazioni, perseguendo l'obiettivo di
valorizzazione delle mura e dando carattere strutturale anche alle scelte
progettuali se ritenute necessarie a garantire l'armonizzazione con il
tessuto storico esistente. In questo senso appare essenziale riconoscere
l'area oggetto di tutela Unesco e definire le ricadute normative coerenti con
il Piano di Gestione.
7) La scelta di esaurire la fase di espansione ad Est, va accompagnata
dalla piena assunzione delle problematiche che restano inevase alla luce
dello stato di attuazione del PRG del 1995. L'espansione residenziale che il
Piano aveva previsto nella periferia est della città è in via di realizzazione
pressochè totale, mentre resta sostanzialmente inattuata la parte di
previsione relativa ai servizi. Una carenza che appare rilevante a fronte di
un incremento di popolazione giovane e in età attiva. Particolare attenzione
dovrà quindi porre il PSC nella localizzazione di un adeguato sistema di
servizi, soprattutto di quelli per l'infanzia e della scuola dell'obbligo, ma anche
degli altri servizi di quartiere che (tranne la dotazione commerciale) non
hanno trovato spazio dentro le aree di nuova espansione fin qui realizzate.
Altrettanta attenzione andrà posta al tema degli strumenti attraverso i quali
garantire l'effettivo reperimento delle aree necessarie e alla realizzazione
dei servizi stessi.
8) Il PSC dovrà approfondire e meglio definire il tema dei collegamenti
e della mobilità del quadrante Nord/ovest della città, (attraversamento del
Po, collegamento con l'asse autostradale, localizzazione delle piattaforme
intermodali) e sviluppare le relazioni tra questi aspetti e l'esigenza di
dare compiutezza all'assetto dell'abitato di Pontelagoscuro soprattutto
individuandone le funzioni di connessione tra Città, parco urbano e fiume.
9) La variante generale del quadrante sud del capoluogo approvata
nell'aprile del 2004 e le scelte essenziali adottate sull'area demaniale hanno
rappresentato un momento importante di anticipazione e verifica della
strategia delineata dal Documento preliminare, queste scelte richiedono di
essere coerentemente completate con l'adozione delle misure necessarie a
garantire le aree di compensazione, ad acquisire le aree del Parco SUD e a
realizzare gli interventi per il ripristino della efficienza idraulica del territorio,
e con la coerente predisposizione del piano attuativo dell'area Foro boario-Stazione di Porta Reno. Andrà fatto inoltre un bilancio complessivo dei
risultati della scelta del piano del '95 di assegnare elevati indici per sostenere
la riqualificazione dei comparti che affacciano sulla via Bologna.
10) La strategia di sviluppo sostenibile volta a limitare il consumo
di nuovo territorio, a controllare e regolare verso la sostenibilità le forme
della sua artificializzazione, trovano nel riuso dell'area industriale del polo
chimico, nella progressiva riduzione dei suoi livelli di impatto ambientale, nel
rispetto degli impegni già assunti da questa Amministrazione in relazione
all'indisponibilità ad accogliere nuovi impianti ad alta pericolosità (SEVESO
II)e nel continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, uno degli
obiettivi fondamentali. Tale scelta va confermata collocandola entro un
ambito di coordinamento territoriale delle scelte di localizzazione delle nuove
aree di insediamento produttivo che deve essere dato da un nuovo PTCP. In
questo senso la nuova articolazione della strumentazione urbanistica tra
PSC che indica e localizza le ipotesi di trasformazione di lungo periodo e il
POC che non solo determina le scelte del quinquennio ma ne indica anche
le modalità (indici, modalità operative etc) permette di evitare il rischio che
la previsione di ambiti per nuovi insediamenti produttivi che il Documento
preliminare prefigura e che il PSC dovrà prevedere, contraddica la scelta
di operare innanzitutto per la riutilizzazione delle aree dismesse, da
recuperare e riutilizzare attraverso i percorsi di bonifica previsti dall'accordo
di programma sul Petrolchimico, e per l'utilizzazione delle ancora consistenti
aree residue del piano del '95 e sue successive varianti.
11) Fin dalla fase successiva all'approvazione dell'accordo di
pianificazione dovranno essere riaperti e allargati la consultazione e il
confronto pubblico per la definizione del PSC, dando continuità al metodo di
partecipazione praticato per la predisposizione del Documento preliminare
(e alle modalità con le quali già in occasione della mostra sulla "Bozza di
documento preliminare", si sono tradotte in immagini e linguaggi accessibili
analisi e proposte pur complesse sul piano tecnico) al fine di garantire la più
ampia trasparenza delle scelte sul futuro della Città.
Le fasi successive hanno, tra l'altro, cercato di interpretare tali indirizzi:
- completando gli elementi di conoscenza delle questioni ambientali e
facendole diventare uno dei centri tematici del nuovo piano (nel "Sistema ambientale
e delle dotazioni territoriali" e nella "Rete del verde");
- delineando con precisione le linee di sviluppo previste per tutto il territorio
con particolare riguardo al consolidamento delle strutture insediative del forese, alla
progettazione di una "nuova centralità" nella fascia compresa tra le mura e il Volano,
al ridisegno delle aree per servizi nella zona ad est, infine, alla organizzazione del
sistema degli accessi al centro città da ovest ed al suo collegamento con il sistema
autostradale;
- fissando gli obiettivi di qualità dei nuovi insediamenti e degli interventi
edilizi già nei modi in cui vengono definiti i singoli strumenti : il piano strutturale
con il disegno dei "Luoghi e delle azioni", il Regolamento Urbanistico ed Edilizio con
la suddivisione delle regole in "Strati tematici", i piani operativi con la previsione dei
comparti di intervento e dei "Progetti norma";
- definendo precise modalità per l'acquisizione delle aree per servizi
all'interno della previsione dei nuovi insediamenti (attraverso gli strumenti della
perequazione e dei comparti urbanistici);
- prevedendo le aree per i nuovi insediamenti produttivi a completamento
di quelli già esistenti al fine di favorire una politica di recupero delle aree esistenti e
di basso consumo di territorio;
- costruendo modalità di consultazione sia di tipo seminariale (con
i numerosi incontri sulla "forma del piano"), sia di partecipazione diretta alla
costruzione del piano attraverso l' "Avviso di pubblicazione del Documento
Preliminare del PSC ai fini della presentazione di proposte di progetti e inziative di
interesse per la comunità locale".
In particolare, quest'ultimo punto ha rappresentato uno specifico momento di
partecipazione della comunità locale alla verifica delle scelte del Documento
Preliminare e un ulteriore arricchimento del programma del PSC. L'Avviso è stata
una iniziativa svolta a cavallo dell'estate 2005 che ha chiesto alla comunità
ferrarese di proporre interventi di trasformazione del territorio coerenti con le linee
guida proposte dal Documento Preliminare. La partecipazione all'iniziativa è stata
significativa. Sono state presentate infatti circa 500 proposte, la maggior parte
delle quali ha avuto come oggetto la richiesta di edificabilità dei suoli. Circa 80
proposte sono state considerate condivisibili e quindi inserite, secondo differenti
modalità, nel PSC. Altrettante (ca.80) hanno riguardato la richiesta di edificabilità
su aree destinate ai servizi (città verde, riqualificazione ambientale, ecc.) e perciò
sono state parzialmente soddisfatte dall'inserimento nel meccanismo perequativo
di distribuzione dei diritti edificatori relativo a tali aree. Una quota consistente (ca.
40 proposte) ha avuto come oggetto un rinvio della valutazione alle successive
fasi operative (del RUE e dei POC), poichè non di competenza del PSC.
Questo percorso di costruzione del piano ha portato alla proposta di PSC che è
contenuta nelle pagine seguenti. Essa parte dal riconoscimento di alcuni principi
che derivano dalla lettura e interpretazione della città di Ferrara all'interno di un più
generale quadro di riferimento di area vasta.
Una particolare attenzione è stata posta alla "forma" del piano. Cioè alla definizione
dei materiali di cui si compone il PSC e dei rapporti tra i diversi livelli della
pianificazione (RUE e POC). E' questo un aspetto che assume rilevanza in funzione
sia delle innovazioni introdotte dalla riforma regionale (LR20/2000), sia alle
riflessioni che le discipline del territorio stanno facendo sul ruolo e il futuro delle
città contemporanee.
|
|
0. Ruoli e campi d'azione di un Piano Strutturale
|
La redazione di un piano costituisce frequentemente occasione di riflessione di
una città e della società che la abita su se stessa.
Non è quindi solo un atto ed uno strumento tecnico-giuridico, ma anche espressione
del clima culturale di un’epoca e di una comunità.
Per questa ragione, sovente un piano e soprattutto il periodo della sua redazione,
sono investiti da parte della comunità insediata, d’attese e di ruoli che esulano
quelli prettamente tecnico-urbanistici: al piano viene chiesto di rendere vivibile,
bella, sicura e giusta la città, andando ben oltre i suoi reali scopi e possibilità, e ciò
forse testimonia la voglia e l’interesse di una comunità a discutere di se stessa e
del suo futuro, senza rassegnarsi a demandare ad altri il proprio destino.
Il piano si trova così ad essere compresso tra due diversi atteggiamenti; da un lato
viene sovraccaricato di tutti i problemi presenti in città, come se fosse una sorta
d’enciclopedia delle politiche pubbliche; dall’altro tende ad essere ridotto ad una
serie d’indicazioni su ciò che si può o non si può costruire o trasformare.
Ecco perché, sempre più di frequente, un piano tende a diventare chiarimento delle
linee d’azione che un’amministrazione-comunità si vuol dare oltre che momento
e strumento con il quale mettere in relazione i diversi tavoli di lavoro già attivi,
provocando una maggiore coerenza tra i diversi atti politico-amministrativi.
Sovrapposto uno all’altro questi aspetti delineano un’interessante e caratteristica
configurazione del piano: la sua capacità di dare precise risposte tecniche a specifici
problemi, di delineare scenari e strategie di lungo periodo oltre che costruire e
definire le condizioni per la “coesione delle politiche”.
Considerando i differenti ruoli che la comunità insediata tende ad attribuire ad un
Piano Strutturale, a Ferrara si è ritenuto adeguato contenerne il campo d’azione,
riportarlo ad una dimensione maggiormente pragmatica, ad esempio tenendo sullo
sfondo gli obiettivi generali del lavoro, evitando di affermare anticipatamente che
il piano è sostenibile, attento alla qualità, rispettoso dell’ambiente, equo e solidale,
e cercando di farne emergere gli specifici caratteri dalle scelte, dai progetti e dalle
azioni previste.
Queste considerazioni hanno sospinto a non raccontare e descrivere il nuovo PSC
di Ferrara dichiarando obiettivi generali ed astratti che assai di frequente risultano
troppo facilmente condivisibili, quanto piuttosto a ragionare sulle condizioni e le
potenzialità di questo territorio senza immaginare di sovrapporgli una nuova
razionalità estranea ed astratta, ma considerando la situazione specifica e
concreta di Ferrara per provare a delineare obiettivi pertinenti a questa situazione,
prospettandone subito una possibile “forma”, traducendoli e verificandoli in precisi
progetti. Da qui l’importanza assunta dal progetto fin dall’avvio della redazione
del PSC come attività d’esplorazione delle possibilità, di verifica delle fattibilità,
per precisare le condizioni e far uscire subito dal vago le questioni, proponendo di
discutere scelte e possibilità concrete.
Questo anche per non dare obiettivi irrealistici quali far diventare la città di Ferrara
come Reggio Emilia o Padova, competere con Venezia o Firenze, diventare una
metropoli come Milano o piccolo centro esclusivo come Pienza o Cortina, ecc. ma
per definire degli obiettivi “su misura” per Ferrara.
|
|
a. Tempi della città e tempi nel PSC
|
Contemporaneamente a questa riflessione, nella consapevolezza che la comunità
insediata che chiede al Piano di “prendere parte”, di schierarsi rispetto ad alcuni
obiettivi di grande respiro è una società dominata dall’incertezza, nella quale
l’orizzonte del futuro si è sempre più ridotto in tutti i settori, dall’economia alla
politica, e che tende a dedicare grande attenzione agli elementi congiunturali, ci si
è interrogati e scontrati con la difficoltà e al limite la contradditorietà di immaginare
e lavorare ad un Piano Strutturale che stando alle indicazioni della nuova legge
urbanistica regionale e al dibattito disciplinare dovrebbe avere durata indefinita,
dovrebbe governare la città fintanto che le condizioni non mutano radicalmente.
Infatti, il PSC dovrebbe essere teso non solo all’individuazione e tutela delle risorse
naturali-ambientali che articolano il territorio, ma principalmente al riconoscimento
delle “invarianti” che connotano un dato contesto, delineando la politica territoriale
dell’amministrazione comunale nel tempo lungo, indirizzando e precisando forme
e modi di sviluppo sostenibile, presentandosi quindi come scenario complessivo ed
insieme selezione di precisi progetti prioritari.
Un insieme di caratteri che il PSC dovrebbe perseguire, nonostante lo spazio
che abitiamo sia in continua trasformazione e, come una sorta di palinsesto, sia
soggetto a continue riscritture e reinterpretazioni che rendono complessa la ricerca
di invarianti.
Un secondo tema di riflessione, che attiene alla dimensione temporale del PSC,
riguarda il rapporto tra la sua presunta durata indefinita e l’inevitabile prospettiva
di riqualificazione della città e del territorio entro cui un piano oggi si colloca.
Infatti, le condizioni demografiche, economiche, ambientali che caratterizzano
la contemporaneità sospingono ad indirizzare le politiche di trasformazione
territoriale verso una dimensione di miglioramento e riqualificazione piuttosto che
di espansione.
|
|
b. Un percorso di lavoro ed alcune questioni
|
Muovendo da queste riflessioni, il percorso di lavoro seguito in questi quattro anni
ha attraversato diverse fasi: dall’indagine sulle morfologie fisiche, economiche e
sociali della città al suo funzionamento ambientale, dalla conoscenza dei fenomeni
alla costruzione di scenari in grado di costituire l’orizzonte di riferimento di progetti
specifici, dalla ricognizione sullo stato della pianificazione esistente alla definizione
di un processo di partecipazione sugli specifici obiettivi del PSC che attraverso
numerosi incontri e discussioni con gruppi sociali, associazioni di categoria ed
il forum di Agenda 21 locale ha permesso di evocare interpretazioni, attese e,
complessivamente, di rendere evidente l’immaginario collettivo della città.
Tenendo sullo sfondo tali riflessioni si è andato precisando un atteggiamento nei
confronti di alcune questioni.
Conoscenza/progetto. L’articolazione del PSC sottende l’idea di uno specifico
rapporto fra conoscenza, indagine ed attività progettuale. Da un lato, le attività di
analisi non hanno rappresentato solamente una fase preliminare del lavoro, ma si
sono sviluppate, con una propria autonomia, per l’intero percorso di costruzione del
Piano. Dall’altro, l’attività di progettazione, considerata come una particolare forma
di indagine, è stata avviata fin dalla fase iniziale, contribuendo alla precisazione di
temi e problemi e alla conoscenza dei diversi ambiti urbani.
Se è vero che in questi anni è stato seguito un ordine “classico” per raccontare
le varie fasi del Psc (analisi, obiettivi, progetti), dovuto principalmente alla legge
urbanistica regionale che chiede, ad esempio, di porre al centro della Conferenza
di Pianificazione il Quadro Conoscitivo, è utile chiarire però che il lavoro svolto è
stato ben più integrato e ciclico, difficile da restituire in una semplice sequenza
lineare di causa effetto (dalle scelte al progetto, dagli obiettivi all’analisi), è
fatto piuttosto di una continua interazione tra obiettivi-progetto-analisi. C’erano
certamente degli obiettivi e dei “problemi sul tappeto” che l’amministrazione ha
posto invitando ad un atteggiamento di tipo “problem solving” (ho un problema,
chiamo il tecnico per risolverlo), ma anche molte questioni che sono state
progressivamente riproblematizzate (reinterpretate e riviste chiedendosi ogni volta
“cosa fa problema? In che senso quello è un problema per la città?). Inoltre, nel
corso della redazione del Psc sono emersi nuovi problemi, nuove questioni e nuovi
temi sono stati individuati: l’attività di redazione di un piano introduce nuovi temi
(ad esempio, la rete di connessione ambientale tra il parco nord e il futuro parco
sud; la città dell’automobile, ecc.) ed infine, la redazione del piano e soprattutto
l’attività di analisi e di esplorazione progettuale porta a tarare, a commisurare sulle
potenzialità (sociali e territoriali oltre che economiche) della città gli obiettivi, li
misura rendendoli praticabili e riducendone gli eventuali effetti perversi.
In questo senso obiettivi-analisi-progetto non si sono configurate come attività
separate o preliminari l’una all’altra.
Tempo del piano/tempo di trasformazione della città. Questi due tempi sono stati
considerati inscindibili e contestuali all’interno del processo di pianificazione. Anche
per questo motivo si è cercato di far interagire la formulazione del quadro d’insieme
strutturale delle politiche urbane con la necessità di avviare la progettazione di nodi
problematici in alcuni “luoghi sensibili”, oggetto di discussioni, in cui è possibile
cogliere alcune specifiche “occasioni” di trasformazione urbana. Si è trattato di
affrontare contemporaneamente differenti scale di progettazione, tra l’orizzonte
generale di riferimento e le esigenze immediate e particolari, tra i tempi del progetto
e quelli della trasformazione urbana, costruendo un quadro di coerenze possibili e
indagando quali strumenti utilizzare, quali soggetti coinvolgere e quali procedure
seguire.
Ambiente come questione trasversale. La continua interazione tra uomo e ambiente,
tra la vita di una comunità e il suo spazio, promuovono l’integrazione disciplinare e
si oppone alle settorialità entro cui si tende spesso a ridurre la questione ambiente.
Per questa ragione si è cercato di incrociare le riflessioni relative al funzionamento
ambientale con quelle relative alle diverse parti e sistemi territoriali, sovrapponendo
quanto più possibile le diverse conoscenze e i diversi saperi in modo da stabilire fra
loro legami e relazioni virtuose. La questione ambientale sembra acquistare oggi un
senso sempre più ampio e vago: ha a che fare con la bellezza del paesaggio, con la
salubrità dell’ambiente, con la sicurezza delle strade, ecc.
Ascolto e partecipazione come principio di lavoro. La partecipazione alla costruzione
del PSC della società locale, è stata intesa come rapporto con un soggetto attivo
con cui condividere continuamente interpretazioni e scelte entro un processo di
pianificazione che si è configurato non tanto come un programma prestabilito di
cui siano chiari fin dall’inizio tutti gli obiettivi, quanto piuttosto come un percorso
articolato durante le varie fasi di lavorazione.
Ma ascolto e partecipazione non solo come operazioni da svolgere durante la
redazione del PSC, ma anche fondamentale attività per la sua implementazione, per
la gestione delle trasformazioni della città e del territorio innescate dal PSC.
Riconoscere il consolidamento delle scelte precedenti. Perché la città si costruisce
nel tempo lungo, e non si può continuamente cambiare o invertire rotta, considerando
che coerenza e continuità sono spesso un valore quando si parla di costruzione
dello spazio urbano.
La città contemporanea è piena di “progetti interrotti”: va ricercata la possibilità
di portarli a termine, sapendo che spesso gli si può attribuire un nuovo senso,
un valore diverso anche da quello che avevano all’origine (molte caserme sono
diventate ottime sedi universitarie, palazzi aristocratici sono diventati sedi di
istituzioni democratiche, ecc.), le funzioni passano, l’architettura resta. Continuità
nelle scelte (almeno per portarle a compimento) o meglio, consapevolezza che gli
obiettivi devono confrontarsi e legarsi con quelli già definiti soprattutto quando c’è
continuità di attori e di idee.
Quindi Ferrara ha predisposto il nuovo PSC non solo per adempiere agli obblighi
della legge regionale, ma anche per altre ragioni: la necessità di risolvere alcuni
nodi del Prg vigente (portare a compimento ipotesi lì contenute ma che hanno
trovato difficoltà attuative), l’opportunità di collocare, entro un quadro generale di
riferimento, le trasformazioni di importanti parti di città già inserite in sei ambiti
di riqualificazione urbana (PRU-PRUSST), delineare un complessivo assetto
futuro della città tenendo conto delle trasformazioni nella sua struttura fisica e
socio-economica, facendo riferimento alla nuova Legge regionale che ne prevede
l’articolazione in Piano Strutturale, Piani Operativi e Regolamento Urbanistico
Edilizio. Senza dimenticare la progressiva messa a punto di nuovi indirizzi regionali
che spingono a salvaguardare, qualificare, e valorizzare il territorio regionale
nelle sue componenti fisiche, paesaggistiche, infrastrutturali, insediative, sociali
e produttive riconoscendo nelle politiche territoriali un fattore fondamentale
per conseguire gli obiettivi di coesione sociale, benessere collettivo e capacità
competitiva dell’economia, con la progressiva convergenza fra pianificazione
territoriale e programmazione economica al fine di governare la complessità delle
dinamiche del sistema regionale.
“(...) In coerenza con gli indirizzi internazionali, europei, nazionali, la Regione Emilia-
Romagna assume l’obiettivo di sviluppo sostenibile per guidare l’azione di governo.
Esso viene perseguito dal PTR con il miglioramento della qualità, dell’efficienza e
dell’identità territoriale. (..) L’integrazione della sostenibilità ambientale con la
sostenibilità economica e sociale porta alla necessità di incorporare nelle scelte
degli obiettivi di sviluppo del sistema regionale il reale valore dell’ambiente e
delle sue risorse. In estrema sintesi si tratta di definire strategie di coevoluzione
programmata tra sviluppo economico, trasformazioni territoriali e uso delle risorse
ambientali.” (SCHEMA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO REGIONALE. DOCUMENTO
PRELIMINARE. Opzioni strategiche per l’aggiornamento del PTR vigente, Allegato alla
Delibera della Giunta Regionale 16 febbraio 2005 n. 360)
|
|
1. Sul posto e ruolo occupati da Ferrara: immagini d'area vasta
|
Per iniziare a descrivere le scelte di trasformazione che il PSC prevede per la città ed
il territorio di Ferrara, si è ritenuto importante avanzare alcune ipotesi sul posto e
ruolo che questa città occupa in un territorio più ampio. In altre parole ci si è chiesto
quali sono le “geometrie” che di volta in volta Ferrara disegna sul territorio svolgendo
il ruolo di città culturale, universitaria, polo della chimica, ecc.
Infatti, Ferrara è una città media che governa un territorio esteso. Tuttavia, se ci si
sforza di immaginare quale ruolo essa sarà in grado di svolgere nel prossimo futuro
si è spinti a chiarire il ruolo che svolge e può svolgere all’interno di contesti altri ed
assai più ampi.
Risulta complesso stabilire oggi quale sia l'ambito territoriale di una città, quale sia
la regione che influenza e da cui è, a sua volta, influenzata.
Da un lato le relazioni economiche e sociali, con i loro cambiamenti rapidi e continui,
sembrano ridefinire continuamente i ruoli tra le diverse parti del territorio: piccoli
centri periferici in pochi anni diventano dinamici distretti industriali, lungo le strade
extraurbane si sviluppano strutture commerciali che formano nuove centralità, ecc.,
dall'altro, l'assetto insediativo appare sempre più articolato e connesso e prendono
forma sistemi urbani reticolari, città lineari, sistemi policentrici interconnessi ed
integrati, sempre più difficilmente delineabili.
Stabilire i possibili confini di una "regione" ferrarese e di un suo ambito territoriale
chiaro significa confrontarsi con il sistema insediativo della pianura Padana che,
pur non funzionando ancora come un'unica grande megalopoli, nondimeno appare
articolato in ambiti urbani dai confini vaghi e da relazioni in continua evoluzione. Ad
esempio, negli anni recenti numerosi studi hanno evidenziato lo sviluppo policentrico
lineare attestato lungo la Via Emilia, la forte crescita del sistema insediativo ed
economico veneto caratterizzato da un assetto policentrico e soprattutto da
un'elevata dispersione, la formazione di una grande area metropolitana tra Milano
e la Brianza e un ulteriore articolato sistema insediativo che si sviluppa lungo
quasi tutto l'asse pedemontano da Novara a Pordenone. A questo quadro possiamo
aggiungere alcune città (Ferrara, Cremona, Mantova, Rovigo in particolare) che
appaiono relativamente isolate da questi sistemi e che tendono a sentirsi prive di
un loro preciso ruolo. D'altro canto però, Ferrara sembra aver reagito a questa sorta
di relativo isolamento, sviluppando e articolando la propria struttura economicoproduttiva,
tanto che, oggi, la dinamica compresenza di diversi settori produttivi
sembra aver assunto un proprio carattere positivo. Accanto al polo chimico (circa
1.800 addetti diretti) oggi si deve riconoscere l'importanza della piccola e media
impresa, delle attività artigianali e di servizio alla produzione, ed in generale
di imprese di altri settori produttivi che si sono sviluppate nelle diverse zone
industriali e artigianali presenti nel territorio comunale. Va sottolineato lo sviluppo
delle attività turistico-culturali, il ruolo dell'Università, nonché l'importanza delle
numerose attività commerciali che, se pur tra varie difficoltà conferiscono a Ferrara
un ruolo di centro attrattore, per finire con il peso ormai assunto dal settore dei
servizi pubblici e privati.
Oggi Ferrara sembra quindi essere un centro urbano abbastanza articolato, con una
struttura economica che non dipende da un unico settore produttivo e che offre
vari servizi di tipo turistico/culturale, sanitario e scolastico sia ad un immediato
intorno composto anche dei comuni contermini, sia ai diversi gruppi sociali che
usano il territorio definendo specifiche reti di relazione. Il ruolo universitario colloca
Ferrara nel network di città come Bologna e Padova, quello turistico la inserisce in
una rete, alternativa all’asse Roma, Firenze, Venezia, composta da un articolato
sistema policentrico di “città d’arte” come Mantova, Ravenna, Parma, Verona e
Treviso. Così, se è vero che confrontata con altre situazioni territoriali, come il
policentrismo e la dispersione veneta e l’insediamento lineare lungo la Via Emilia,
l’area ferrarese mantiene una sua precisa impronta ed un relativo distacco, facendo
emergere ancora in tutta chiarezza l’importanza della città rispetto ad un vasto
intorno agricolo e di piccoli ma dinamici centri, da un lato le dinamiche interne alla
città l’hanno portata a sviluppare una pluralità di settori economici rafforzando la
sua immagine di centro urbano, dall’altro le relazioni socio-economiche collocano
anche Ferrara entro una rete vasta ed articolata.
Osservando il sistema insediativo e le relazioni che Ferrara intrattiene con l'esterno,
sembra possibile riconoscere almeno due diverse immagini che non si negano a
vicenda, ma che, anzi, si integrano e devono essere considerate complementari.
Ferrara "piccola capitale". Il territorio ferrarese appare ancora caratterizzato dalla
netta distinzione dialettica città/campagna. La città principale sembra posizionarsi
al centro di una vasta area agricola costellata da piccoli centri che hanno conosciuto
in questi decenni una dinamica di diversificazione economica rimanendo, comunque,
strettamente legati ai servizi urbani forniti dalla città di Ferrara (dall'istruzione
superiore alla sanità, dagli uffici pubblici al commercio, ecc.).
Probabilmente ci troviamo di fronte ad un territorio, che, riprendendo una definizione
più volte proposta da Patrizio Bianchi, possiamo indicare come "grande delta", nel
quale sono riconoscibili chiare e precise gerarchie urbane tra la città principale e
una serie di centri satellite (Occhiobello, Copparo, Portomaggiore, Bondeno,
ecc.) che svolgono ruoli tra loro differenti.
Ferrara città in rete. Ferrara è però, oggi, anche una città inserita in una pluralità
di reti di relazione che coprono ambiti ben più vasti, specifici e differenziati. Ad
esempio, possiamo affermare che uno dei
territori di Ferrara è determinato dal "raggio d'influenza" della sua Università su
un territorio vasto che copre le province contermini, che la collega direttamente
a Padova e Bologna e la inserisce nel sistema delle città universitarie italiane. Ma
Ferrara è anche strettamente collegata a Mestre, Mantova e Ravenna dalla filiera
del petrolio, costituendo un nodo di un altro specifico sistema produttivo. Il turismo
definisce, poi, un ulteriore ambito, dai confini ancora più ampi ed incerti, ma che la
connette ad un'altra articolata rete.
Queste due immagini complementari si sovrappongono, definendo il profilo di
quella che, forse, possiamo considerare una tipica città media europea, che diversi
studiosi indicano come specifica del nostro continente, con particolare ricchezza
e qualità non riscontrabili altrove. Ferrara dovrebbe guardare a questa categoria di
città per trarre suggerimenti ed indicazioni utili per la messa a punto di un modello
di sviluppo che non insegua miti di grandeur ma, al contempo, non consideri il suo
relativo isolamento, la sua alterità, dettata dalla diversità dall'insediamento lineare
emiliano e dalla dispersione veneta, come un deficit.
Si dovrebbe inseguire un modello di sviluppo sostenibile per il futuro di Ferrara che
crei una città efficiente, capace di garantire ai suoi cittadini ma anche alle diverse
popolazioni che la abitano, la visitano e la usano, una qualità dell'ambiente di vita
tale da attrarre e produrre ricchezza.
Infatti, appare evidente che, accanto al continuo miglioramento dei servizi
specializzati offerti direttamente alle persone (servizi sociali e sanitari, scuole,
ecc.), le città dovranno sempre più rispondere ad una diffusa e articolata domanda
di "benessere urbano", offrendo alle diverse reti e filiere produttive cui vogliono
appartenere un buon ambiente di vita, considerato come supporto indispensabile
per l'avvio di nuove dinamiche, anche e soprattutto di "sviluppo senza crescita",
cioè riducendo il consumo di risorse non rinnovabili per evitare la dissipazione
dell'ambiente e del suolo.
Tra le grandi metropoli (Londra, Parigi, Berlino, ecc.) in competizione per garantirsi
la presenza delle grandi attrezzature, degli aeroporti, dei musei, delle principali
istituzioni economico-finanziarie, ecc. e la dispersione insediativa che interessa
regioni sempre più ampie in tutta Europa, molte città medie (Nantes, Montpellier,
Salisburgo, Lerida, ecc.) negli anni più recenti hanno avviato politiche urbane
integrate centrate sul ridisegno degli spazi pubblici e collettivi, sul recupero delle
aree dismesse, sul potenziamento del trasporto pubblico, ecc., volte a migliorare
la vivibilità complessiva della città, a garantire livelli di vita più elevati, maggiore
confort urbano, pensando che ciò sia intrinsecamente collegato alla possibilità di
avviare nuove fasi di sviluppo.
Emerge così per Ferrara il ruolo di città media, una città che deve ricercare qualità
nell’esistente puntando a rafforzare e intensificare le relazioni tra le parti. In questo
senso a Ferrara è la struttura urbana e territoriale a costituire il principale “bene
comune”: una struttura coesa capace di tenere insieme gli spazi, le funzioni e le
persone.
Solo uno sforzo progettuale che muova in questa direzione e che ricerchi per questa
struttura urbana una qualità diffusa ci può consentire di parlare ancora di una
visione unitaria della città.
|
|
2. Sull'idea di qualità diffusa come "bene comune": tre proposizioni guida
|
Assai di frequente, in un passato anche molto recente, si è pensato che il carattere
prevalente di una città dinamica fosse necessariamente il suo essere "in
espansione", ed il carattere principale dei suoi piani fosse di prevedere consistenti
ampliamenti dei tessuti urbanizzati.
Oggi, a fronte di dinamiche demografiche, economiche, insediative, ecc. assai
differenti rispetto a quelle del passato sembra necessario ridimensionare quest’idea
che appare sempre più un luogo comune da sostituire con immagini di sviluppo
qualitativo più che quantitativo. Infatti, le condizioni economiche, sociali, insediative
e ambientali a partire dalle quali immaginare il futuro di una città oggi spingono con
sempre maggiore forza ed intensità verso una prospettiva di innalzamento del livello
medio della qualità, ed in particolare a Ferrara si è ritenuto importante provare a
garantire per il futuro una maggiore “qualità diffusa”, immaginando un processo di
maturazione di tutte quelle parti della città costruite a partire dal secondo dopoguerra
e che necessitano interventi di potenziamento e riqualificazione ambientale, dei
servizi e delle attrezzature, della rete idraulica quanto della rete stradale. Interventi
che mirino a trasformare in città ciò che oggi non è considerato tale, quelle parti che
oggi sembrano condannate ad essere per sempre periferia.
Allo stesso tempo però, si è consapevoli che assai difficilmente si potrà accedere
a risorse aggiuntive da destinare a miglioramenti qualitativi dello spazio aperto e
costruito esistente; ed inoltre che mentre la nuova edificazione oggi è considerata
appetibile da più soggetti, un investimento garantito, altrettanto non avviene o
avviene in misura assai minore per gli interventi di miglioramento e riqualificazione.
E’ per questa ragione che il PSC di Ferrara cerca di sostenere e veicolare l’idea,
oltre che di esplorarla progettualmente e dal punto di vista della attuazione degli
interventi, secondo cui migliorare la qualità della città esistente significa oggi
investire sul suo welfare, sul suo benessere e su quello della società insediata
che ritornano così ad immaginare di poter costituire un proprio bene comune, un
patrimonio condiviso che diventa risorsa per il futuro della città. Infatti, investire per
una maggiore qualità spaziale diffusa contiene in se gli elementi per un maggiore
benessere sociale diffuso.
Se solitamente si tende a mettere in contraddizione una logica di investimento
incrementale legata ai piccoli interventi di singoli soggetti non coordinati tra loro,
con una di tipo strutturale caratterizzata dall'estensione dell'intervento, dalla
cospicuità dell'investimento e dal ruolo forte dei soggetti attivati, allora il PSC di
Ferrara si propone di eliminare o quanto meno attenuare questa contraddizione,
mostrando che la sommatoria di tanti piccoli interventi, investimenti e soggetti se
adeguatamente coordinati tra loro possono essere indirizzati verso un progetto
strutturale e di lungo periodo. La riflessione sulla qualità diffusa come prospettiva
generale del PSC è stata articolata in tre proposizioni guida che corrispondono ad
altrettanti obiettivi misurati sullo specifico contesto ferrarese.
|
|
a. Lavorare sulla città esistente.
|
La trasformazione di Ferrara prende le mosse dall'esistente riqualificandolo,
compattandolo. Seguendo questa ipotesi è nata l'idea di rafforzare l'asse est-ovest,
e per garantirgli maggiore sostenibilità è stato agganciato alla nuova linea di ferrovia
metropolitana.
La città del futuro sarà sostanzialmente quella esistente: considerando sia gli attuali
trend demografici sia le dinamiche dei (pur rilevanti) processi socio-economici.
Ciò significa principalmente non ricercare nuove "addizioni" urbane, accettare
l'impossibilità di fissare nuovi limiti urbani e una "forma" chiusa e predefinita, ma
trasformare il processo di metamorfosi della città esistente in un valore.
Lavorare sulla città esistente non vuol dire rinunciare ad immaginare nuovi futuri,
oppure costruire la città a misura della società esistente, ma partire da un progetto
che si sviluppi tra le sue pieghe e che sia capace di esplorare le potenzialità inscritte
nei diversi contesti per riscattare l'immagine spesso preconcetta che si ha della
città contemporanea.
Da qui anche l'idea di lavorare soprattutto sulle reti e connessioni più che su
l'aggiunta di nuovi insediamenti "esemplari".
Questa idea si fonda anche sulla sensazione che nei passati decenni di sviluppo
della città siano state destinate a nuova edificazione molte aree che ancora faticano
a diventare completamente parte integrante della città. Questi ambiti urbani, se
appaiono compiuti nella loro forma, tuttavia risultano ancora poveri di funzioni ed
usi: è allora importante aumentarne l'articolazione interna, il livello di "urbanità" e,
forse, la "biodiversità sociale". A questa prima ipotesi si ricollega l'opportunità offerta
dal recupero delle aree dismesse nell'ottica di una complessiva riqualificazione
urbana. Infatti, è proprio da questi contesti che possono prendere avvio procedure
amministrative di gestione che diventino occasioni per attivare un rapporto tra
l'investimento pubblico sullo spazio urbano e gli operatori privati.
Inoltre, considerato che sia dal punto di vista sociale che economico, Ferrara è
una città aperta ad accogliere nuove popolazioni (necessarie per rinvigorire e
ringiovanire la sua struttura demografica), e inserita in un insieme di geografie
variabili che le consentono di non sentirsi orfana né della Via Emilia, ma nemmeno
del Veneto, essa dovrebbe fare della sua articolazione una ricchezza e una risorsa,
considerando la bio-diversità anche in campo economico come capacità di reagire
alle crisi dei singoli settori e valore politico.
In questo senso le diverse popolazioni che la abitano dovrebbero consentire la
convivenza e coabitazione di diverse "culture del lavoro", in altre parole il suo essere
una città plurale dovrebbe sospingere il contemporaneo consolidamento delle tante
funzioni già insediate: dai servizi territoriali (strade, idrovia, corridoio cispadano,
ecc.) al turismo, dall'università alla piccola-media industria, dal commercio alla
città verde, alla città da abitare.
In qualche modo questo PSC potrebbe allora essere considerato come la trascrizione
territoriale di un piano strategico che parte dallo slogan "Ferrara è Ferrara".
|
|
b. Espandere il centro ovvero, portare la qualità del centro al resto della città.
|
La seconda proposizione, in stretta relazione con la precedente, si prefigge di
esportare nelle parti di città esterne, la qualità, densità e frammistione di funzioni,
servizi ed attrezzature che connotano il centro antico. All'interno dell'ipotesi di
lavorare sulla città esistente, si colloca anche l'idea di rafforzarne la sua urbanità,
prolungando alle parti della città contemporanea e a quelle caratterizzate da una più
forte omogeneità funzionale e spaziale, il sistema degli spazi collettivi e di socialità
che innervano così fortemente la città entro le mura.
Espandere il centro antico non significa quindi allargare la fascia di vincoli a tutela
di un territorio più ampio, ma far appartenere anche le parti di città esterne alla
vitalità e ricchezza di opportunità che caratterizza oggi il centro antico.
Si pensa di fare ciò sia attraverso la ridefinizione del ruolo delle strade più importanti
che escono dal centro, sia rafforzando la rete degli spazi e dei luoghi collettivi che
attualmente appaiono separati e frammentati, sia infine mettendo in rete servizi,
attrezzature e più in generale attrattori di popolazione.
Contemporaneamente, espandere il centro vuol anche dire aumentare quantità e
qualità dei punti di aggregazione riconoscendo luoghi, ambiti e forse una struttura,
attualmente celata, che ne consenta nuove ed inesplorate modalità d'uso.
Espandere il centro vuol dire in fondo dare dignità di città alla Ferrara che la nostra
società ha costruito nel corso del Novecento, senza esaltarla ma anche senza
un'eccessiva nostalgia per il passato.
Nel corso dell'elaborazione del PSC si è riflettuto sulla quantità di servizi,
attrezzature, negozi, uffici e fabbriche presenti in città, ma ancor di più sulle
logiche della loro localizzazione, sulla loro distribuzione spaziale e soprattutto sui
ritmi d'uso, sui diversi tempi di vita che attraversano ogni giorno la città, e ciò ci ha
portato a riflettere anche sull'idea di funzionamento della città stessa, di come le
cose stiano in mutua relazione tra loro, sull'idea che la città (come una macchina o
un organismo) sia fatta di parti ed oggetti che danno luogo a sistemi di relazione.
La distribuzione dei diversi servizi, attrezzature, e più in generale di "attrattori" di
popolazione, è stata allora osservata anche per la capacità di conformare flussi e
percorsi, ritmi e pulsazioni della vita urbana, immaginando che le diverse popolazioni
mettendo in relazione numerosi punti, garantiscono nei diversi momenti dell'anno
e del giorno vitalità, e perciò anche sicurezza, allo spazio urbano e al territorio.
Questi attrattori, rivestendo un importante significato per la società ferrarese non
vanno intesi solamente come dei servizi, delle "attrezzature tecniche" che devono
erogare un servizio, possono allora costituire progressivamente, per le diverse
popolazioni, dei luoghi urbani, spazi e materiali ai quali sono attribuiti dei valori, che
sono caricati di un senso comune, che entrano nella memoria collettiva diventando
parte inalienabile della città.
Popolazioni e luoghi sono variamente distribuiti sul territorio disegnando differenti
"geografie" nelle diverse parti della città: nel centro antico (in cui alcuni servizi
pubblici si trovano a stretto contatto e quasi si sovrappongono), nei quartieri
residenziali (dove i servizi diventano quasi dei punti, degli elementi regolarmente
distribuiti) nelle frazioni caratterizzate ovviamente da più semplici sequenze di
attrezzature e servizi lungo le strade principali che però formano delle interessanti
sequenze di poli che presidiano il territorio.
In questo senso si è pensato che servizi ed attrezzature, e le pratiche d'uso a
loro connesse, contribuiscono a disegnare la città dando vita a successioni di punti
regolarmente distribuiti, altre volte a sequenze, altre ancora ad assi tematici (ad
esempio, la strada dei negozi) o ad aree e nodi di concentrazione (l'area dei musei,
il centro politico-amministrativo, l'area artigianale).
Se questi servizi ed attrezzature sono uno dei materiali, uno dei "mattoni"
fondamentali nella definizione dello spazio urbano la città è tale anche perché
al suo interno coesistono numerose attività), allora anche la loro
eventuale rilocalizzazione, la loro chiusura o nuova costruzione, deve essere
trattata come "questione urbana", non come semplice localizzazione di un servizio
ma come strategia fondamentale nella definizione di un efficiente, ma anche
piacevole e vivibile ambiente urbano, uno spazio civile nel quale, come ai tre principi
di Serendip, possa capitare di "scoprire qualcosa per caso mentre ne sto cercando
un'altra", un ambiente che permetta percorsi programmati ma anche libere
"derive", che permetta di vagare facendo casualmente piacevoli e inattese scoperte
connettendo tra loro cose e funzioni diverse: sto andando al lavoro e mi fermo a
prendere il giornale e il caffè, devo andare in centro per ritirare un certificato alla
Camera di Commercio e nel negozio accanto vedo il cappotto che stavo cercando,
esco per andare all'ufficio postale e passando davanti alla libreria mi ricordo di
comprare un libro interessante, ecc.
|
|
c. Stabilire reti e connessioni
|
Tra le principali caratteristiche della città contemporanea, la sua indefinitezza
formale e la diversità delle sue parti funzionalmente definite, sembrano suggerire
l’ipotesi di lavorare sulla riconnessione dei segmenti di rete e dei frammenti urbani.
Differenti punti di vista sottolineano l’importanza assunta dalle reti di connessione,
ed in particolare dalle reti della mobilità, dai sistemi di continuità ambientale e da
quelli dei luoghi collettivi. Tuttavia, si prevede di riconnettere tutto con tutto, ma
sembra importante dare continuità alle reti ecologiche ambientali, ai frammenti di
spazi collettivi, ovvero provare a riconnettere ciò che lo sviluppo dei decenni passati
ha consegnato spesso in modo frammentato.
Ad esempio, le strade possono essere considerate non solamente spazi necessari
allo smaltimento del traffico veicolare, ma anche e soprattutto un sistema di
luoghi urbani importanti nella definizione dell'immagine della città, attraverso
la costruzione di una grammatica degli spazi aperti. A Ferrara, questo vale in
particolare per gli assi storici che escono dalla città murata, ma anche per i sistemi
viabilistici delle "U", per i terminal d'interscambio e i parcheggi di attestamento.
In modo analogo, le reti ambientali costituiscono un'articolata trama entro cui
assumono un ruolo strutturante, sia per un corretto funzionamento ecologico del
territorio, sia per una migliore vivibilità della città, le grandi superfici verdi dei parchi,
degli ambiti naturalistici così come la presenza discreta di vegetazione nelle zone
rurali. Una vegetazione che contribuisce a far apparire "rugosa" la superficie del
territorio di Ferrara. Infatti, non si tratta di grandi boschi, di grandi masse alberate,
ma piuttosto di lunghi filari di platani lungo le principali strade storiche, di boschi
ripariali lungo i corsi dei fiumi, di pioppeti e frutteti, di sequenze di salici bianchi
e siepi lungo alcuni canali, ed infine di grandi alberi sparsi. Una vegetazione che,
come i piccoli movimenti del suolo, in questo territorio ha un carattere discreto,
esercita un'attenta selezione dei luoghi, articolando il territorio in diversi paesaggi.
Infine, le reti di spazi pubblici rappresentano trame costituite dalla successione di
percorsi pedonali e ciclabili differenziati e protetti e dall'insieme di piazze, spiazzi,
slarghi, giardini, viali e parcheggi che tessono, tra loro, le varie parti della città. Esse
costituiscono l'ossatura della città, individuando i luoghi centrali e più in generale,
le aree in cui si svolge la vita pubblica e collettiva della città.
|
|
3. Il funzionamento della città: prestazioni e dimensionamento
|
Coerentemente con le riflessioni sin qui svolte, relative alle potenzialità spaziali
della frammistione di attività e soggetti, si è ritenuto l’articolazione, la pluralità e
l’eterogeneità degli spazi e dei loro usi, caratteri costitutivi della città e del territorio
ferrarese.
Contrariamente alla pratica di azzonamento che cerca di ricondurre questi
caratteri entro insiemi omogenei e chiaramente specializzati, entro parti di
città funzionalmente distinte e separate, si è ritenuto necessario riconoscere le
potenzialità della frammistione e della mixitè di attività e soggetti, precisando gli
specifici ruoli che gli spazi devono svolgere, le prestazioni che devono garantire, i
materiali con i quali dovrebbero essere costruiti.
Il PSC cerca di raccogliere quest’articolazione in quattro principali sistemi:
della mobilità, dell’abitare, della produzione, dell’ambiente e delle dotazioni
territoriali. Questi sistemi evocano possibili modi d’uso del territorio, ci parlano
del funzionamento della città, rappresentano una sorta di descrizione critica della
realtà, ma delineano anche possibili scenari per la trasformazione e lo sviluppo.
Inoltre, i sistemi proposti costituiscono dei “telai strutturali” su cui poggiare le
principali scelte del PSC, definendone le parti più stabili.
|
|
I SISTEMI del PSC
In evidenza il sistema
ambientale e delle
dotazioni territoriali (nei
toni dell'azzurro) e il
sistema della mobilità e
la "città dell'automobile"
(in rosso)
|
| 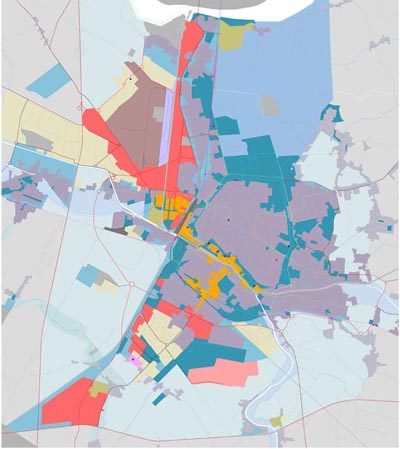
|
|
|
a. Il sistema ambientale e delle dotazioni territoriali
|
|
Il sempre più forte ruolo assunto dagli aspetti ambientali nella pianificazione
territoriale è frutto del recente riconoscimento che un corretto rapporto con
l'ambiente rappresenti uno dei principali obiettivi della società contemporanea. In
questo senso la particolare situazione ambientale di Ferrara, caratterizzata dalla
dipendenza dal funzionamento del sistema idraulico, ha fatto si che la questione
ambientale sia sempre stata centrale nella gestione del territorio. Il nuovo PSC
conferma e consolida tale tradizione affidando al progetto del sistema ambientale
non solo la risposta a questioni specifiche, ma anche il ruolo di struttura su cui
poggiare le principali ipotesi di trasformazione e sviluppo.
Il sistema ambientale, attraversando e sovrapponendosi agli altri sistemi assume
differenti ruoli: di infrastruttura (elemento di connessione tra ambiti ed ambienti
diversi, rete ecologica), di città alternativa (grande parco che oppone il suo
specifico disegno a quello della città), di risorsa e riserva (elemento fondamentale
per garantire l'equilibrio idraulico del territorio). Sono questi obiettivi primari che
la collettività di Ferrara deve poter condividere attraverso una discussione sulla
definizione di un preciso disegno e ruolo degli spazi aperti, delle aree pubbliche e
dello spazio rurale.
Una prima, ambiziosa, proposta riguarda la previsione di una "città verde" cui affidare
funzioni e ruoli che negli insediamenti esistenti vengono svolti in maniera parziale
e isolata. La "città verde" può rappresentare una vera e propria città complementare
a quella esistente, composta di luoghi e spazi di relazione. A tal fine la connessione
delle aree verdi urbane esistenti e previste, sia delle superfici attrezzate (parchi,
aree scolastiche e sportive, ecc.), sia degli altri spazi aperti della città (viali alberati,
prati, ecc), rappresenta una prima importante operazione che il PSC propone. Volendo
distinguere e graduare il "livello di naturalità" degli spazi aperti, questa rete può
essere letta come la componente più urbana del sistema ambientale, attraverso cui
ridefinire il rapporto tra la grande dimensione dello spazio rurale e quella più ridotta
degli ambiti urbani.
Una seconda componente è rappresentata da un insieme di spazi agricoli esterni
alla città consolidata attraverso i quali disegnare una sorta di “cintura” cui viene
attribuito il compito di mediare il rapporto tra lo spazio rurale e quello urbano.
I ruoli che questi spazi assumono sono molteplici: per alcune parti prevale il
ruolo paesaggistico, mentre per altre diviene importante il ruolo di salvaguardia
ambientale, per altre ancora diventa importante recuperare una funzione agricola
anche ipotizzando nuove e più innovative forme di conduzione e/o coltivazione.
Il progetto del sistema ambientale si compone anche di aree attraverso cui
compensare alcuni squilibri ambientali. Fasce boscate, ma anche vasche di
contenimento di possibili esondazioni della rete di raccolta della acque piovane o dei
corsi d'acqua, filari lungo le nuove strade e aree di rispetto attorno agli insediamenti
produttivi: l'importanza di questi ambiti sta nella capacità di rendere sostenibile
la compresenza di attività e luoghi, come ad esempio aree industriali, ambiti
residenziali ed infrastrutture, solitamente incompatibili nella città contemporanea.
L'attuazione del progetto del sistema ambientale, così come descritto, non può
dipendere dalla sola gestione degli standards urbanistici. La rilevanza collettiva
riconosciuta a questo insieme di spazi, ai fini di un buon funzionamento del
territorio, deve far pensare a modi di realizzazione basati non esclusivamente
sull'acquisizione pubblica delle aree, ma anche, e piuttosto, su modalità di gestione
che si confrontino con il coinvolgimento di una pluralità di attori.
Oltre a ciò, il progetto del sistema ambientale comprende anche ambiti caratterizzati
da un forte carattere di naturalità e riconoscibili come veicoli di interazione con
l'ambiente.
Gli ambiti fluviali (corsi d'acqua, aree golenali, paleoalvei, ecc.) con il loro carattere
di permanenze, costituiscono gli elementi portanti della struttura territoriale del
forese oltre che gli elementi attraverso cui stabilire le principali connessioni tra le
diverse parti del territorio. Il sistema fluviale considerato nel suo complesso può
diventare allora, non solo fondamentale per il funzionamento idraulico del territorio,
ma anche materiale attraverso cui raccordare la dimensione geografica del territorio
rurale con gli ambiti urbani della città.
Accanto a tali elementi non meno significative appaiono alcune emergenze
paesaggistiche ed architettoniche che, pur nella "casualità" della loro collocazione
caratterizzano il territorio in maniera rilevante.
Il PSC in questo caso si pone l'obiettivo di una loro conservazione, ma anche di
sfruttare le opportunità derivanti dalle possibilità di un loro riuso compatibile. I filari,
le strade alberate e le aree golenali boscate rappresentano importanti elementi di
riconoscimento e orientamento all'interno di un paesaggio "aperto" come quello
del forese. In modo analogo il riutilizzo degli edifici rurali inutilizzati, delle corti
coloniche, ecc. rappresenta un'opportunità per un uso articolato del territorio
agricolo che garantisce il mantenimento dei manufatti esistenti.
|
|
b. Il sistema dell'abitare
|
Per quanto riguarda il sistema dell'abitare, costituito dall'insieme dei luoghi
residenziali, del commercio, dei servizi e delle attrezzature ad essi strettamente
connessi, i principali obiettivi sono di favorire la qualità urbana dei luoghi
attraverso la riqualificazione delle aree esistenti e l'insediamento di nuovi tessuti
a completamento di quelli esistenti; di garantire un corretto dimensionamento e
funzionamento della rete dei servizi collettivi; infine, di favorire una frammistione
funzionale che garantisca la prevalenza della destinazione residenziale.
Una delle principali immagini che si incontra occupandosi di Ferrara è quella di una
città che propone il suo centro storico come elemento di confronto con il resto del
territorio, una città in cui la parte dentro le mura contrapposta alla campagna e alla
periferia delle nuove zone residenziali ha costituito un'immagine di straordinaria
efficacia descrittiva. Attualmente tale contrapposizione, pur denunciando differenze
e omogeneità ancora riconoscibili, non sembra più così fortemente rappresentativa
della realtà territoriale e della società ferrarese. Nonostante "dentro" e "fuori" le mura
siano ancora categorie denotative di ambiti molto differenti, oggi è la frammistione
e l'eterogeneità di usi e di spazi, di modi di circolare e di attività a caratterizzare la
struttura del territorio e, in parte, la sua società.
Tutto ciò significa allora confrontarsi con una situazione frammentata e che
oppone rilevanti resistenze a qualsiasi tentativo di omogeneizzazione, cercando di
ricondurre i frammenti all’interno di un sistema in grado di narrarne differenze, oltre
che di stabilirne potenzialità e opportunità.
A tal fine una prima azione proposta dal PSC è di espandere il centro, ovvero allargare
la qualità del centro storico alle parti contigue ma anche, e soprattutto, espanderne
il livello di urbanità. Si ipotizza di esportare i caratteri urbani del centro ai tessuti
edilizi costruiti a ridosso delle principali direttrici di espansione della città quali
Via Modena, Via Bologna e Via Bentivoglio, Via Comacchio, e al di là di p.le Medaglie
d'oro, p.le S.Giovanni e p.zza S.Giorgio. Queste strade, attorno e lungo le quali si è
espansa la città, costituiscono anche dei luoghi centrali che il nuovo PSC prevede di
potenziare attraverso differenti interventi: dalla costruzione di sistemi di mobilità
alternativi che ne riducano la funzione di strade di attraversamento, alla previsione
di densificazione del tessuto edilizio, infine, alla concentrazione, nel loro intorno, di
attrezzature e servizi che ne aumentino il ruolo di centralità. Il medesimo obiettivo
viene perseguito anche sostenendo modalità di spostamento adeguate, agevolando
l'uso della bicicletta e affidando alla pedonalità e al trasporto pubblico un ruolo più
significativo.
Per le frazioni del forese, il PSC propone di consolidare le strutture insediative
riconosciute, valorizzando le centralità eprevedendo nuove aree residenziali
principalmente come completamento dei tessuti esistenti. Questi obiettivi
puntano a confermare queste parti del territorio come nuovi e ricercati luoghi della
residenza. Aree che possano diventare una modalità di abitare alternativa alla città
concentrata, e caratterizzate dalla bassa densità edilizia.
Come abbiamo già evidenziato, un'osservazione attenta e approfondita dei materiali,
delle forme e delle modalità di relazione reciproca degli usi e degli spazi di cui si
compone la struttura urbana porta a riconoscere una molteplicità di tessuti e
strutture insediative, una frammentazione ed eterogeneità, la continua separazione
tra porzioni differenti. Il tentativo del PSC è, in questo caso, di confrontarsi con
questi caratteri intessendo più strette relazione tra le parti, inserendo i frammenti
riconosciuti all'interno di una narrazione che riconosca agli spazi verdi il ruolo di
elemento di connessione.
Il PSC propone quindi che la città consolidata venga definita e completata attraverso
la previsione di una città alternativa, la “città verde”, capace di legare le differenti
parti urbane tramite un sistema di connessioni che, da un lato garantisce il
mantenimento dei caratteri e della qualità dei luoghi, dall’altro suggerisce nuovi
ambiti da destinare a servizi introducendo, quindi, una nuova immagine di Ferrara,
dove le parti residenziali sono tra loro connesse da un reticolo di spazi verdi che
può comprendere anche quelli di pertinenza delle attrezzature di servizio.
Il nuovo disegno della città proposto si confronta anche con la necessità di crescita
ed espansione urbana.
All’interno del PSC, oltre al completamento della città
consolidata e dei nuclei del forese, si prevedono nuovi luoghi in cui ritrovare tracce
di una nuova e possibile città. Si tratta di ambiti in cui il corretto rapporto tra spazi
edificati e spazi aperti costituisce l’elemento fondativo degli insediamenti, in cui
gli aspetti legati alla mobilità e alla circolazione non sono subiti, ma piuttosto sono
parte integrante dell’ipotesi di sviluppo. Nuovi spazi dell’abitare in cui il rapporto
con l’ambiente, piuttosto che un aspetto problematico, rappresenta un’opportunità
per la costruzione di luoghi di qualità.
Il nuovo PSC individua nell’asse est-ovest, costituito dal sistema Porotto-Cassana,
Ambito del Po di Volano, Foro Boario e vicina area ferroviaria e Cocomaro-Cona, il
luogo dove proporre queste parti di città nuova. Una città che deve far convivere
modelli abitativi molto diversi tra loro: da situazioni a bassa densità (Porotto-
Cassana e Cocomaro- Cona), ad ambiti a densità più elevata (Ambito del Po di Volano
e Foro Boario-area ferroviaria). Le ipotesi di sviluppo per le parti più esterne (Porotto-
Cassana e Cocomaro-Cona) nascono dalle opportunità offerte dai nuovi interventi
di infrastrutturazione del territorio (bypass di Via Modena e metropolitana
suburbana), che permettono ipotesi di mobilità alternative a quella dell'automobile.
Entrambe le previsioni si fondano, perciò, sulla possibilità di immaginare nuovi spazi
residenziali costruiti a ridosso di un contesto naturale in cui far coesistere funzioni
residenziali ed agricole, immaginandosi nuovi ruoli e spazi per entrambi. All'interno
di questo disegno, un ruolo fondamentale può essere affidato alla presenza di
sistemi fluviali quale importante elemento naturale di riferimento. La struttura
delle nuove parti centrali (ambito del Po di Volano e Foro Boario-area ferroviaria) si
fonda, invece, sull'opportunità che nuovi insediamenti modifichino le relazioni tra le
parti dell'immediato intorno. In questo caso, gli spazi aperti dei nuovi insediamenti
disegnano luoghi collettivi e ambiti di relazione tra i tessuti esistenti.
|
|
c. Il sistema della mobilità
|
Il sistema della mobilità, cui appartengono le autostrade, le ferrovie, la rete di piste e
percorsi ciclo-pedonali, le principali strade urbane ed extraurbane, dovrebbe essere
in grado di garantire le seguenti prestazioni: una gerarchizzazione e specializzazione
delle reti delle infrastrutture di mobilità, ed in particolare una chiara e agevole
connessione tra la rete delle principali vie di comunicazione e quella delle strade di
accesso, penetrazione e collegamento; una chiara separazione tra gli spostamenti
di veicoli pesanti che attraversano la città e gli spostamenti di automobili legati alla
vita quotidiana. Inoltre, dovrà garantire una maggiore riconoscibilità dei
diversi tipi di strada, attraverso il ridisegno delle sezioni e la previsione di nuove
interconnessioni.
Il progetto delle infrastrutture e della mobilità ha da sempre caratterizzato il disegno
della città sia perché interagisce fortemente con le problematiche inerenti alla sua
crescita, sia perché stabilisce effetti immediati sui soggetti coinvolti. A Ferrara il
disegno generale della mobilità proposto dal PSC muove da alcune questioni.
1. L'introduzione di nuovi assi di scorrimento (tangenziali, circonvallazioni,
ecc.) alternativi ai tracciati storici di collegamento contribuisce, da un lato a ridurre
il sovraccarico di traffico e di ruoli riconosciuto come aspetto problematico, dall'altro
ad alleggerire la sovrapposizione tra luoghi e spazi di relazione.
2. Come lo spazio edificato, anche gli spazi per il movimento e la circolazione
sembrano essere caratterizzati da forte discontinuità presentandosi sempre più
come frammenti che necessitano di essere connessi tra loro.
3. La tendenza a scomporre le modalità di spostamento secondo
differenti temi (trasporto pubblico, trasporto privato, movimenti delle merci, sosta,
pedonalizzazione, ecc.), non ha prodotto nel PSC l'identificazione di una priorità di
scelte, quanto piuttosto la definizione di un quadro di coerenza generale entro cui i
diversi aspetti non entrano in conflitto tra loro.
4. I caratteri di emergenza insiti nelle problematiche legate alla circolazione
e alla sosta tendono ad allargarsi fino a comprendere le questioni relative
all'inquinamento atmosferico e acustico prodotto da tali situazioni.
A Ferrara questi aspetti generali hanno assunto connotati ben precisi legati alla
crescita della città a sud e ad ovest, alla dimensione e forma della città antica, alla
presenza di alcuni assi di collegamento con l'area vasta, al Po e al sistema fluviale
e, non ultimo, all'importanza che assume, nel bilancio complessivo del traffico, la
circolazione in bicicletta.
La riflessione della città attorno a questi temi si sta articolando da tempo. Alle
previsioni del Prg vigente si sommano, infatti, le proposte contenute nei recenti
studi del piano urbano del traffico, datato 2001, ma anche la realizzazione
dell'interramento del tratto urbano delle linee ferroviarie per Codigoro e Rimini.
Si stanno anche progettando importanti opere infrastrutturali, sia per la viabilità
automobilistica locale, con il prolungamento a sud e a nord di Via Ferraresi, ed
extracomunale, con il corridoio adriatico e l'E55, sia per il trasporto pubblico, con la
metropolitana leggera.
La rete automobilistica. Un primo tema in cui scomporre la questione
della mobilità è quello della circolazione automobilistica. La "grande U" e la
"piccola U" rappresentano modalità di funzionamento della viabilità ormai entrati
nell'immaginario dei ferraresi. Queste due modalità costituiscono la declinazione
locale del principio di circonvallazione della città antica, utilizzato per sgravare il
centro dal traffico di attraversamento da e verso la rete autostradale. Infatti, a Ferrara,
la presenza del Po e del parco urbano non consentono di chiudere a nord il cerchio e
di completare la circonvallazione che funziona, quindi, per i rimanenti tre lati.
Le opere che si stanno realizzando confermano queste scelte. La rete di connessione
viabilistica tra le diverse parti della città è completata dalla prosecuzione di Via
Ferraresi a sud e, quindi, dalla bretella di collegamento tra le due uscite autostradali.
Dall'opportunità offerta da quest'arteria deriva la costruzione di uno specifico
paesaggio, la "città dell'automobile" che, a partire dalla presenza di attività
esistenti legate all'uso dell'automobile, permette l'insediamento di futuri manufatti
commerciali, direzionali e per i grandi servizi, con adeguati sistemi di accesso alla
strada principale compatibili con il ruolo urbano assunto da tale asse. Il paesaggio
della "città dell'automobile" si caratterizza, quindi, per il tentativo di dare adeguato
trattamento
|
|
PSC. La rete automobilistica
Le linee tratteggiate indicano
le opere da realizzare per
completare il sistema di
funzionamento proposto.
(piccola e grande "U", "orecchio"
di raccordo con la viabilità
autostradale e di accesso alla
città da ovest.
| 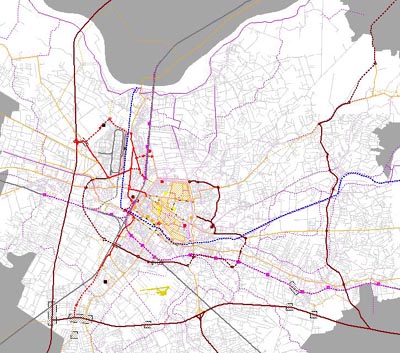 |
|
alle estese superfici caratterizzate da una fruizione di carattere
prevalentemente automobilistico, anche attraverso una forte interazione nell'uso
dei materiali della strada e dei materiali vegetali.
Il potenziamento dell'accessibilità da Ovest alla città costituisce un'opportunità
anche per la localizzazione del nuovo museo della Shoa posto ai margini del Parco
urbano, oltre che dello stesso Parco.
La gradualità delle relazioni consentita dal sistema delle due "U" si completa e
conclude a ridosso della rete per l'accessibilità al centro storico. La parte centrale
della città diviene raggiungibile oltre che utilizzando un "passante interno" costituito
dalla sequenza Via Darsena-Viale Volano e Via Argine Ducale-Via Fabbri-Via Goretti,
anche avvalendosi degli anelli interni alle mura posti, ad ovest, (Viale Cavour-Corso
Porta -6), e ad est (Corso Giovecca, Corso Portamare), del nucleo centrale Duomo-
Castello. Il funzionamento dell'accesso al centro è completato dalla sistemazione
dei principali parcheggi previsti (viale Volano, Kennedy, Viale Cavour, multisala,
S.Anna, ecc.).
Il sistema dei parcheggi per il centro si completa con la previsione di alcune aree
dedicate ai soli residenti e con una corona di parcheggi turistici (Kennedy, S.Anna,
via Canapa) posti in corrispondenza della cinta muraria.
Una rete alternativa. Biciclette e metropolitana. Ferrara "città della
bicicletta" è un'immagine che deriva dall'utilizzo della bicicletta come mezzo di
circolazione pervasivo e frequente. A Ferrara la bicicletta rappresenta non solo
un'alternativa all'automobile, ma anche e soprattutto ai mezzi pubblici. Le ragioni
di questa realtà dipendono da una molteplicità di fattori che vanno dalla forma
e dimensione della città, e in particolare del suo centro, alla localizzazione dei
principali servizi e luoghi collettivi, ma anche da una forte tradizionale affezione
|
|
PSC. Rete alternativa
In evidenza: la linea
metropolitana (colore
rosa), i terminals di
interscambio delle
persone (colore
rosso scuro), i park
turistici (colore
rosso), i parcheggi
per i residenti (colore
giallo).
|
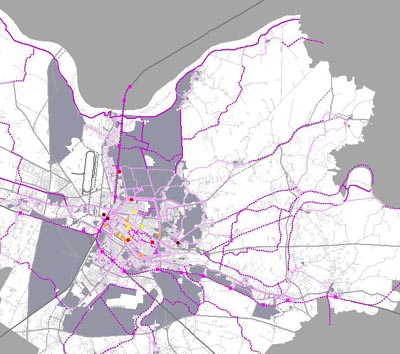 |
|
a questo mezzo. Questa situazione rappresenta un importante punto di partenza
nella costruzione di un progetto complessivo della mobilità, fondato sulla
molteplicità e sull'articolazione dei mezzi di spostamento. Al principale sistema
della rete automobilistica è possibile associare un'ulteriore importante modalità
di spostamento capace di coniugare l'utilizzo della bicicletta con quello della
metropolitana leggera. Quest'ultima, infatti, se dotata di vettori adatti al trasporto
delle biciclette, potrebbe associare la facilità di spostamento per tragitti brevi offerti
dalla bicicletta con la possibilità di collegare parti di territorio più distanti tra loro;
queste caratteristiche rendono tanto più interessante l'ipotesi di un prolungamento
della linea metropolitana a nord fino a comprendere i quartieri Barco, Pontelagoscuro,
il Parco urbano e a ovest fino a Porotto.
Reti alternative. Gli interscambi. Il sistema della mobilità è completato
dalla previsione di adeguati luoghi di interscambio che grazie all'utilizzo di mezzi
più adeguati garantiscano un alleggerimento degli spostamenti in città. All'interno
di questa logica si collocano:
- la previsione di due piattaforme logistiche per le merci a nord (in
corrispondenza della zona artigianale ad ovest del Petrolchimico) e a sud (a sud
della zona Fiera)
- la localizzazione di due nodi di interscambio per il trasporto pubblico ad
est (in corrispondenza dell'area scolastica) e ad ovest (a ridosso della stazione
ferroviaria).
Nel primo caso, oltre a rappresentare un aspetto importante per la definizione di un
ruolo centrale di Ferrara rispetto al sistema dei trasporti regionali, le due piattaforme
possono rappresentare i luoghi deputati alla rottura di carico a favore di mezzi di
trasporto merci di dimensioni più consone alle parti di città più densamente abitate.
La razionalizzazione della distribuzione delle merci attraverso l'utilizzo di mezzi di
dimensioni adeguate alle strade del centro e la distribuzione delle merci in precise
fasce orarie della giornata consentirebbe, infatti, una significativa riduzione del
traffico sia nella parte storica sia negli altri ambiti residenziali.
I nodi di interscambio tra il trasporto pubblico urbano, extraurbano e ferroviario,
rappresentano, invece, l'opportunità di definire per il centro della città una rete di
trasporto con frequenza più alta, ma anche alcuni circuiti serviti da bus navetta per
il servizio alle parti urbane più dense.
Lo schema dei luoghi di interscambio è completato da un nodo posto a ridosso
dell'area del Petrolchimico per sfruttare le opportunità di intermodalità offerte
dalla presenza del sistema fluviale (canale Boicelli), dall'accessibilità al sistema
autostradale senza interferire con la viabilità locale (attraverso la nuova viabilità
di collegamento al casello di Ferrara nord), ed infine dalla possibilità di garantire
il collegamento con la linea ferroviaria del corridoio adriatico attraverso una linea
dedicata. La nuova linea ferroviaria ripropone l’attuale accesso ferroviario
al Petrolchimico da sud con un collegamento diretto al corridoio adriatico:
sottopassando la via Modena (già collocata ad una quota superiore a quella della
linea ferroviaria) e la fascia di via Arginone e del canale di Burana.
|
|
d. Il sistema della produzione
|
Il sistema della produzione, formato dall'insieme dei manufatti singoli e delle
aggregazioni di manufatti a carattere industriale, agro-industriale, artigianale,
della grande e media distribuzione commerciale e, pur se in misura contenuta, dai
servizi, spazi scoperti di uso pubblico, attrezzature e modeste quote di residenza
dovrebbe favorire la connessione delle aree produttive con la viabilità territoriale,
la grande U e piccola U, e con i principali nodi di interscambio merci; favorire i
collegamenti, anche ciclabili, con le altre parti della città; garantire un'adeguata
presenza di servizi e attrezzature capaci di rispondere alle esigenze degli addetti;
garantire un opportuno trattamento degli spazi aperti ad uso pubblico che vada
nella duplice direzione di agevolare il movimento e la sosta delle automobili, ma
anche di persone e ciclisti; infine, sostenere il corretto funzionamento idraulico e
ambientale del territorio, attraverso la non totale impermeabilizzazione dei suoli
pubblici e privati e la predisposizione di filtri e barriere a difesa e compensazione
dell'inquinamento.
Le importanti modifiche della struttura della società e della città contemporanee
avvenute negli ultimi decenni hanno coinvolto, in maniera rilevante anche la
struttura economica. A Ferrara, la particolare e specifica struttura del settore
produttivo, caratterizzata nei decenni scorsi dalla pressoché esclusiva presenza
del comparto chimico, ha subito importanti variazioni ad esso legate. La storia
dell'economia e del mondo del lavoro di questo territorio, infatti, ha coinciso per
molto tempo con la storia del petrolchimico di Ferrara, ed ha visto riproporsi, a livello
locale, le fasi di espansione, crisi e ristrutturazione del settore della chimica.
A questo andamento si sono associate le trasformazioni, altrettanto strutturali, del
mondo agricolo, legate a loro volta a modifiche più generali, ma caratterizzate anche
dall'andamento di specifici settori quale quello frutticolo e zuccheriero.
Già il piano vigente ha saputo interpretare le modificazioni del settore produttivo
prevedendo un insieme di nuove aree per la produzione non legate al solo
petrolchimico, articolando l'offerta in risposta alla domanda di insediamento di
attività commerciali, per la piccola e media industria e servizi, riconosciuti come
settori in espansione.
Oggi, a Ferrara, il sistema produttivo è caratterizzato dalla presenza articolata
e dimensionalmente omogenea della piccola e media impresa con l'ipotesi di
ristrutturazione della grande impresa del petrolchimico. La particolare struttura,
sia del mondo della produzione industriale-artigianale che di quello agricolo, oltre
che naturalmente del territorio, ha permesso il contenimento dell'espansione
delle attività della piccola e media impresa all'interno delle aree industriali,
senza provocare, come in altre situazioni territoriali, fenomeni di dispersione e
di occupazione estensiva del territorio. Ma l'economia ferrarese è caratterizzata
anche dalla significativa presenza di altre componenti come l'istruzione di livello
universitario, il turismo, le attività museali, ecc. definendo un quadro complessivo
fondato su una pluralità di attività ciascuna delle quali coinvolge diverse parti della
città.
A partire da tali considerazioni, e nella consapevolezza che uno strumento
urbanistico non ha tra i suoi compiti quello di definire la politica economica del
territorio, il PSC ha ritenuto importante fissare le condizioni per uno sviluppo
sostenibile dell'economia ferrarese. In questo senso, la conferma e il rafforzamento
della struttura polifunzionale dell'economia di Ferrara costituisce uno degli obiettivi
principali di questo piano.
Petrolchimico. Considerato l'importante ruolo che il settore della chimica
ha avuto nell'economia ferrarese, il PSC prende atto della recente ipotesi di conferma
dell'attività del petrolchimico. Le possibilità e gli investimenti di ristrutturazione, di
bonifica e di adeguamento a nuovi e più adatti standards dell'area, parallelamente alla
trasformazione dell'assetto delle aziende comprese nel perimetro, costituiscono,
infatti un’importante occasione per la città. La ristrutturazione del “condominio della
chimica” può, infatti, rappresentare, oltre che un importante elemento di sviluppo
dell’economia locale, anche l’occasione per il nuovo insediamento di attività che
utilizzino le infrastrutture e le risorse esistenti. Per queste ragioni, la previsione
di un interscambio modale tra idrovia, ferrovia e strada posto a nord dell’area e la
nuova centrale elettrica assumono un peso rilevante.
Le nuove aree per la piccola e media impresa. Lo sviluppo della piccola
e media impresa è forse uno dei fenomeni recenti più rilevanti che ha investito il
territorio ferrarese; nonostante ciò, le aree di espansione previste dal piano vigente
sono state realizzate solo in parte.
Il nuovo PSC ipotizza, quindi, la saturazione delle aree già destinate alla produzione
e collocate soprattutto ad ovest della città e la previsione di alcune nuove aree a
completamento di quelle esistenti. Le nuove aree previste completano i bordi del
petrolchimico verso la campagna, e la zona artigianale di Via Bologna. Particolare
attenzione è posta all’interazione tra gli insediamenti produttivi e alcuni elementi
della “città verde” che possono contribuire alla loro sostenibilità ambientale. Nel
disegno proposto gli insediamenti produttivi posti ad ovest della città sono separati
dagli insediamenti residenziali mediante ampie fasce boscate. In particolare, nelle
frazioni di Porotto e Cassana l’ampia fascia, boscata posta a nord dell’edificato,
costituisce una zona di protezione e filtro dalle zone della piccola media impresa e
dall’inceneritore collocati a nord.
Il progetto delle aree verdi di compensazione legato agli insediamenti industriali si
completa con il rafforzamento della fascia boscata, compresa tra i quartieri Barco
e Pontelagoscuro e l’area del petrolchimico; questa fascia rappresenta la naturale
continuità del sistema verde previsto a sud lungo Via Ferraresi. Risulta evidente che
il disegno degli spazi aperti configura in maniera decisa questa parte del territorio
collocando le nuove aree produttive esistenti e previste all’interno di un reticolo
caratterizzato da rilevanti elementi di naturalità.
La città dell'automobile. Nell'ottica di definire nuove reti e nuovi paesaggi
legati sia al mondo dell'automobile che ai luoghi dove si svolgono le principali
attività produttive della città, il PSC prevede di forzare il collegamento tra le due
uscite autostradali poste a nord e a sud della città. Ciò avviene attraverso la
ridefinizione di alcuni assi stradali (Via Ferraresi, ecc.), e le aree e gli insediamenti
da essi attraversati. Si tratta di estese superfici caratterizzate da una fruizione di
carattere prevalentemente automobilistico, poste lungo le strade di ingresso alla
città, dove si collocano insiemi di edifici di grandi dimensioni ospitanti funzioni
prevalentemente commerciali, ma anche importanti servizi come la Fiera e la
Facoltà di ingegneria. L'intensivo utilizzo dell'automobile in questa parte della città
richiede di riqualificare gli spazi scoperti ad uso pubblico, i parcheggi e le superfici
per l'esposizione, ma anche di mettere a punto progetti omogenei relativamente
alle modalità di accesso alle attività, alla natura degli spazi della sosta e di quelli
della circolazione; progetti capaci di interagire fortemente anche con il disegno
degli spazi aperti, ecc. I parcheggi, ad esempio, possono essere pensati come spazi
aperti permeabili caratterizzati da una pavimentazione verde, dalla presenza di
alberature e dalla possibilità di un uso diversificato nei differenti orari della giornata.
Oppure, l'accesso alle aree servite dalla strada può essere ridisegnato utilizzando
dei controviali opportunamente dimensionati.
I progetti devono inoltre perseguire l'obiettivo di definire un nuovo paesaggio degli
accessi autostradali alla città anche attraverso una forte interazione nell'uso dei
materiali della strada e dei materiali vegetali.
Il centro. La dimensione del centro di Ferrara e la sua riconoscibilità come
parte di città sono associabili alle opportunità che esso può offrire in termini di
sviluppo economico. Le trasformazioni di grandi aree (S.Anna, ex MOF, Caserme,
ecc), alcune importanti funzioni già presenti e lo sviluppo che per loro è ipotizzabile,
(attività museali, università, turismo fluviale, ecc), il ruolo e il peso delle attività
commerciali e dei servizi esistenti, rappresentano importanti opportunità per l’intera
economia ferrarese. In questo senso il PSC prevede, a conferma e completamento di
questa parte di città, un sistema di accessibilità e di spazi per la sosta adeguati alla
pluralità di attività esistenti, ma anche al loro potenziamento derivante dal recupero
dei molti manufatti dismessi o in via di dismissione. In particolare il sistema della
mobilità e della sosta si confronta con i nuovi carichi derivati dal rilancio delle attività
museali e universitarie, ma anche con le questioni associate all’uso residenziale del
centro storico.
Il distretto della frutta e dell'agroindustria. In maniera analoga a quella
prevista per altri settori, il PSC conferma le previsioni di aree produttive per la
conservazione e la trasformazione dei prodotti agricoli che si collocano entro
la struttura produttiva agricola. L'obiettivo è di garantire quanto più possibile la
lavorazione in loco dei prodotti agricoli accompagnando il processo di ristrutturazione
del settore attualmente in corso, attraverso l'accorpamento dei plessi produttivi,
salvaguardando l'occupazione e razionalizzando la funzione di servizio al settore
agricolo.
In conclusione, per il sistema della produzione il rapporto con l'ambiente costituisce
un aspetto di grande importanza e si traduce in scelte che hanno come obiettivo sia
la verifica e costruzione di nuovi paesaggi, sia la previsione di nuove reti di relazioni
tra le parti, sia, infine, la specificazione di modalità di compensazione nei casi di
bassa compatibilità.
|
|
e. Ambiti e Dimensionamento
|
L’impostazione del dimensionamento del PSC, non può prescindere da alcune
precisazioni sulle mutate condizioni in cui si trova ad operare il nuovo piano.
L’eterogeneità che connota la città, la varietà e modificabilità della società e della
composizione della popolazione, l’indeterminatezza della validità temporale del
PSC, sono alcune delle principali ragioni che rendono problematiche ed inutilizzabili
valutazioni sullo sviluppo del territorio a partire dalla definizione di fabbisogni
riconosciuti. E d’altra parte, l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile del territorio,
sposta il centro del piano collocando la previsione quantitativa della pianificazione
al di fuori degli obiettivi generali.
All’interno di un piano che si concentra sulla “riqualificazione” dell’esistente, sulla
valorizzazione del territorio, sul suo buon funzionamento, l’ipotesi su cui fondare
il dimensionamento non parte tanto dalla definizione di un “fabbisogno stimato”
ma piuttosto si propone come verifica “dimensionale dello sviluppo” rispetto alle
risorse esistenti e alle compatibilità con i caratteri più profondi del territorio.
Gli elementi su cui basare tale verifica sono molteplici e possono essere compresi
in due gruppi di questioni:
-
quelle legate alla interpretazione della crescita delle aree urbane come
completamento/consolidamento delle strutture insediative esistenti. Con il
non secondario obiettivo di ridurre l’urbanizzazione dello spazio rurale e di non
intercludere nuove aree agricole.
- quelle relative alla previsione, nei nuovi insediamenti, di densità di
edificazione e quantità di spazi aperti che garantiscano una più elevata qualità dei
tessuti urbani.
Con questi presupposti, il dimensionamento del PSC di Ferrara si costruisce a partire
dalle ricognizioni sullo stato di attuazione del piano vigente, sulla individuazione del
“residuo” del Prg sia in termini di volumi che di aree occupate. Parallelamente vanno
precisati gli obiettivi di densità edilizia a cui ricondurre la realizzazione delle nuove
aree.
In particolare quest’ultimo aspetto necessita di alcune precisazioni. Una prima
riguarda l’individuazione di differenti situazioni in cui si trovano le aree in funzione
del loro “carattere urbano”. A tal fine sono riconosciuti e definiti, i seguenti
contesti:
- "Aree centrali", comprensive delle seguenti strutture insediative:
Entro mura;
Volano;
via Bologna: Foro Boario;
Corso Po-via Modena.
- "Centri Urbani", comprensivi delle seguenti strutture insediative:
Arginone;
Doro - Barco - Pontelagoscuro;
Quacchio - Borgo Punta;
Mizzana;
Darsena - Stazione - Porta Catena;
Parco Urbano;
via Bologna;
via Comacchio.
- "Aree di prima corona", comprensiva delle seguenti strutture insediative:
Aguscello;
Cona - Cocomaro - Quartesana;
Malborghetto - Boara - Pontegradella - Focomorto;
Porotto - Cassana.
- "Nuclei del forese", comprensivi delle seguenti strutture insediative:
Francolino-Pescara-Sabbioni-Fossadalbero
Porporana-Ravalle-Casaglia
Borgo Scoline-Fondo Reno
Malborghetto-Corlo-Correggio-Baura-Viconovo
Albarea-Villanova-Denore-Parasacco
Torre Fossa-Fossanova-Gaibanella-S.Egidio-Gaibana
Monestirolo-Marrara
Uccellino-S.Martino-Montalbano
S.Bartolomeo-Spinazzino
Una seconda precisazione riguarda la definizione delle densità edilizie previste per
i contesti riconosciuti con riferimento alle diverse situazioni territoriali e ai diversi
obiettivi di trasformazione previsti. Si hanno:
- 1. Aree di nuovo insediamento nei "Centri urbani".
Densità territoriale prevista (espressa in volume): 1,20 mc/mq (pari ad un indice di
Utilizzazione territoriale espresso in superficie: 0,25 mq/mq di sup.terr.)
E' questa una densità che prevede tipologie edilizie dense, tipiche delle
situazioni urbane più consolidate.
- 2. Aree di nuovo insediamento nella "Prima corona".
Densità territoriale prevista (espressa in volume): 0,90 mc/mq (pari ad un indice di
Utilizzazione territoriale espresso in superficie: 0,18 mq/mq di sup.terr.)
E' questa una densità che prevede tipologie edilizie miste che,
accompagnano zone a media densità, con ambiti in grado di costruire
spazi precisi e definiti spazi pubblici e parcheggi.
- 3. Aree di nuovo insediamento nei "Nuclei del forese".
Densità territoriale prevista (espressa in volume): 0,60 mc/mq (pari ad un indice di
Utilizzazione territoriale espresso in superficie: 0,12 mq/mq di sup.terr.)
E' questa una densità che prevede tipologie edilizie a bassa densità (case
isolate, schiere, ecc.) con altezze massima di tre piani e con una quantità
di spazio aperto (pubblico e privato) compatibile con il contesto rurale in
cui si collocano gli interventi.
- 4. Aree di riqualificazione nelle "Aree centrali".
Densità territoriale prevista (espressa in volume): 2,50 mc/mq (pari ad un indice di
Utilizzazione territoriale espresso in superficie: 0,50 mq/mq di sup.terr.)
E' questa una densità che, similmente a quella già prevista dal piano
vigente, consente la ricostruzione di parti di città dense al cui interno
possono giocare un ruolo determinante gli spazi pubblici.
- 5. Aree di riqualificazione nei "Centri urbani".
Densità territoriale prevista (espressa in volume): 2,00 mc/mq (pari ad un indice di
Utilizzazione territoriale espresso in superficie: 0,40 mq/mq di sup.terr.)
E' questa una densità che consente la ricostruzione di parti di città
dismesse, od altrimenti dedicate, confrontandosi con le condizioni
dell'immediato contesto.
- 6. Aree di riqualificazione nella "Prima corona".
Densità territoriale volumetrica prevista: 1,50 mc/mq (pari ad un indice di Utilizzazione
territoriale di 0,30 mq/mq di sup.terr.)
E' questa una densità che consente la ricostruzione di parti di città
dismesse, od altrimenti dedicate, confrontandosi con le condizioni
dell'immediato contesto.
- 7. Aree di riqualificazione nei "Nuclei del forese".
Densità territoriale prevista (espressa in volume): 1,00 mc/mq (pari ad un indice di
Utilizzazione territoriale espresso in superficie: 0,20 mq/mq di sup.terr.)
E' questa una densità che consente la ricostruzione di parti di città
dismesse, o altrimenti dedicate, confrontandosi con le condizioni in
questo caso rurali, dell'immediato contesto.
- 8. Aree di nuovo insediamento artigianale/produttivo.
Densità territoriale prevista (espressa in superficie): 0,50 mq/mq.
- 9. Aree di nuovo insediamento direzionale/commerciale.
Densità territoriale prevista (espressa in superficie): 0,60 mq/mq.
Le densità proposte si misurano con una serie di obiettivi generali sulla natura
delle nuove parti urbane che pongono una particolare attenzione al rapporto tra lo
spazio aperto e lo spazio edificato. Un rapporto che, contrariamente alle consuete
modalità di realizzazione dei tessuti residenziali di espansione, punti sul ruolo dello
spazio aperto non riducendolo: alle strade di distribuzione, ai minimi per i parcheggi
previsti dalla legge, alle aree verdi quasi inutilizzabili. Queste densità partono dal
presupposto che gli obiettivi di qualità dei nuovi insediamenti, passano anche per
una definizione quantitativa delle densità edilizie che tenga conto della necessità di
avere quantità di aree verdi maggiori che nel passato. E' questo un obiettivo su cui
devono convergere tutti gli strumenti di piano, è infatti un aspetto che coinvolge la
definizione delle quantità, del disegno del principio di insediamento, ma anche del
disegno preciso degli interventi (che sarà contenuto nei Progetti Norma dei Piani
Operativi).
Parallelamente vi è la scelta di utilizzare, per la definizione delle densità edilizie,
il parametro della superficie (più precisamente la "Superficie utile" - Su) in luogo
del più tradizionale indice volumetrico. E' questo un tema che sarà sviluppato
soprattutto nel Regolamento Urbanistico Edilizio, ma che nel PSc definisce un primo
elemento di riferimento. Il presupposto di questa modifica sta nella sostanziale
"svalutazione" degli aspetti dimensionali (volume o superficie) nell'ottica di
un maggior controllo della qualità degli interventi. In altre parole, se l'obiettivo è
la definizione di tipologie edilizie adeguate, di un corretto rapporto tra l'edificio e
l'immediato intorno, di una qualità degli spazi interni non ridotta dai tentativi di
massimo sfruttamento del potenziale edificatorio. Se tutto ciò rappresenta un
obiettivo per i nuovi insediamenti edilizi, allora i parametri urbanistici devono essere
diversi, più specifici e diretti come ad esempio: la tipologia edilizia, il rapporto di
copertura e di permeabilità dei suoli, ecc. Nel qual caso il parametro di controllo
della densità edilizia deve essere in grado di garantire la flessibilità e qualità degli
spazi interni non contribuendo a costruire meccanismi forzosi di riduzione delle
altezze utili degli spazi di distribuzione e dei locali abitabili oppure di interramento
dei vani. Parallelamente, dal parametro utilizzato è previsto il non conteggio dei
principali spazi di distribuzione e di servizio con l'obiettivo di incentivare soluzioni
distributive e spaziali che non sacrifichino tali ambiti in funzione del massimo
utilizzo della capacità edificatoria. Il parametro edificatorio basato sulla superficie
rappresenta perciò uno dei presupposti per una gestione più appropriata di questi
aspetti e contemporaneamente consente di"avvicinare" la misura urbanistica della
capacità edificatoria ai parametri utilizzati dal mercato immobiliare.
Un ulteriore aspetto relativo al dimensionamento del PSC di Ferrara sta nel fatto
che le densità previste (e quindi il dimensionamento degli Ambiti di piano), non
rappresentano, come già nel Prg vigente, i "diritti edificatori" delle aree interessate.
In altre parole, la "capacità insediativa" (cioè quanto si può "costruire") di un ambito
di "nuovo insediamento" non corrisponde ai suoi "diritti edificatori" (cioè quanto
"vale"). Questa differenza è legata all'applicazione del principio di distribuzione
perequata dei diritti edificatori tra tutte le aree interessate dalle trasformazioni
urbane (aree di nuovo insediamento, aree di riqualificazione, aree per servizi, aree
di compensazione, aree di riqualificazione urbana, ecc.)che caratterizza il PSC e che
è descritto nei capitolo seguenti.
|
REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO.
Definizioni dei parametri
urbanistici della capacità
edificatoria.
|
Art Superficie utile (Su)
- La Superficie utile è la superficie che comprende le parti degli edifici utilizzate
per le funzioni fondamentali delle attività che in essi si svolgono e concorre a
determinarne il carico urbanistico.
- Si definisce Superficie utile (Su), la superficie di pavimento di tutti i piani di
un edificio, al netto di murature, pareti, pilastri, muri, tramezzi ed ogni altra struttura
interna ed esterna. Non costituisce aumento di Su la demolizione di muri interni
di edifici esistenti, o di nuovi edifici se realizzata dopo l'ultimazione dei lavori, anche
successivamente all'entrata in vigore del presente piano. Non costituiscono superficie
utile edificabile gli spazi, i vani o le porzioni di vano, aventi altezza massima
minore o uguale a m. 1,80.
- Non costituisce superficie utile la superficie destinata ad accessori e servizi
che contribuisce a migliorare la qualità dell'abitare o la fruizione degli insediamenti,
senza aumentare il carico urbanistico, cosi come di seguito specificata:
-Vani e spazi di uso comune condominiale (androni di ingresso, vani scala e
vani ascensore esterni alle unità immobiliari, tettoie per ricovero auto e biciclette e
altri locali di uso comune, cantine; locali per impianti tecnologici quali centrali termiche,
idriche, di climatizzazione, cabine elettriche, locali per contatori elettrici, ecc.).
- Vani ascensore , vani scala interni, montacarichi e locali per impianti tecnologici
al servizio di singole unità immobiliari;
- Scale di sicurezza esterne o interne quando imposte da norma di sicurezza o
di prevenzione incendi;
- Autorimesse pertinenziali, singole o comuni, fuori terra, entro terra o semplicemente
coperte, con relativi spazi di manovra;
- Porticati pertinenziali alla singola unità immobiliare, di uso comune e percorsi
pedonali coperti in genere, porticati pubblici o di uso pubblico;
- Balconi, terrazze e logge.
- Tettoie , purché non pertinenziali di attività produttive o commerciali
- Vani risultanti dai sottotetti non accessibili.
- Magazzini, depositi e archivi, solo se interrati e pertinenziali.
- Gli scomputi di cui al precedente 3° comma non potranno eccedere il limite di
0,70Su. La superficie eccedente sarà computata come Su.
Art. Superficie territoriale (St)
- La Superficie territoriale è la porzione di territorio che comprende sia le aree di
pertinenza degli edifici sia le aree destinate alle opere di urbanizzazione, generalmente
soggetta a intervento urbanistico unitario. Essa viene individuata dal POC e
si misura in mq.
Art. Utilizzazione territoriale (Ut)
- Rappresenta il rapporto fra la Su fisicamente realizzabile su un'area, come stabilita
da presente piano all'art. [...], e la rispettiva St. Si misura in mq/mq
Art. Diritto di edificazione (De)
- Rappresenta il rapporto fra la Su potenziale attribuita dal POC, ai sensi dell'art.
[...], ad un'area e la rispettiva St. Il POC stabilisce se il De è realizzabile sull'area medesima
o deve essere trasferito su altra area edificabile. Il De si misura in mq/mq.
|
|
|
Una lettura del dimensionamento del PSC di Ferrara(restituito nelle tabelle riportate
di seguito) mette in evidenza il più generale obiettivo di contenere l'espansione del
suolo urbano e di indirizzare lo sviluppo verso il consolidamento e il completamento
dei tessuti esistenti. Ciò risulta leggibile sia dall'incidenza della riqualificazione
rispetto ai nuovi insediamenti, che dalla ridotta quantità di aree e di volume introdotti
rispetto al piano vigente anche in funzione dei differenti tempi di validità dei due
strumenti urbanistici (10 anni il Prg, non definito il PSC). D'altra parte il doppio
livello cui fa riferimento la pianificazione comunale (quello strutturale e quello
operativo) fanno si che le previsioni dimensionali del PSC, rappresentino, come
detto in precedenza, i valori massimi su cui attestare le scelte della successiva
pianificazione operativa. Spetterà quindi al Regolamento Urbanistico Edilizio e ai
Piani Operativi Comunali stabilire, in funzione degli aspetti specifici del territorio e
del periodo considerato, le quantità effettivamente realizzabili sul territorio.
Dal dimensionamento emerge anche la previsione di una rilevante quantità di
aree per servizi. E' questo un dato che risente dell'interpretazione del tema delle
dotazioni territoriali nella direzione di considerare l'interesse pubblico non solo per
le aree destinate alla realizzaizone dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ma
anche a quelle necessarie al buon funzionamento del territorio (aree di mitigazione
e di compensazione). Il PSC, così come la nuova legge regionale, stabilisce l'utilità
pubblica di tali aree e quindi la loro classificazione come "dotazioni territoriali"
necessarie alla comunità. Questa consistente quantità di aree per servizi deve
necessariamente misurarsi anche con il problema della loro effettiva realizzazione.
Ciò a maggior ragione in un piano che si propone la sostenibilità dello sviluppo e
si misura con la scarsità delle risorse disponibili. Vedremo in seguito come una
possibile soluzione a tale problema possa venire dall'interpretazione allargata degli
standards urbanistici (a comprendere anche le aree di riqualificazione ambientale)
associata alla distribuzione perequata dei diritti edificatori anche su tali aree al fine
di una loro acquisizione/realizzazione a carico degli interventi edilizi.
A partire da queste considerazioni il dimensionamento del PSC può essere
organizzato, all'interno dei Sistemi individuati dal PSC, secondo gli ambiti previsti
dalla legge e raggruppati in alcuni insiemi territoriali. Le tabelle riportate alle pagine
seguenti restituiscono tali letture.
|
| Ambiti del sistema residenziale
|
| AMBITI |
AREE CENTRALI-CENTRI URBANI |
PRIMA CORONA -NUCLEI FORESE |
TOTALE |
| ST |
Su |
V |
ST |
Su |
V |
ST |
Su |
V |
| mq |
mq |
mc |
mq |
mq |
mc |
mq |
mq |
mc |
| PREVISIONE PRG vigente |
|
2.388.878 |
|
296.886 |
|
2.685.764 |
| RESIDUO DAL PRG vigente |
|
|
|
| SOSTITUZIONE / RIQUALIFICAZIONE (
PSC) |
1.025.378 |
410.151 |
2.050.756 |
296.433 |
35.499 |
178.409 |
1.321.811 |
445.650 |
2.229.165 |
| PREVISIONE PRG vigente |
|
895.099 |
|
1.922.974 |
|
2.818.073 |
| RESIDUO DAL PRG vigente |
|
465.673 |
|
854.599 |
|
1.320.272 |
| NUOVI INSEDIAMENTI (PSC) |
738.534 |
184.634 |
886.241 |
1.510.390 |
217.695 |
1.118.218 |
2.248.924 |
402.328 |
2.004.458 |
| PREVISIONE PRG vigente |
|
3.283.977 |
|
2.219.860 |
|
5.503.837 |
| RESIDUO DAL PRG vigente |
|
|
|
| TOTALE (PSC) |
1.763.912 |
594.785 |
2.936.997 |
1.806.823 |
560.447 |
1.296.626 |
3.570.735 |
847.978 |
4.233.623 |
|
| Ambiti del sistema produttivo
|
|
|
|
PRG VIGENTE
RESIDUO
St (
mq) |
PSC
PREVISIONI
St (
mq) |
| PICCOLA MEDIA IMPRESA |
1.332.000 |
2.684.000 |
| Area via Bologna (est) |
369.000 |
511.000 |
| Area via Bologna (ovest)(-45.000) |
|
133.000 |
| Nuova area Casello Fe-sud |
199.000 |
1.046.000 |
| Nuova area Casello Fe-nord |
764.000 |
1.039.000 |
| CITTA' DELL'AUTO |
212.000 |
235.000 |
| Area via Bologna |
212.000 |
212.000 |
| |
|
23.000 |
| CAVE |
1.098.000 |
1.098.000 |
| Area ovest |
1.098.000 |
1.098.000 |
| RIEPILOGO |
2.642.000 |
3.787.000 |
|
|
4. Luoghi e azioni del piano
|
La necessità di indagare con maggiore precisione le potenzialità di trasformazione di
alcune parti di territorio, nasce dalla consapevolezza che i caratteri di frammentarietà
ed eterogeneità riconosciuti nella città contemporanea non sono governabili sempre
nello stesso modo. D'altro canto, la continuità dell'attività edilizia e amministrativa
e, quindi, la necessità di governare le trasformazioni del territorio anche durante
la costruzione del PSC, hanno evidenziato temi e questioni che, pur derivando da
percorsi esterni al nuovo strumento urbanistico, hanno dovuto tuttavia essere
verificati e collocati all'interno dei suoi obiettivi principali.
A partire dall'attenzione che in questi anni la società locale, le forze economiche,
gli attori politici hanno dedicato alla città, esercitando un'azione di selezione nei
confronti di alcuni temi e di alcune aree in particolare, oltre che dalle questioni
emergenti dai programmi e politiche urbane che l'amministrazione si è impegnata
a sostenere (progetti di legislatura, Pru, Prusst, Contratti di Quartiere II, ecc.), sono
stati individuati alcuni "luoghi sensibili" sui quali sono state avviate più approfondite
riflessioni ed esplorazioni progettuali. Luoghi che costruiscono un insieme di risorse
ed opportunità che la città deve necessariamente considerare nella definizione di
ipotesi di pianificazione generale.
Il percorso intrapreso costituisce il tentativo di verificare la rispondenza delle
previsioni strutturali con risorse e opportunità reali per alcuni "luoghi sensibili",
ciascuno dei quali comprende temi e problemi tra loro differenti.
|
| I luoghi del PSC
|
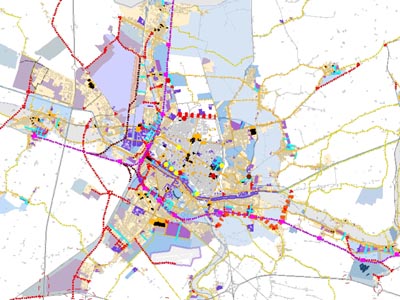 |
|
|
a. IL CENTRO STORICO. Un centro policentrico
|
In primo luogo si è trattato di fissare nuove politiche per il centro storico. Politiche
indirizzate non solo al recupero e restauro di edifici, monumenti e spazi aperti, ma,
anche, alla messa a punto di modi d'uso e di assetti spaziali legati ad un ulteriore
possibile sviluppo di questa parte di città.
A Ferrara, le problematiche tipiche degli ambiti storici, legate alla compresenza
di usi e necessità della città contemporanea con spazi e luoghi derivati dalla
stratificazione della città storica, assumono un aspetto rilevante soprattutto per il
ruolo che la città murata assume nei confronti del resto del territorio.
Infatti, la parte antica della città non costituisce solamente il luogo della memoria di
un importante passato ma è centro politico-amministrativo di rilievo in cui attività di
varia scala (università, attività museali, ecc.) concorrono all'economia complessiva
della città.
Obiettivo del PSC è allora forzare il passaggio da "centro con un unico centro", in cui il
sistema spaziale Duomo-Castello rappresenta il punto nevralgico della città storica,
a "centro policentrico" in cui una pluralità di aree e edifici di rilievo concorrono ad
articolare l'intera parte interna alle mura.
Tale obiettivo è perseguito attraverso la connessione spaziale-funzionale di alcuni
importanti edifici monumentali, il recupero e la trasformazione di aree parzialmente
o totalmente inutilizzate o in via di dismissione, infine attraverso una diversa
organizzazione della circolazione automobilistica, dell'accessibilità al centro, oltre
che degli spazi per la sosta.
In questo modo l'interruzione della circolazione automobilistica sui principali assi
di attraversamento della città antica in senso est-ovest, lungo Corso Giovecca, Viale
Cavour e lungo Corso Porta Po e Corso Portamare consente di riconnettere la trama
dei percorsi pedonali tra la parte medioevale della città a sud e l'Addizione Erculea
a nord. In particolare, garantendo continuità pedonale lungo Corso Ercole d'Este,
il polo Duomo-Castello si riallaccia al Quadrivio degli Angeli riavvicinando al centro
l'originario incrocio dell'Addizione Erculea e, soprattutto, l'insieme di edifici e spazi
aperti che lo costituiscono.
Il ruolo di Polo museale per l'arte contemporanea che dovrebbe caratterizzare
tale ambito è costituito oltre che da Palazzo dei Diamanti, da Palazzo Massari e
dalla possibilità di recupero ad uso museale della Caserma Bevilacqua, di Palazzo
Prosperi Sacrati e di Palazzo Turchi di Bagno, anche dalla possibilità di riportare
all'uso collettivo importanti spazi aperti quali i giardini dello stesso Palazzo dei
Diamanti e del Liceo Ariosto.
Nell'ottica di ampliare l'articolazione dei modi d'uso e degli assetti spaziali del centro,
si colloca anche l'opportunità di recuperare l'area dell'ex Mercato Ortofrutticolo
a sud, il complesso ospedaliero del S.Anna ad est, una volta che l'ospedale si sia
trasferito a Cona, ed infine la Caserma Pozzolo del Friuli ancora ad est. Questo
particolare settore della città, posto nella parte finale di Corso Giovecca, può essere
immaginato come un'altra importante centralità caratterizzata anch'essa da attività
espositive (Polo museale dell'arte antica e Museo Archeologico di Spina) collocate
nei Palazzi Schifanoia, Bonacossi e Marfisa d'Este e Palazzo Ludovico il Moro.
Mentre la nuova centralità del Quadrivio degli Angeli deriva dal rafforzamento del
sistema museale esistente e dalla sua riconnessione con il sistema delle piazze
centrali (Savonarola, del Castello, della Cattedrale, Trento-Trieste, ecc.), invece il
polo museale di Arte antica assieme all'area della Caserma Pozzolo e del S.Anna ad
est, si appoggiano alla trama di percorsi e spazi paralleli a Corso Giovecca e interni
all'Addizione di Nicolò II (Via Gorgadello e la possibile deviazione interna a recuperare
l'ambito di Palazzo Schifanoia) e la sua prosecuzione verso S.Giorgio.
Per perseguire l'obiettivo di interconnettere le nuove centralità risulta allora
necessario recuperare percorsi e passaggi pedonali attualmente celati o
parzialmente non disponibili all'attraversamento pubblico, valorizzare strade e
vicoli attualmente marginali, infine, rendere visibili spazi altrimenti di difficile
percezione.
Un'ulteriore opportunità di riqualificazione del centro è legata alla trasformazione
delle aree che si affacciano sul Po di Volano. Qui gli obiettivi della trasformazione
riguardano sia la navigabilità dell'asta fluviale, sia la sua sistemazione in un'ottica
sportivo-ricreativa.
|
|
b. POLO DI CONA. Un nuovo paesaggio.
|
Un secondo tema riguarda la definizione di uno scenario adeguato all'insediamento
del nuovo polo opedaliero di Cona.
Negli ultimi anni, questo intervento rappresenta una delle più consistenti operazioni
previste sul territorio di Ferrara, la cui importanza è legata non solo alla dimensione e
al ruolo che il nuovo presidio sanitario propone, ma anche alle opportunità prodotte
dalla sua collocazione. La trasformazione di questa porzione di territorio si lega
inoltre anche alla realizzazione della metropolitana leggera lungo la linea ferroviaria
Ferrara-Codigoro, la quale rappresenta un altro significativo investimento compiuto
dalla città.
|
| Macroarea centro.
Un centro policentrico
|
 |
|
La metropolitana ed il consolidamento degli insediamenti di Cocomaro, Cona e
Quartesana posti lungo il suo tracciato costituiscono la prosecuzione dell'asse
est-ovest individuato dal PSC e costituito, oltre che dai consistenti interventi di
riqualificazione lungo il Po di Volano e dell'area dell'ex Foro Boario, anche dalle
aree di consolidamento e di collegamento fra le frazioni di Porotto, Cassana e
Mizzana. In questo tratto ad est, la presenza di un sistema di trasporto alternativo
a quello privato dell'automobile, ma anche a quello dei mezzi pubblici su ruote, che
si fonda sull'uso integrato del treno e della bicicletta, consente di ipotizzare una
forte compatibilità dei nuovi insediamenti con la struttura del territorio, riducendo
al minimo la nuova infrastrutturazione. A questo scopo, la fascia compresa tra la
strada principale e la linea ferroviaria costituisce, da un lato, il luogo dove prevedere
possibili incrementi residenziali a completamento dei nuclei esistenti (ad esempio,
vicino alle fermate della metropolitana), dall'altro l'ambito dove coniugare attività
agricola e usi collettivi dello spazio aperto, cercando di mantenere una sequenza di
pieni edificati e vuoti rurali.
I nuovi insediamenti prevalentemente a bassa densità dovrebbero ricercare un
rapporto virtuoso con gli elementi naturali del territorio, ed in particolare favorire
una più stretta connessione tra gli abitati ed il Po di Volano.
|
| Macroarea Polo di Cona.
Un nuovo paesaggio
|
 |
|
|
c. VIA BOLOGNA. Reti e connessioni
|
Un terzo tema riguarda la parte sud di Ferrara attraversata da Via Bologna. L'area
di Via Bologna, a sud delle mura, rappresenta uno dei luoghi in cui è avvenuta la
crescita recente della città di Ferrara e, per questo, comprende una molteplicità
di insediamenti: dai quartieri "disegnati" dell'edilizia pubblica, ai tessuti ripetuti di
edifici isolati; dai grandi edifici contenenti attività commerciali e di servizio di livello
sovracomunale, ad alcuni complessi dismessi o in via di dismissione come l'ex Foro
Boario e lo scalo ferroviario.
Se la compresenza di elementi così eterogenei è da associarsi alla rapida crescita
di questa parte della città, allora l'obiettivo della sua riqualificazione può essere
perseguito cercando di forzare i caratteri peculiari e recuperando la distanza che
la separa dalla città antica. In quest'ottica, l'attuale marginalità del quartiere di
Via Bologna, il suo carattere periferico possono trasformarsi in qualità urbana
attraverso un attento progetto delle parti pubbliche e la costruzione di un sistema
di connessioni tra i quadranti del tessuto edilizio, attualmente separati da assi
stradali ed altre infrastrutture.
Qui si tratta di potenziare il sistema di relazioni con la città storica attraverso la
ridefinizione della fascia di insediamenti posta lungo il Po di Volano; attraverso
l'importante sistema di superfici verdi a ridosso delle mura di connettere alcuni
grandi spazi aperti esistenti come l'ippodromo, gli assi ferroviari da dismettere,
l'area della fiera, e di progetto come il parco sud con il parco nord e quindi con il
Po grande; per mezzo della risignificazione dell'asse di Via Bologna rafforzare
le relazioni tra l'area ad est e quella ad ovest, chiarendo al contempo le relazioni
di compatibilità ed incompatibilità tra le aree produttive presenti e il più minuto
tessuto residenziale che caratterizza questa parte di città.
Gli interventi riguardano sia alcune importanti modificazioni degli assi infrastrutturali,
sia la possibilità di mutare radicalmente l'uso e l'assetto di alcune parti del tessuto
edilizio.
In particolare l'interramento delle due linee ferroviarie per Ravenna e Codigoro
che attraversano in senso est-ovest il tessuto edilizio; lo spostamento verso
sud dell'area demaniale dell'aeroporto e la possibilità di riutilizzare gli ambiti
attualmente occupati dalla pista di atterraggio; il prolungamento verso sud di Via
Ferraresi in alternativa a Via Bologna per l'accesso alle aree produttive e alle zone
centrali a nord; il riuso dell'area pubblica dell'ex Foro Boario e dello scalo ferroviario
da dismettere e l'ampliamento del comparto residenziale militare.
Il disegno perseguito dal PSC per questa parte di città prevede, quindi, di
recuperare il ruolo degli spazi pubblici e degli spazi aperti entro un'ipotesi di loro
"riammagliamento", e ciò avviene attraverso reti di percorsi e aree verdi, ortogonali
e parallele a Via Bologna, costituite principalmente dall'ex Foro Boario-assi ferroviari
da dismettere, area Fiera-nuove aree artigianali; dall'area verde parallela a Via
Ferraresi e dal nuovo parco sud.
La maglia di percorsi che ne deriva, si propone di garantire anche un corretto
funzionamento idraulico del territorio, legato sia al mantenimento e all'eventuale
aumento della quota di suolo urbano permeabile, sia alla conservazione e definizione
di nuovi varchi nel tessuto edilizio tali da permettere il corretto flusso delle acque.
I percorsi verdi con direzione est-ovest hanno l'obiettivo di interrompere la problematica
continuità degli assi di Via Bologna e di Via Ferraresi, della linea ferroviaria e
dell'autostrada per Bologna. Contemporaneamente, alcune superfici possono divenire
parte dello stesso sistema idraulico assumendo, in funzione della loro dimensione e
localizzazione, il ruolo di aree di riserva (casse di espansione) e contenimento nei
momenti di maggior difficoltà del sistema di smaltimento delle acque.
Questo specifico obiettivo è perseguito principalmente attraverso la previsione, nella
fascia compresa tra Via Ferraresi e la ferrovia, di una vasca di espansione relativa alla
parte ovest del bacino idraulico che scola nel Primaro. Una sistemazione vegetale
adeguata alla presenza dell'acqua e che ricerchi la continuità con gli spazi verdi a
nord, porta alla definizione di un nuovo paesaggio per Via Ferraresi, caratterizzato
dalla presenza di una fascia boscata ad ovest e di un sistema di spazi legati alla città
della macchina ad est. Un corretto funzionamento idraulico dell'area richiede inoltre
la previsione di ulteriori ambiti da adibire al contenimento delle acque, localizzati
ad est, a ridosso degli insediamenti militari e dell'area di espansione artigianale.
|
| Macroarea via Bologna
Reti e connessioni.
|
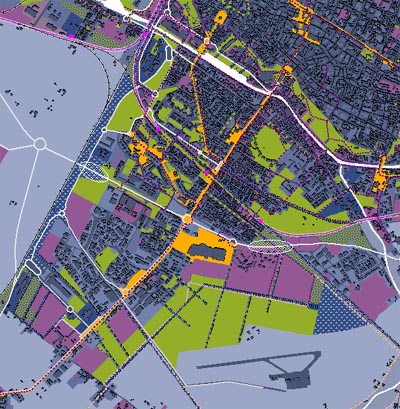 |
|
D'altro canto, un adeguato funzionamento del sistema di scolo delle acque, è reso
vieppiù necessario dalla previsione di nuovi insediamenti residenziali e produttivi
legati, da un lato, al completamento dei tessuti esistenti, dall'altro alle importanti
richieste di espansione del presidio militare.
Un ultimo, ma non meno importante intervento, è la definizione del parco sud, già
contenuto nelle previsioni dello strumento urbanistico vigente.
Nel PSC il progetto del parco si misura, da un lato con le specifiche opportunità
di trasformazione di questa parte urbana, dall'altro con la possibilità di ridefinire
il suo ruolo non solamente rispetto al quartiere, ma anche in relazione al sistema
urbano degli spazi verdi che dal parco sud si spingono a nord fino a raggiungere il
Po grande.
Il progetto del nuovo parco sud prevede:
- una prima fascia a ridosso dell'edificato ospitante le attrezzature sportive e di
servizio legate al quartiere che svolge il ruolo di filtro tra la parte edificata e gli spazi
aperti più prossimi. Per questa ragione oltre ed essere caratterizzata da ampie parti
boscate garantisce il collegamento diretto tra la città e lo spazio agricolo attraverso
la prosecuzione di alcuni assi stradali esistenti.
- una seconda, più grande, area verde, posta tra la prima fascia e lo spazio agricolo
vero e proprio, rappresenta un ulteriore ambito del parco entro cui si collocano, oltre
alla nuova pista dell'aeroporto, anche attrezzature sportive di livello comunale ed
alcuni percorsi ciclabili collegati agli ambiti naturalistici che caratterizzano questa
parte del forese.
Inoltre, il disegno del parco si confronta con le previsioni di espansione delle
residenze militari collocate a nord, salvaguardando alcuni passaggi verso le aree
dell'ippodromo, del Volano e delle mura, poste ancora più a nord.
|
|
d. AREA OVEST. Recinti e fasce boscate.
|
Per quanto riguarda l'ambito a nord-ovest, il PSC propone di stabilire una relazione
più forte tra le diverse parti urbane che lo compongono e tra queste e il resto della
città.
Più precisamente, in questa parte di territorio caratterizzata dalla compresenza
di grandi insediamenti industriali (ex-Montedison, ex-Solvay, ecc.), vaste aree
dismesse disponibili alla trasformazione (ad esempio, l'area ex-Eridania),
attrezzature urbane di servizio (carceri, scalo merci, ecc.), ed infine ambiti
residenziali (quartieri di Porotto, Cassana, Mizzana, Doro, Barco e Pontelagoscuro),
cui si sovrappone un'altrettanto ricca ed articolata dotazione di infrastrutture: strade
di accesso alla rete autostradale, rete ferroviaria e corridoio adriatico, canali collegati
alla rete fluviale del Po, abbiamo riconosciuto il ruolo strutturale della sequenza di
spazi industriali-commerciali e delle fasce di compensazione, in modo particolare
dell'area compresa tra Via Modena e l'inceneritore che consente di ridurre l'impatto
di questa infrastruttura sui tessuti residenziali limitrofi.
Per Via Modena si ipotizza un processo di riqualificazione che la fa diventare spazio
di riferimento delle frazioni, luogo principale delle loro relazioni. Tale possibilità, che
prevede un adeguato collegamento ciclabile fra Porotto e Cassana ma anche con
il centro della città, si lega alla realizzazione di una bretella stradale che supera
verso ovest il centro di Porotto liberando Via Modena dal traffico diretto al casello
autostradale, alle zone industriali e al centro città.
Più a sud, la natura residenziale della parte compresa tra Via Modena e Via Arginone,
è confermata e rafforzata dalle trasformazioni delle aree dismesse dell'ex Eridania
dove, oltre ad edifici commerciali e di servizio, sono previste anche consistenti
quote residenziali.
I frammenti di tessuto urbano, di dimensioni più o meno rilevanti, compresi in
questa parte di città sono collegati tra loro dall'area verde collocata tra Via Modena
e Via Arginone la cui prosecuzione, attraverso l'area ex Eridania, consente un
collegamento, diretto e alternativo alla stessa Via Modena, con la stazione ferroviaria
e quindi con il resto della città. Tale collegamento è reso possibile dall'utilizzo
dell'attuale ponte ferroviario sul canale Boicelli a fini ciclo-pedonali.
|
| Macroarea ovest.
Recinti e fasce boscate
|
 |
|
La chiusura dello scalo merci presente nell'area della stazione, e la previsione del
nuovo collegamento ferroviario dell'area del Petrolchimico direttamente sul nuovo
corridoio adriatico, consentono di ridisegnare le aree attualmente interessate da
tali infrastrutture nella direzione di un loro sviluppo in senso urbano rafforzando il
carattere residenziale di questa parte di territorio. Ciò avviene sia per la previsione di
nuovi spazi e luoghi di relazione (aree verdi e piste ciclabili), sia per il miglioramento
della compresenza tra residenza e altre attività (carceri, attrezzature commerciali,
ecc.), attraverso un adeguato ridisegno di recinti e bordi.
Un ruolo analogo è affidato, nella parte a nord, agli spazi verdi. Qui, i quartieri
Barco e Pontelagoscuro, costruiti a ridosso del petrolchimico e compresi tra la
congestionata Via Padova e la linea ferroviaria, sono delimitati da due fasce verdi
che rappresentano, ad ovest, una barriera rispetto all'area industriale e alla strada
di scorrimento, a est un elemento di relazione con il più importante parco urbano.
Come per le altre parti di città anche in questo caso il PSC articola il sistema delle
relazioni tra le parti urbane e tra queste e il centro. In particolare la rete di piste
ciclabili del parco urbano, l'asse di Via Bentivoglio e i luoghi centrali dei due quartieri
diventano i principali protagonisti del sistema di connessioni proposto. Inoltre,
l'accessibilità a questi nuclei residenziali è legata alla previsione del prolungamento
verso nord della metropolitana leggera e le tre fermate di Pontelagoscuro, Barco,
e Via Bianchi previste in corrispondenza degli assi centrali dei quartieri, possono
rappresentare una nuova modalità di accesso al parco nord che sfrutta l'ipotesi di
un servizio integrato treno-bicicletta.
La sistemazione delle strutture e dei recinti, così come l'ipotesi di costituzione
di fasce boscate di compensazione e di aree verdi, può avvenire nell'ambito della
realizzazione delle nuove attrezzature o dei nuovi insediamenti residenziali. Un tale,
ambizioso, programma presuppone, naturalmente, il coinvolgimento dei differenti
soggetti interessati alle trasformazioni fin dalle fasi iniziali della discussione
per mettere a punto adeguate procedure di costruzione dei progetti oltre che di
realizzazione e gestione delle aree.
|
|
e. I CENTRI DEL FORESE. Strutture insediative
|
Il PSC considera i centri del forese non semplicemente come frazioni di Ferrara.
Essi sono visti come "specifici paesi" che formano complesse ed articolate
strutture urbane: lungo il Po Grande la struttura Casaglia-Ravalle-Porporana e
quella Francolino-Pescara-Sabbioni, lungo il Po di Volano la struttura Cocomaro di
Focomorto-Cona Codrea-Quartesana, i due centri Contrapò-Baura e la sequenza
Viconovo-Albarea-Villanova-Denore, Lungo il Po di Primaro l'articolata struttura
Fossanova-Gaibanella-S.Egidio-Gaibana-Marrara-Monestirolo, ed infine, i due centri
di S. Martino e S. Bartolomeo.
Obiettivo principale è allora quello di rendere maggiormente coese tali strutture,
soprattutto per quanto riguarda la dotazione e la fruizione dei servizi. A tal fine il PSC
suggerisce da un lato di completare e compattare i centri con nuove edificazioni di
modesta entità e con nuove aree per servizi; dall'altro di potenziare i collegamenti
ciclabili e pedonali tra i centri e tra questi e gli spazi aperti lungo i corsi d'acqua.
Gli schemi riportati di seguito indicano le forme di questo consolidamento
individuando le aree in cui collocare i nuovi insediamenti residenziali (con il colore
viola), le aree per i servizi (con il colore bleu), le centralità e gli assi di connessione
(con il colore giallo-ocra) e le principali opere infrastrutturali (con il colore rosso).
|
| Macroaree forese.Parte nord
|
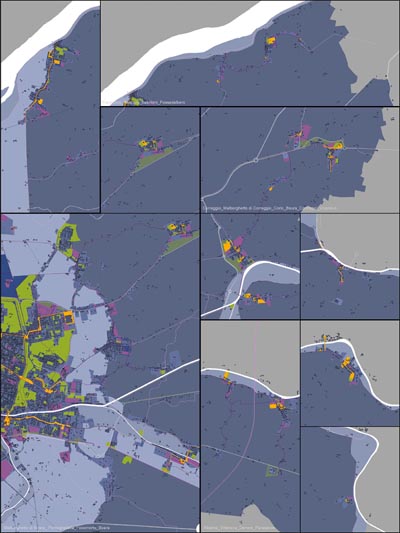 |
|
| Macroaree forese.Parte nord
|
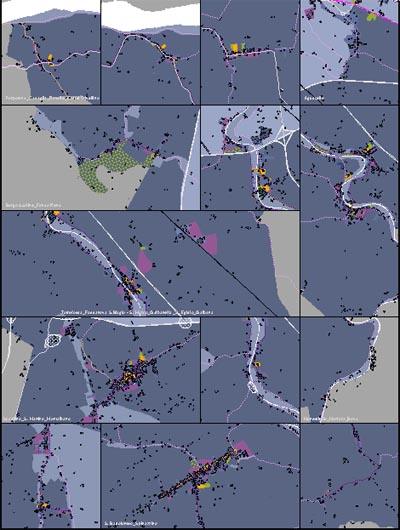 |
|
|
5. Forme e procedure di gestione della città
|
La traduzione delle ipotesi di trasformazione della città di Ferrara in uno strumento
di governo del territorio incrocia la significativa e profonda revisione degli strumenti
di pianificazione, contenuta nella recente riforma urbanistica regionale.
La legge regionale 20/2000 ha introdotto nella pianificazione comunale modifiche
sostanziali rispetto al modo tradizionale di concepire, costruire e gestire il piano.
Le innovazioni riguardano sia il ruolo del piano rispetto alle politiche di governo del
territorio sia gli aspetti formali e procedurali della sua attuazione.
L'impostazione della nuova disciplina urbanistica regionale rende possibile la
definizione di modi innovativi e più efficaci di costruzione e gestione del piano;
modi che a partire dal riconoscimento della ridotta efficacia del Prg tradizionale,
stabiliscano meccanismi di governo del territorio in grado di ridurre la distanza tra
la fase programmatoria e quella realizzativa.
Il rinnovamento degli strumenti urbanistici sollecita una discussione sui contenuti
del piano, oltre che una riflessione sulle sue possibili innovazioni formali: sui
documenti di cui è composto (testi e tavole, norme e progetti, indicazioni e
prescrizioni, ecc.), sul ruolo e il significato di ognuno di questi, e infine, sulla
precisazione dei modi per una sua più proficua gestione.
Parallelamente, il piano urbanistico oggi deve affrontare con più decisione che in
passato alcune questioni rilevanti, correggendo alcuni degli strumenti su cui negli
anni passati si è fondata l'attività di pianificazione e che appaiono sempre più
inefficaci.
In primo luogo si tratta di rivedere l'istituto dell'esproprio e la sua "debolezza"
quale strumento unico per l'acquisizione delle aree pubbliche. Una seconda
questione riguarda il rapporto pubblico/privato considerato ormai maturo e reso
sufficientemente credibile delle molteplici esperienze dei piani/programmi di
riqualificazione urbana. Una terza questione è relativa al sempre maggiore interesse
rivolto ad una gestione strategica del territorio che non contrasti con una visione
strutturale. Infine, a partire dalle più interessanti esperienze di perequazione
urbanistica, si tratta di definire nuove e più efficaci forme di controllo della rendita
fondiaria.
Come di consueto l'introduzione di un nuovo strumento, in questo caso del PSC,
sospingerà i più a chiedersi quali benefici esso apporti alla città e alla comunità che
la abita, a fare confronti e paragoni chiedendosi se esso sia più semplice, efficace
e adeguato ai tempi rispetto al vecchio PRG; se il nuovo piano sia in grado di dare
risposta ai tanti problemi lasciati insoluti dal PRG.
Un Piano è un contenitore di fatti e fenomeni desiderabili: innovazione, cambiamento,
vitalità, nuova identità. Ma come può l'urbanistica, ed il Nuovo piano di Ferrara,
aiutare ad avviare questi cambiamenti? Oltre a porsi alcuni obiettivi virtuosi,
attraverso quale forma e quali procedure riesce a perseguirli?
Va ricordato che quello presentato qui è solo il PSC: RUE E POC sono in corso
di elaborazione. E' importante ricordare ciò perché da solo il PSC non è sufficiente
a governare le trasformazioni di una città, è uno strumento incompleto, manca dei
dispositivi che lo rendono funzionante. Ed è solamente assieme a RUE e POC che il
PSC può essere confrontato al vecchio PRG.
|
|
a. Forma: tre carte riferite a diversi soggetti. Gestione, prestazioni,
progetti.
|
Dalle considerazioni fin qui svolte, risulta forse più chiara l'utilità di riflettere sugli
aspetti formali del nuovo strumento urbanistico. Non si tratta solo di discutere un
modo diverso di costruire ed utilizzare gli elaborati, le procedure di approvazione
e le modalità di gestione del piano, ma anche di verificare se la qualità del piano
non passi anche attraverso una più adeguata definizione della sua struttura logicoformale.
La forma che ha caratterizzato il Prg tradizionale è omogenea, basata sulla
continuità, riconducibile ad una geometria lineare.
La complessità che esso ha
affrontato è, infatti, legata più alla quantità delle questioni trattate che alla loro
articolazione. Nel Prg tradizionale la traduzione della realtà è avvenuta secondo
strutture semplici, costruite a partire dal rapporto biunivoco tra un'unica ed a volte
minuziosa classificazione del territorio, e un apparato normativo ad essa collegato.
Questa "forma" di pianificazione ha funzionato per molto tempo ed ha accompagnato
la fase di "crescita" delle città, sostenuta dall'ipotesi che la gestione del territorio
fosse realizzabile come "somma" delle sue diverse parti. Da tale presupposto è
derivata la necessità di riconoscere, programmare e gestire parti omogenee e
funzionalmente distinte del territorio, le Zone Territoriali Omogenee.
Negli anni recenti, alle discipline che si occupano del territorio -ma non solo a
queste- la realtà è apparsa sempre più come un palinsesto di frammenti, in molti
casi non compiuti, nei quali sono difficilmente riconoscibili aspetti di omogeneità
e continuità: porzioni di città e di campagna la cui principale caratteristica è
l'eterogeneità delle forme fisiche, delle destinazioni funzionali e dei soggetti che le
abitano.
Il riconoscimento dell'eterogeneità come carattere pervasivo del territorio ha portato a
deformare la "forma" del Prg attraverso una moltiplicazione e scomposizione sempre
maggiore delle zone omogenee che si sono trasformate in "microzone"; invece, il
nuovo piano ha riconosciuto questa condizione proponendo due diverse modalità
di articolazione della sua forma: l'articolazione nel "tempo" con l'introduzione del
livello strutturale e di quello operativo, e l'articolazione nello "spazio" attraverso
la sostituzione della categoria delle "zone omogenee" con quella, più eterogenea,
dei "sistemi". Questa articolazione ha consentito al Nuovo piano di misurarsi con
la complessità del territorio e del suo funzionamento, riconoscendo l'eterogeneità
come valore, elemento di ricchezza in grado di offrire molteplici opportunità di
sviluppo e crescita, legate non solamente all'espansione, ma anche e soprattutto
alla riqualificazione della città esistente.
Su questi presupposti Il PSC di Ferrara fonda la sua forma "stratificata", costituita da
tre diversi livelli tematici:
- il DISEGNO DEL PIANO,
- i CONTENUTI DEL PIANO,
- le PROCEDURE DEL PIANO.
Ciascun livello, rappresentando uno specifico insieme di questioni, costituisce una
modalità di accesso e di lettura alle informazioni del piano capace di confrontarsi
con la molteplicità degli interessi e dei soggetti che solitamente incrociano il piano
urbanistico, i quali possono trovare nel piano una più esplicita rappresentazione.
Più precisamente, nel livello del DISEGNO DEL PIANO è rappresentata la prefigurazione
della "città futura". Ciò avviene sia attraverso una mappa in cui sono identificate
le aree coinvolte dal progetto di trasformazione ed i materiali di cui si compongono
(e che diventa traccia per la formazione degli strumenti di pianificazione della successiva
fase operativa), sia attraverso una serie di mappe che descrivono alcuni
particolari aspetti il cui buon funzionamento garantisce una "qualità diffusa" del
territorio (ambiente, mobilità, sistema idraulico). I CONTENUTI DEL PIANO riportati
nelle mappe degli Ambiti e dei Sistemi, definiscono le prestazioni che ciascuna porzione
di territorio deve garantire e si caratterizza come uno schema di direttive ed
indicazioni per le fasi successive, oltre che riferimento per una verifica qualitativa e
quantitativa degli obiettivi generali previsti. Gli aspetti relativi alla definizione delle
procedure per l'implementazione delle trasformazioni previste sono invece contenuti
nel livello GESTIONE DEL PIANO.
La forma del PSC emerge anche dalla struttura delle Norme di Attuazione che lo accompagnano.
Spesso, infatti, le norme del piano sono considerate come una sorta
di manifesto delle sue intenzioni più profonde ed anche nel caso del PSC l'indice
delle norme consente di rendere leggibile la sua struttura formale.
|
| INDICE/MANIFESTO DELLE
NORME TECNICHE DEL PSC
|
titolo - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
art. - Oggetto e contenuti delle presenti norme
art. - Riferimenti normativi
art. - La forma del Piano strutturale. Elaborati.
art. - Il linguaggio del Piano strutturale. Definizioni.
art. - Indirizzi per la formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio
art. - Indirizzi per la formazione dei Piani Operativi Comunali
titolo I - I CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE: obiettivi e prestazioni
capo i - Disciplina dei Sistemi
art. - Disposizione generali
art. - Sistema della mobilità
art. - Sistema della produzione
art. - Sistema dell'abitare
art. - Sistema del verde e delle dotazioni territoriali
Capo ii - Disciplina degli ambiti
art. - Disposizione generali
art. - Ambiti
titolo II -IL DISEGNO DEL PIANO STRUTTURALE: i luoghi del piano
Capo i - Tracce di città futura
art. -
art. -
art. -
art. -
Capo ii - La qualità diffusa
art. - Disposizioni generali
art. - La rete del verde
art. - La rete idraulica
art. - La rete dei servizi
art. - La rete della mobilità
titolo III - ATTUAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE: diritti e procedure
capo i - Modalità di attuazione del piano
art. - Disposizioni generali
art. - Territorio urbanizzato
art. - Territorio urbanizzabile
art. - Territorio rurale
capo ii - I vincoli del piano
art. - Disposizioni generali
art. - Vincoli di tutela idraulica e idrogeologica
art. - Vincoli di tutela storico-architettonica culturale e testimoniale
art. - Vincoli di tutela naturalistica, ambientale e paesaggistica
art. - Fasce di tutela delle infrastrutture
|
|
|
Una più dettagliata descrizione dei livelli tematici del PSC può diventare lo spunto
per ulteriori riflessioni:
1° livello tematico del PSC:
la definizione dei CONTENUTI DEL PIANO STRUTTURALE
La "disciplina dei contenuti" riporta, nel gruppo di norme e di elaborati grafici che la
costituiscono, le scelte di carattere generale del PSC.
All'interno di questa disciplina il PSC classifica il territorio in SISTEMI (fisici e di funzionamento)
e AMBITI specifici.
I SISTEMI fissano le prestazioni di carattere generale che le diverse situazioni territoriali
riconosciute devono garantire. All'interno del PSC sono definiti:
- il SISTEMA DELL'AMBIENTE E E DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI - comprende
gli ambiti e gli elementi riconducibili alla definizione di un corretto funzionamento
ambientale della città e del territorio e delle necessarie dotazioni di attrezzature
e spazi collettivi. Gli obiettivi del sistema del verde e delle dotazioni territoriali sono
a loro volta articolati nei seguenti subsistemi: Connessioni geografiche strutturali,
Aree agricole del forese, Aree agricole di cintura, Aree di mitigazione e compensazione
ambientale, Città verde.
- il SISTEMA DELL'ABITARE - interpreta la città contemporanea come "mixitè"
tra le funzioni residenziali, i servizi pubblici e privati e il piccolo commercio. In
funzione delle differenze riconosciute, il sistema dell'abitare si articola a sua volta
nei seguenti subsistemi: Centro antico, Insediamenti contemporanei, Nuove centralità,
Nuclei del forese.
- il SISTEMA DELLA PRODUZIONE - rappresenta l'insieme dei luoghi dove
si svolgono le attività economiche ed è suddiviso nei seguenti subsistemi: Piccola
e media impresa, Condominio della chimica, Città dell'auto, Distretto della frutta e
dell'agroindustria, Grandi servizi tecnici.
- il SISTEMA DELLA MOBILITA' - è costituito dai principali elementi infrastrutturali
legati alla circolazione delle persone e delle merci ed è suddiviso nei seguenti
subsistemi: Automobile, Ferrovia e mobilità ciclabile, Intermodalità, Infrastrutture
fluviali
|
|
All'interno delle Norme tecniche del PSC una specifica parte è dedicata alla regolamentazione
della disciplina dei sistemi.
|
| |
Capo i - Disciplina dei sistemi
art. - Disposizioni generali
- Il PSC articola, ed indica nella tavola 2.n, il territorio comunale nei quattro
sistemi:
- della mobilità
- dell'abitare
- della produzione
- dell'ambiente e delle dotazioni territoriali.
- Tale articolazione è finalizzata a riconoscere la pluralità e l'eterogeneità
degli spazi e dei loro usi, caratteri costitutivi della città e del territorio
contemporaneo.
I sistemi precisano i ruoli che gli spazi devono svolgere, le prestazioni
che devono garantire, i materiali con i quali devono essere costruiti.
- indirizzo Gli interventi nei sottosistemi di cui al presente titolo
sono disciplinati dal RUE e/o dai POC secondo quanto indicato nelle
tavole 1.n, e secondo gli indirizzi indicati nelle presenti norme e nelle
tavole 4.n.
|
|
|
| Livello tematico 1. I CONTENUTI DEL PIANO
"I SISTEMI"
|
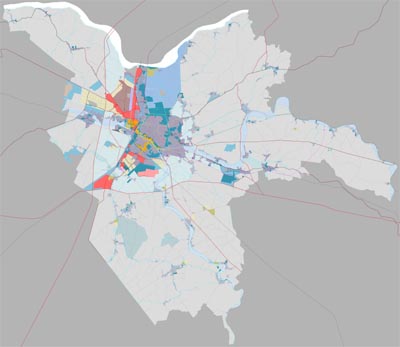 |
|
|
Una ulteriore classificazione del territorio - quella in AMBITI - stabilisce gli specifici obiettivi di dimensionamento
e di dotazione di servizi per le diverse parti del territorio riconosciute come "autonome"
dal punto di vista del funzionamento urbano. (esempi: via Bologna, Porotto-Cassana,
ecc).
In particolare, per ogni ambito il PSC stabilisce la massima capacità insediativa sostenibile in
funzione del grado di infrastrutturazione e degli obiettivi ambientali previsti dal piano. Per queste
parti del territorio gli strumenti di pianificazione operativa (regolamento urbanistico edilizio
e piani operativi) dovranno tradurre in quantità edificabile ed in aree per servizi le previsioni di
sviluppo che il piano strutturale definisce in termini di abitanti. L'ambito diventa quindi l'unità territoriale
rispetto alla quale prevedere lo sviluppo (in termini di dimensionamento del piano) ma
anche verificare gli esiti dal punto di vista ambientale.
|
| |
Capo ii - Disciplina degli ambiti
art. - Disposizioni generali
1. Il PSC articola il territorio comunale in strutture insediative. Per ciascuna
di esse, al fine di esplicitare le indicazioni e i parametri da rispettare
nelle successive fasi di pianificazione (RUE e POC) e per le verifiche
della VALSAT, il PSC individua gli ambiti ai sensi della legge regionale e ne
definisce la capacità insediativa, e le infrastrutture e i servizi necessari.
2. Al fine di rappresentare e mettere a confronto le questioni generali con
le scelte specifiche degli strumenti di pianificazione operativi, il PSC riporta
per ogni ambito:
2.1 DESCRIZIONE:
- descrizione della localizzazione rispetto alla città;
- appartenenza al sistema o al subsistema al fine della definizione degli
obiettivi generali;
2.2 FATTORI DI CRITICITA' PRESENTI:
- in relazione all'aria;
- in relazione all'acqua;
- in relazione al suolo;
- in relazione al sottosuolo;
2.3 DIMENSIONAMENTO:
- stato attuale (abitanti, servizi e infrastrutturazione)
- previsioni di progetto (abitanti, servizi e infrastrutturazione).
|
|
|
2° livello tematico del PSC:
il DISEGNO DEI LUOGHI del piano
L'esigenza di governare la "qualità diffusa" considerando fin dalla fase di impostazione
generale gli esiti fisici delle scelte ci ha spinto a "disegnare" il piano, cioè a dare
forma allo sviluppo e alle trasformazioni previste.
Nella tavola dei "LUOGHI DEL PIANO", sono definiti i materiali urbani (Spazi aperti, Spazi
edificati, Aree verdi, Aree boscate, Filari, Piste ciclabili, Assi di riqualificazione, Varchi visivi,
ecc.) utilizzati per disegnare le aree di trasformazione e di nuovo insediamento.
Le indicazioni riportate consentono di differenziare con sufficiente grado di precisione
le aree edificate da quelle vuote, le aree boscate dalle vasche di compensazione
idraulica, i percorsi e gli assi urbani da riqualificare e i varchi da garantire nei tessuti
edilizi, e costituiscono una sorta di simulazione degli esiti delle politiche di piano,
oltre che uno strumento indispensabile per la redazione degli strumenti di pianificazione operativa (regolamento urbanistico edilizio e piani operativi).
Vedremo in seguito come la individuazione delle parti edificate e di quelle dove realizzare
i servizi, consente di gestire efficacemente le politiche di distribuzione della
capacità edificatoria contenute nel modello perequativo proposto.
|
Livello tematico 2. IL DISEGNO DEL PIANO. "I LUOGHI DEL PIANO"
Nella tavola sono evidenziati i luoghi dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi
(rispettivamente viola scuro e chiaro), delle aree di riqualificazione (viola più scuro), dei
servizi (azzurro), delle aree di mitigazione e compensazione (celeste) e i principali elementi
di connessione urbana che gli strumenti operativi devono garantire.
|
 |
|
3° livello tematico del PSC:
la definizione delle modalità di GESTIONE DEL PIANO
Questo livello tematico del PSC contiene e mette in evidenza gli aspetti di gestione e
attuazione del piano. Le norme e gli elaborati grafici ad esso associati si confrontano
con la definizione delle procedure attuative e delle impostazioni dei diritti sui suoli
che competono al livello strutturale della pianificazione.
Un primo aspetto contenuto nella disciplina di "ATTUAZIONE DEL PSC stabilisce una
classificazione del territorio in funzione delle successive discipline di attuazione:
quella del regolamento urbanistico edilizio (per le parti consolidate) e quella dei piani
operativi comunali (per le parti di trasformazione). All'interno di questo elaborato
sono individuati, ai sensi della legge regionale: il territorio urbanizzato, il territorio
urbanizzabile e il territorio rurale. L'"isolamento" della disciplina dell'attuazione
dalle altre finalità di carattere generale consente di definire gli obiettivi che il PSC
si pone in merito alla "trasformabilità" del territorio, cioè delle parti che saranno
oggetto delle più importanti modificazioni nel prossimo futuro.
|
Livello tematico 3. LA
GESTIONE DEL PIANO
"ATTUAZIONE DEL PSC"
Gli aspetti gestionali
del piano sono tradotti
nell'individuazione
delle parti di territorio
Urbanizzato (in grigio),
Urbanizzabile (in rosso e
rosa) e Rurale (in bianco).
Questa classificazione
rappresenta anche
un rinvio agli specifici
strumenti operativi (RUE e
POC).
|
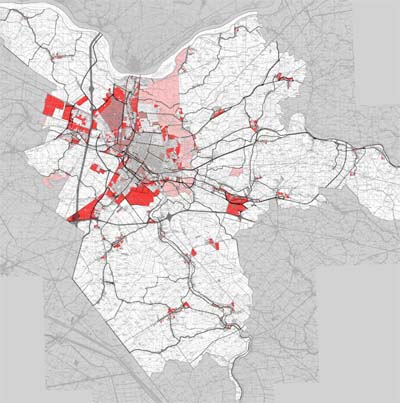 |
|
| |
capo i - Modalità per l'attuazione degli interventi
art. - Disposizioni generali
- Ai fini della sua attuazione e con particolare riguardo alla definizione
delle aree soggette a RUE e a POC, il PSC, ai sensi dell'art.28 della LR
20/2000, classifica il territorio in:
- territorio urbanizzato;
- territorio urbanizzabile;
- territorio rurale.
- Il PSC individua inoltre i corridoi per la realizzazione delle principali infrastrutture
di progetto.
- La disciplina per le aree così definite è indicata nei successivi articoli
di questo capo.
art. - Territorio urbanizzato
- Il Psc individua ed indica nella tavola "ATTUAZIONE DEL PSC", il territorio
urbanizzato e lo articola in: aree urbane consolidate, aree urbane da
riqualificare.
- Prescrizione All'interno delle aree urbane consolidate, gli interventi
si attuano per mezzo di intervento edilizio diretto in conformità
con quanto previsto negli elaborati del RUE.
- Prescrizione All'interno delle aree urbane da riqualificare gli
interventi si attuano successivamente all'approvazione del POC, fatto
salvo quanto indicato nella disciplina dei singoli ambiti.
art. - Territorio urbanizzabile
- Il PSC individua ed indica nell'elaborato "ATTUAZIONE DEL PSC", il territorio
urbanizzabile secondo le aree di nuovo insediamento.
- Prescrizione All'interno delle aree di nuovo insediamento gli
interventi si attuano successivamente all'approvazione del POC specificamente
riferito all'area.
art. - Territorio rurale
- Il Psc individua ed indica nell'elaborato "ATTUAZIONE DEL PSC", il territorio
rurale articolato in: aree rurali e aree di riqualificazione ambientale.
- Prescrizione All'interno delle aree rurali gli interventi si attuano
attraverso intervento edilizio diretto in conformità con quanto previsto
negli elaborati del RUE.
- Prescrizione All'interno delle aree di riqualificazione ambientale
la realizzazione dei diritti edificatori legati alla perequazione
urbanistica di cui al successivi artt. .... si attuano successivamente
all'approvazione del POC. Tutti gli altri interventi sono regolamentati dal
RUE.
art. - Infrastrutture
- Il Psc individua ed indica nell'elaborato "ATTUAZIONE DEL PSC", le infrastrutture
di progetto e le infrastrutture da riqualificare.
- Prescrizione Gli interventi relativi alle infrastrutture di progetto
e alle infrastrutture da riqualificare si attuano successivamente
all'approvazione del POC.
- Prescrizione Gli interventi relativi alle aree limitrofe alle infrastrutture
di progetto e alle infrastrutture da riqualificare sono disciplinati
in funzione delle indicazioni di cui ai precedenti articoli di questo
stesso titolo.
|
|
|
Un secondo aspetto relativo a questo livello tematico del PSC è quello della definizione
delle limitazioni all'utilizzo delle risorse del territorio. Si tratta di individuare e
definire i limiti alle trasformazioni che competono direttamente al piano strutturale.
Si tratta di limitazioni derivate da leggi e piani di livello sovracomunale, dell'insieme
dei vincoli di tipo ambientale, storico, paesaggistico, ma anche infrastrutturale,
che possono essere indicate come limitazioni all'attività edilizia. Si tratta dei vincoli
considerati "connaturati" ai beni immobiliari (aree ed edifici) e pertanto non soggetti
ad indennizzo alcuno.
Il PSC nella disciplina dei “VINCOLI DEL PIANO” indica tali limiti e li riporta in alcune
mappe che rappresentano la base per la definizione della CARTA UNICA DEL TERRITORIO
e che punta a garantire una più efficiente gestione ed una più “visibile” definizione
delle condizioni a cui sono soggette le trasformazioni del territorio.
|
| |
capo iii - I vincoli del piano
art. - Disposizioni generali
1. Il PSC riporta e specifica negli specifici elaborati individuati come" CARTA DEI VINCOLI
E DELLE TUTELE", le aree soggette a vincoli derivati dalla necessità di tutela del
suolo e dell'ambiente, dalle caratteristiche morfologiche e geologiche che rendono
incompatibili i processi di trasformazione, dalla presenza di fattori di rischio ambientale
e dalla vulnerabilità delle risorse naturali e quelli derivati dai piani territoriali
sovraordinati.
art. - Vincoli di tutela idraulica e idrogeologica
1. Il PSC individua e indica nella tavola "TUTELE IDRAULICHE E IDROGEOLOGICHE" le
aree soggette a vincolo con particolare rifeirmento a:
a. Vincoli di tutela idraulica:
1.1 alvei dei corsi d'acqua (art. 18 PTCP)
1.2 aree a rischio di allagamento grave da fiumi e da canali
1.3 fascia A piano di bacino Po (art. 18 PTCP)
1.4 fascia B piano di bacino Po (art. 17 PTCP)
1.5 fascia C piano di bacino Po (art. 17 PTCP)
b. Vincoli di tutela idrogeologica:
1.6 paleoalvei (art. 24 PTCP)
1.7 aree a ridotta soggiacenza della falda freatica
1.8 corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 26 PTCP)
art. - Vincoli di tutela storico-architettonica culturale e testimoniale
1. Il PSC individua e indica nella tavola "TUTELE STORICHE E TESTIMONIALI" le aree
soggette a vincolo con particolare riferimento a:
a. Tutela del sito Unesco
1.1 sito Unesco
b. Vincoli di tutela storico-architettonica:
1.2 manufatti monumentali (D.Lgs. 42/2004)
1.3 viabilità storica (art. 20 PTCP)
1.4 ville con parco(art. 24 PTCP)
1.5 parchi storici(art. 24 PTCP)
1.6 manufatti idraulici
c. Vincoli di tutela archeologica:
1.7 complessi archeologici (art. 21/a PTCP)
1.8 aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 21/b PTCP)
1.9 aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 21/c PTCP)
1.10 potenziale archeologico Centro Storico classe 01
1.11 potenziale archeologico Centro Storico classe 02
1.12 potenziale archeologico Centro Storico classe 03
1.13 potenziale archeologico Centro Storico classe 04
art. - Vincoli di tutela naturalistica, ambientale e paesaggistica
1. Il PSC individua e indica nella tavola "TUTELE NATURALISTICHE" le aree soggette a
vincolo con particolare riferimento a:
a. Vincoli di tutela naturalistica e ambientale
1.1 SIC
1.2 ZPS
1.3 aree boscate
1.4 zone umide e specchi d'acqua
1.5 aree di riequilibrio ecologico
b. Vincoli di tutela paesaggistica
1.6 vincoli paesistici art. 142 (D.Lgs. 42)
1.7 vincoli paesistici art. 157 (D.Lgs. 42)
1.8 strade panoramiche (art. 24 PTCP)
1.9 alberi monumentali
art. - Fasce di tutela delle infrastrutture
1. Il PSC individua e indica nella tavola "TUTELE DELLE INFRASTRUTTURE" le aree
soggette a vincolo con particolare riferimento a:
a. Vincoli di tutela delle infrastrutture
1.1 strade
1.2 aeroporto
1.3 pipeline
1.4 gasdotti
1.5 eletrodotti (alta ensione)
1.6 depuratori
1.7 cimiteri
1.8 cabine alta tensione
1.9 antenne TV
b. Aree a rischio di incidente rilevante
1.10 aree a rischio di incidente rilevante
|
|
|
|
b. Procedure. Il doppio livello della pianificazione
|
Come si è già avuto modo di precisare, la nuova legge urbanistica regionale
prevede l'articolazione degli strumenti di pianificazione in due livelli: quello strutturale
e quello operativo. Questo può essere considerato uno degli elementi più innovativi
della riforma, e anche uno degli aspetti che maggiormente differenzia il
nuovo piano da quello tradizionale. Gli altri riguardano: l'inserimento degli aspetti
ambientali nella programmazione e nella gestione del territorio, un coinvolgimento
più diretto della società locale nella costruzione e gestione del piano ed, infine, la
definizione di strumenti operativi più efficaci poiché legati ad un più maturo rapporto
tra pubblico/ privato.
I due livelli di pianificazione operativa riconosciuti dalla legge, che assumono la forma
del regolamento urbanistico edilizio e del piano operativo, necessitano di alcune
precisazioni.
Nel caso di Ferrara la fase operativa (sia del regolamento sia del piano) è stata considerata
come un'ulteriore importante fase della pianificazione, un livello al quale è
affidato l'ambizioso compito di avvicinare, quanto più possibile, la programmazione
degli interventi alla loro attuazione.
Al Prg tradizionale che assumeva l’onere della gestione complessiva del territorio,
si sostituisce uno strumento articolato in più fasi temporali; così, rispetto ad un
unico momento di discussione e di decisione degli obiettivi generali e delle scelte
operative caratterizzante il Prg tradizionale -con i limiti derivati dallo “scollamento”
tra i tempi di costruzione del Prg e quelli della sua attuazione- il nuovo piano cerca di
“sfruttare” le opportunità derivate dalla possibilità di articolare le decisioni in livelli,
tempi e strumenti differenti.
In particolare, nel Nuovo piano di Ferrara la scansione temporale della pianificazione
consente di operare in maniera differente rispetto al passato relativamente alla
questione dei diritti edificatori dei suoli, provando ad incidere in maniera profonda
sul meccanismo della rendita fondiaria.
Il principio previsto dalla riforma urbanistica regionale, e fatto proprio dal Nuovo piano
di Ferrara, prevede di fissare i diritti edificatori - cioè le potenzialità edificatorie
che il piano affida a ciascuna parte del territorio - nelle fasi operative del regolamento
urbanistico edilizio (per le parti del territorio consolidato), e dei piani operativi
(per le parti oggetto di trasformazione urbanistica), lasciando al momento strutturale
la definizione delle regole generali (perequate) su cui fondare tali diritti.
In questo modo si ottiene l’indubbio vantaggio di avvicinare la precisazione di alcune
regole del mercato (quelle del valore dei suoli) ad una fase in cui le previsioni urbanistiche
sono più vicine al momento della loro realizzazione, rendendo possibile
un diverso e più fertile confronto tra i soggetti e riducendo la separazione temporale
considerata una delle principali difficoltà nella implementazione dei piani urbanistici.
Si vedrà in seguito come questo spostamento interagisce con lo strumento della
perequazione urbanistica, diventando uno dei presupposti per la sua efficacia.
La regia della gestione dei diritti edificatori è quindi affidata al livello strutturale del
Nuovo piano, il quale contiene, oltre alla definizione delle regole e delle modalità
per la formazione degli strumenti operativi (regolamento urbanistico edilizio e piani
operativi), anche l’insieme delle relazioni formali tra i diversi strumenti della filiera.
I Piani Operativi. Nel Nuovo piano urbanistico di Ferrara, i Piani Operativi rappresentano
gli strumenti più innovativi. Essi trovano un primo momento di definizione
nel PSC di Ferrara non solo in relazione ai contenuti e al ruolo svolto, ma anche
rispetto al loro percorso di formazione. Lo spostamento della definizione dei diritti
edificatori in tale fase, infatti, rende necessaria la previsione di un'attività di partecipazione,
che anticipi le scelte specifiche del Piano Operativo. Per ottenere ciò il PSC
di Ferrara prevede una fase preliminare di partecipazione, anticipata a sua volta
dalla pubblicazione di un documento in cui esporre gli obiettivi generali previsti per
il piano operativo. Questa fase programmatica non è prevista, ma neppure esclusa
dalla legge regionale, e risulta un'utile e quasi indispensabile fase nel percorso di
costruzione del Piano Operativo.
Più precisamente, il percorso di formazione del Piano Operativo prevede:
- la predisposizione di un DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL POC che contenga,
tra l'altro:
- la verifica del grado di attuazione del piano;
- il dimensionamento di massima della capacità insediativa del piano operativo;
- la definizione dei livelli minimi e massimi dei diritti edificatori per le varie classi
omogenee dei suoli;
- la definizione degli obiettivi di interesse pubblico previsti per il periodo di validità
del piano operativo.
- la definizione dei principali investimenti pubblici previsti nel periodo interessato dal POC.
- la previsione di un CONCORSO PUBBLICO per la raccolta delle proposte di
inserimento nel piano operativo a partire dalle previsioni del PSC e dalle indicazioni
del documento di cui al punto "a".
- la predisposizione del piano operativo vero e proprio considerando anche
gli esiti del concorso.
All'interno delle Norme Tecniche del PSC, un articolo, in particolare, governa tale processo.
|
| |
art. - Indirizzi per la formazione dei Piani Operativi Comunali
- I Piani Operativi Comunali (POC) rappresentano gli strumenti
operativi delle scelte di pianificazione generale del PSC per quel che riguarda
il "TERRITORIO URBANIZZABILE", le "Aree da riqualificare" del "TERRITORIO
URBANIZZATO" e le "Aree di riqualificazione ambientale" del "TERRITORIO
RURALE", così come definiti al successivo "Titolo III" delle presenti
Norme Tecniche.
- CONTENUTI DEI POC. I POC dovranno essere redatti ai sensi
della LR/2000. In particolare, per attuare le scelte generali del PSC, essi
dovranno:
- indicare gli interventi e le trasformazioni sul territorio, previsti dal PSC
e da realizzare nell'arco temporale di cinque anni;
- definire i diritti edificatori delle aree interessate dalla trasformazioni, in
conformità con le Classi omogenee dei Suoli individuate dal PSC e secondo
i criteri definiti nel RUE;
- coordinare e indirizzare il programma delle opere pubbliche.
- FORMAZIONE DEI POC. Al fine di realizzare gli obiettivi del PSC attraverso
la condivisione e la partecipazione alla fase attuativa, il percorso
di formazione dei POC comprenda le fasi seguenti:
3.1. l'adozione preliminare, da parte del Consiglio Comunale, di un DOCUMENTO
DEGLI OBIETTIVI DEL POC in cui sono contenuti in particolare:
- l'aggiornamento del QUADRO CONOSCITIVO sullo stato di attuazione del
PSC in tema di opere pubbliche, aree per servizi, nuovi insediamenti e
aree di riqualificazione;
- l'aggiornamento del QUADRO CONOSCITIVO sullo stato dell'ambiente;
- gli indirizzi generali della programmazione delle opere pubbliche per il
periodo interessato dal POC;
- le valutazioni sugli andamenti della popolazione e dei principali settori
economici per il periodo interessato dal POC;
- la definizione delle linee di intervento rispetto alle linee d'azione del
PSC (L'acqua come risorsa, Abitare a Ferrara, La città verde);
- la definizione dei diritti edificatori minimi e massimi previsti per le diverse
Classi Omogenee dei Suoli;
3.2. la definizione di un CONCORSO PUBBLICO, ai sensi del comma 10
dell'art.30 della LR20/2000, al fine di selezionare le richieste di inserimento
nel POC in corso di redazione delle aree interessate alle
trasformazioni;
3.3. l'adozione del POC ai sensi della LR20/2000.
|
|
|
L'altro strumento operativo previsto dalla legge regionale è il Regolamento
Urbanistico Edilizio. Esso disciplina le parti consolidate del territorio che il piano
strutturale considera "complete", sia dal punto di vista della dotazione dei servizi
sia da quello degli insediamenti. Va da se che la disciplina per queste aree ha come
obiettivo la "manutenzione ordinaria" del territorio, cioè degli interventi che non
comportano trasformazioni importanti.
Per la parte "urbanistica", i contenuti del regolamento non si discostano molto da
quelli che il Prg tradizionale prevedeva per gli interventi all'interno delle parti urbane
esistenti, e cioè la definizione di densità, altezze, distanze, modalità attuative, ecc.
Nello specifico caso del Nuovo piano di Ferrara, si è pensato di semplificare, rendendo
esplicito e intelligibile quest'insieme di regole. La proposta prevede di organizzare
le norme per "strati tematici", un insieme di mappe riferite all'altezza, alla densità,
ecc. che, se lette separatamente, rappresentano il disegno complessivo dal quale
deriva la regola specifica, (ad esempio, rispetto all'altezza degli edifici mostrano il
disegno complessivo dell'omogeneità/eccezionalità delle parti più "alte" della città);
se sovrapposte mostrano l'insieme delle norme riferite ad una singola porzione
(lotto) di territorio.
La struttura proposta rende leggibile, nella modalità più articolata del "certificato
d'uso", quello che fino ad ora era definito "certificato di destinazione urbanistica".
Naturalmente, tale forma è possibile solo prevedendo l'utilizzo di strumenti
informatici adeguati (Sit).
Anche in questo caso, il PSC, disciplina la forma del regolamento in uno specifico
articolo delle sue Norme Tecniche.
|
| |
art. - Indirizzi per la formazione del Regolamento Urbanistico Edilizio
- Il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) rappresenta lo strumento
che disciplina l'attività di trasformazione, fisica e funzionale, e di
conservazione delle opere edilizie.
- CONTENUTI DEL RUE. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
individuati al comma precedente il RUE si articola in una parte di regole
edilizie e una parte di regole urbanistiche.
In particolare il RUE deve prevedere :
parte 1.REGOLE EDILIZIE
a. la definizione dei termini e dei parametri da utilizzare nella
progettazione e nella valutazione degli interventi edilizi;
b. la definizione delle regole generali per le procedure degli
interventi;
c. la definizione delle regole generali per la qualità degli interventi
articolate in:
c.1.regole per la progettazione degli edifici (sia rispetto
alla qualità formale e compositiva che alla qualità tecnica e con particolare
riguardo alle questioni del risparmio energetico, dell'uso di fonti
energetiche rinnovabili e della corretta gestione del ciclo dell'acqua);
c.2. regole per la progettazione delle infrastrutture
(strade, corsi d'acqua, piste ciclabili);
c.3.regole per la progettazione degli spazi aperti (aree
verdi, aree boscate, vasche di laminazione, ecc.)
parte 2.REGOLE URBANISTICHE
d. le regole specifiche per i luoghi del territorio consolidato, per gli
interventi ammessi in assenza di POC negli ambiti ad intervento diretto,
nonchè per gli interventi ammessi in assenza di POC negli ambiti ad
intervento indiretto, definite come:
d.1. regole funzionali (destinazioni d'uso degli edifici e
degli spazi aperti, ecc.);
d.2. regole dimensionali (altezze, densità edilizie, ecc.)
d.3. regole ambientali (copertura e permeabilità dei
suoli, trattamenti, ecc.)
d.4. regole per la qualità (categorie di intervento, ecc.).
e. i criteri per la definizione dei diritti edificatori da attribuire alle
diverse Classi omogenee dei Suoli così come definite nel PSC.
- DISEGNO DEL RUE. Il RUE, sarà costituito da una serie di mappe
in scala adeguata e da un articolato normativo.
Le mappe del RUE dovranno riportare le regole che traducono gli obiettivi
del PSC articolandole per STRATI NORMATIVI secondo l'articolazione del
precedente punto 2.
|
|
|
|
c. Strumenti. La perequazione
|
Un ulteriore elemento d'innovazione previsto dalla legge 20/2000 riguarda l'istituto
della perequazione urbanistica, questione che da molto tempo cerca riferimento
all'interno delle disposizioni legislative e che solamente con le recenti riforme
urbanistiche regionali ha trovato spazio come strumento di governo della rendita
fondiaria all'interno dei piani urbanistici.
Nel PSC di Ferrara il modello perequativo assume caratteri del tutto specifici. Rispetto
ad uno schema ormai "tradizionale", in cui la perequazione riguarda tutte le aree per le
quali il piano prevede la trasformazione sia per realizzare nuovi insediamenti abitativi
o produttivi, sia per attuare le previsioni di opere pubbliche (parchi, attrezzature, ecc.),
nel senso che tutte queste aree concorrendo alla realizzazione della città devono
partecipare alla divisione dei benefici e dei costi attraverso il disegno di "comparti"
allargati, a Ferrara il Nuovo Piano introduce almeno due ulteriori elementi.
- Oltre alle aree per servizi, nella perequazione sono inserite, anche quelle
per la compensazione, sulla base dei criteri dello "standard ambientale", per gli ambiti
destinati alle "dotazioni ecologiche e ambientali" (art. A-25 della LR"20/2000). Si
tratta di alcune aree agricole periurbane e delle aree di compensazione destinate
alla forestazione e alle zone di espansione idraulica.
- La perequazione del Nuovo Piano di Ferrara utilizza i due livelli della
pianificazione, quello strutturale e quello operativo, per garantire condizioni più
efficaci alla sua realizzazione. Avvicinando alla fase realizzativa la scelta delle aree,
oltre che la definizione dei comparti e dei diritti edificatori.
Il modello proposto si traduce, nel PSC in una serie di apetti strutturali ed in una
serie di questioni operative. In sintesi si prevede:
|
|
a. nel livello strutturale:
|
- l'individuazione delle aree oggetto della perequazione e compensazione quali:
- le aree di nuovo insediamento (aree di trasformazione, di nuova edificazione);
- le aree destinate ai servizi;
- le aree della compensazione ambientale;
- le aree agricole di cintura.
- la classificazione di queste aree secondo CLASSI OMOGENEE DEI SUOLI in
funzione del loro stato di fatto e di diritto;
- l'individuazione delle aree su cui realizzare i nuovi insediamenti e i servizi;
- la definizione delle capacità insediative massime insediabili su tali aree;
- la definizione delle regole per gli strumenti operativi che dovranno applicare
la perequazione.
|
|
b.nel livello operativo:
|
- la definizione dei diritti edificatori con riferimento alle diverse classi dei suoli;
- la definizione dei comparti edificatori in funzione degli obiettivi generali e
specifici e degli interessi attivati attraverso le fasi di partecipazione.
Tutto ciò è tradotto nel PSC, in una serie di articoli normativi che prevedono:
|
| |
capo iii - La perequazione del piano
art. - Disposizioni generali
- Il PSC individua la perequazione e la compensazione per le aree
interessate dalle ipotesi di sviluppo del territorio come uno degli strumenti
per la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle trasformazioni
edilizie previste.
- A tale fine il PSC indica, per le parti di territorio interessate, le
Classi omogenee dei suoli in funzione dello stato di fatto e del ruolo che
assumono nel contesto generale del piano.
- La classificazione delle aree e le regole perequative indicate nei
successivi articoli rappresentano un elemento strutturale e pertanto non
negoziabile.
- La definizione dei diritti edificatori, dei comparti di intervento
e delle relative volumetrie, viene rinviata, in quanto conformazione della
proprietà, ai successivi POC.
|
|
|
|
Classi omogenee dei suoli
ed elementi incongrui
| 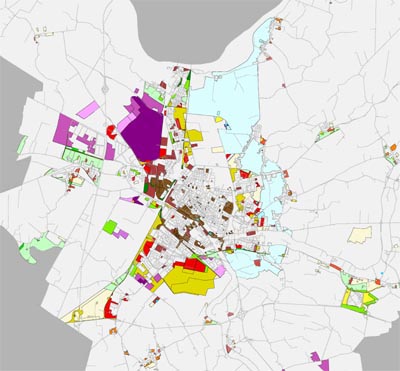 |
|
| |
art. - Le aree della perequazione e compensazione
- Il PSC individua sul territorio comunale le aree delle principali
trasformazioni alle quali applicare le regole perequative.
- Le aree di cui al comma 1 sono indicate nella tavola del
PSC "ATTUAZIONE DEL PSC. PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE" e
comprendono:
2.1. Aree per i nuovi insediamenti;
2.2. Aree di riqualificazione ambientale;
2.3. Aree urbane da riqualificare.
art. - Le classi dei suoli
- Prescrizione Il PSC, in funzione dello stato di fatto e al fine di
realizzare gli obiettivi del piano, riconosce alle parti di territorio interessate
dalla perequazione l'appartenenza alle seguenti Classi dei suoli:
1.1 Classe 1. Aree edificate:
1.1 Centrali
1.2 Del centro urbano
1.3 Del forese
1.2. Classe 2. Aree edificabili:
2.1 Centrali
2.2 Del centro urbano
2.3 Del forese
1.3. Classe 3. Aree per servizi:
3.1 Centrali
3.2 Del centro urbano
3.3 Del forese
1.4. Classe 4: Aree agricole.
- Prescrizione Il PSC stabilisce che le classi definite al comma 1,
si suddividino a loro volta in funzione degli obiettivi generali assegnati dal
piano. Per ognuna delle Classi dei suoli è prevista la ulteriore suddivisione:
2.1. Sottoclasse A. Aree oggetto di nuova urbanizzazione residenziale,
commerciale e direzionale, e per la realizzazione di opere pubbliche;
2.2. Sottoclasse B. Aree oggetto di nuova urbanizzazione produttiva, e
per la realizzazione di opere pubbliche;
2.3. Sottoclasse C. Aree per la compensazione ambientale;
2.4. Sottoclasse D. Aree per la riqualificazione ambientale.
- Il PSC indica nella tavola "ATTUAZIONE DEL PSC. PEREQUAZIONE
E COMPENSAZIONE" le Classi dei suoli definite nei commi precedenti.
art. - Aree ed elementi incongrui
- Il PSC individua sul territorio comunale ed indica nella tavola del
PSC "ATTUAZIONE DEL PSC. PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE", le aree e i
manufatti incongrui ai contesti urbani in cui si collocano.
- Prescrizione Per tali aree e manufatti, al fine della loro
dismissione, i POC possono stabilire un'adeguata capacità edificatoria
da realizzare all'interno delle aree previste come edificabili dal PSC.
Le condizioni della demolizione e del ripristino dei luoghi interessati
dovranno essere garantite da apposita convenzione da stipularsi tra
l'Amministrazione comunale e i proprietari.
art. - Regole perequative
- Prescrizione Gli interventi sulle aree di perequazione e
compensazione dovranno far riferimento ai Comparti di Attuazione definiti
dai POC e soggetti a Piano Urbanistico Attuativo. All'interno dei Comparti di
Attuazione devono essere comprese le aree pubbliche, di compensazione
e le aree agricole di riqualificazione ambientale periurbane che il POC
associa alle aree per nuovi insediamenti.
- Prescrizione I diritti edificatori delle aree soggette a
perequazione saranno stabiliti di volta in volta da ogni POC prevedendo
diritti uguali per ognuna delle Classi dei suoli individuate dal PSC.
I POC dovranno determinare i diritti edificatori delle aree tenendo conto:
- delle proposte di inserimento nel POC derivate dal Concorso di
partecipazione;
- dello stato di attuazione del PSC sia per quel che riguarda i nuovi
insediamenti che le aree pubbliche previste;
- dell'andamento del mercato immobiliare così come ricavato dal
monitoraggio dell'Urban Center.
- Prescrizione All'interno di ogni area i POC potranno prevedere
una quota di Superficie lorda di pavimento, da realizzarsi come edilizia
residenziale pubblica. Tale quota se realizzata dal proponente, non sarà
computata nei diritti edificatori previsti per l'area.
Per l'edilizia residenziale pubblica realizzata direttamente dal proponente
dovrà essere stipulata una convenzione con l'Amministrazione comunale
nella quale stabilire il tipo di intervento, e le eventuali misure e durata
delle locazioni, ecc.
- La capacità insediativa che il PSC prevede per ogni area
edificabile è costituita dalla somma dei diritti edificatori previsti per
l'area edificabile più quella prevista per le aree della città verde, della
compensazione e della riqualificazione ambientale comprese all'interno
del comparto di intervento stabilito dal POC. Tale quantità può essere
ridotta della capacità insediativa per edilizia residenziale pubblica se
realizzata ai sensi del comma precedente.
|
|
|
L'importanza che assume la questione della perequazione urbanistica nel PSC di
Ferrara e le differenze, nei comportamenti e in alcune pratiche del mercato, che questa
propone, necessitano di alcune ulteriori riflessioni. E, d'altra parte, nei numerosi
incontri in cui è stata presentata la "forma" del PSC di Ferrara, il modello perequativo
ha sollevato interesse e necessità di approfondimento non tanto rispetto alla
necessità, oramai condivisa, di prevedere una modalità perequata di distribuzione
dei diritti edificatori, quanto piuttosto per lo spostamento della definizione di tali
diritti dalla fase decisionale principale del piano (quella del PSC) a quella operativa
(dei POC).
Un contributo alla descrizione del modello di perequazione del PSC di Ferrara, e
alla riflessione su alcuni aspetti legati alla definizione dei diritti edificatori in tempi
diversi, può venire dalla simulazione di casi specifici attraverso i quali approfondire
le tematiche "incrociate" dall'applicazione dello strumento perequativo. Si tratta la
di questioni relative al mercato immobiliare, alla residenza pubblica e soprattutto al
ruolo dell'amministrazione comunale nella gestione dello strumento perequativo.
SIMULAZIONE 1. Come il modello perequativo proposto può definire un diverso
rapporto tra gli operatori del mercato immobiliare e quale può essere il ruolo
dell'amministrazione comunale?
Una riflessione su questo tema può partire dal riconoscimento di situazioni a cui
ricondurre i possibili operatori del mercato. I casi da analizzare - inevitabilmente
semplificati - fanno riferimento a soggetti che, al momento della formazione del piano
operativo comunale possono risultare:
- proprietari di aree con diritti edificatori e non interessati a diventare
soggetti attuatori;
- proprietari di aree con diritti edificatori interessati a diventare soggetti attuatori;
- soggetti attuatori non proprietari di aree.
Non sembra irrilevante cominciare a differenziare il ruolo dei soggetti poiché questi
assumono interessi diversi proprio in funzione della rendita fondiaria.
Per i soggetti "c" risulta sostanzialmente indifferente una politica di distribuzione
dei diritti edificatori su più aree, anche non contigue, a patto che sia garantita la
possibilità di acquisire i diritti e le aree su cui realizzarli. Compito del piano è, quindi,
quello di favorire tale necessità, dopodiché gli interessi di questi operatori - cioè la
realizzazione dell'intervento previsto- coincidono con quelli dell'amministrazione.
I soggetti "b" partono da una condizione di privilegio rispetto a quelli del punto
precedente in quanto già in possesso di parte dei diritti edificatori e soprattutto
dell'area su cui realizzarli. Tali soggetti possono perciò essere vantaggiosamente
ricondotti ai soggetti precedenti.
Ai soggetti "a", invece, può essere associato l'interesse per la valorizzazione delle
aree in loro possesso al fine di ottimizzare la vendita.
Questa casistica non intende interpretare l'insieme dei comportamenti dei soggetti
e del mercato, purtuttavia mette in luce uno dei ruoli che l'amministrazione pubblica
può assumere rispetto al mercato e alla rendita fondiaria. Si può, infatti, ipotizzare
che l'amministrazione gestisca una quota dei diritti edificatori (eventualmente
come quota premio) al fine di: "aiutare" la realizzazione degli interventi, calmierare
le contrattazioni tra i diversi soggetti individuati e "coprire" eventuali assenze di
diritti edificatori dovuti alla non partecipazione di alcuni soggetti. Ciò può portare al
controllo di una quota di riserva dei diritti edificatori - un "paniere" - da utilizzare durante
le fasi negoziali della costruzione dei piani operativi. Vedremo in seguito come
questa quota di "riserva" renda possibili ulteriori forme di gestione delle questioni
abitative: ad esempio quella della residenza pubblica.
SIMULAZIONE 2. La domanda successiva riguarda la definizione dei
meccanismi con i quali l'amministrazione può entrare in possesso dei diritti
edificatori da inserire nel "paniere" e le modalità di utilizzo di questi diritti.
Anche in questo caso, e con le dovute semplificazioni, vale la pena di valutare alcuni casi.
- Caso in cui nel Piano Operativo si voglia realizzare un'opera pubblica
consistente. Ad esempio il Parco sud della città. In questo caso l'obiettivo della
realizzazione del Parco sud si traduce nell'interesse ad acquisire le aree coinvolte
dal progetto. Tale obiettivo deve essere preventivamente dichiarato nel DOCUMENTO
DEGLI OBIETTIVI che accompagna la fase di formazione del Piano Operativo Comunale.
In questo documento esso diviene elemento prioritario ai fini della scelta delle aree
da inserire ed obiettivo delle opere pubbliche da realizzare.
Il CONCORSO PUBBLICO successivo può dare, per le aree coinvolte, i seguenti esiti:
- nessun interesse a partecipare alla realizzazione;
- interesse esteso a tutta l'area coinvolta dal progetto del parco;
- interesse solo per una parte dell'area coinvolta dal progetto.
Vale la pena di esaminare la sola condizione "c" in quanto contiene anche le altre
due. In questo caso nel Piano Operativo Comunale viene inserito il progetto del Parco
Sud come obiettivo pubblico e quindi viene implicitamente dichiarato l'interesse
pubblico delle aree coinvolte. Diviene perciò possibile, nei casi in cui non vi sia partecipazione
alla realizzazione, acquisire attraverso l'esproprio le parti di area non
offerte. In questo caso, l'acquisizione delle aree, si accompagna all'acquisto dei
diritti edificatori perequati che possono quindi essere inseriti nel "paniere" dell'amministrazione
comunale.
- Caso in cui l'amministrazione comunale intende realizzare un'area di
nuovo insediamento e annesse opere pubbliche. Ad esempio nel caso dell'espansione
di Cona.
Anche in questo caso l'obiettivo e l'interesse pubblico vanno prestabiliti nel DOCUMENTO
DEGLI OBIETTIVI DEL POC. E, anche in questo caso l'esito del CONCORSO
PUBBLICO può dare risposte non soddisfacenti. Possono infatti darsi delle situazioni
problematiche riconducibili a:
a. indisponibilità delle aree per le opere pubbliche;
b. indisponibilità delle aree per il nuovo insediamento.
La situazione "a" è riconducibile al caso precedente e quindi al percorso: acquisizione
delle aree - trasferimento dei diritti.
La situazione "b", in funzione della dimensione, del ruolo e dell'interesse pubblico,
può portare a valutazioni diverse:
b1. quella di prendere atto dell'impossibilità di realizzare l'intervento previsto e
quindi di rinviarlo ai piani operativi successivi;
b2. quella di ridefinire il comparto secondo le sole aree disponibili mantenendo
la possibilità di sviluppare un progetto unitario (anche se ridimensionato);
b3. quella di stabilire l'utilità pubblica per la parte non disponibile - ad esempio
per edilizia pubblica - e quindi procedere con lo strumento dell'acquisizione.
Le tre situazioni non comprendono naturalmente quella auspicabile, in cui gli
interessi dei soggetti siano tali da consentire l'attuazione delle previsioni del piano.
La simulazione vuole però mettere in evidenza come anche nelle tre situazioni di
maggior problematicità, viene garantita la possibilità di governare il processo di
trasformazione delle aree.
- Caso in cui l'amministrazione intenda realizzare un intervento di
riqualificazione su aree di proprietà pubblica. Ad esempio area ex Mof.
Nel DOCUMENTO DEGLI OBIETTIVI, viene esplicitato l'interesse pubblico e viene
stabilita una adeguata capacità edificatoria in funzione della particolare CLASSE
OMOGENEA DEI SUOLI (quella delle aree già edificate). Nel successivo Piano
Operativo il progetto di valorizzazione dell'area viene tradotto nel disegno della
trasformazione ed eventualmente viene prevista una quota di diritti edificatori da
trasferire in altra area.
Nei casi esaminati, gli obiettivi di garanzia dell'interesse pubblico e di governo
delle trasformazioni previste, sono ottenuti principalmente dalla combinazione
degli effetti prodotti durante tutto il percorso di formazione del Piano Operativo.
Lo spostamento dei diritti edificatori e la capacità di negoziare che assume la fase
operativa assieme alla definizione delle scelte e delle aree nella fase strutturale,
sono le principali ragioni della efficacia del modello di pianificazione ipotizzato.
Da ciò deriva l'importanza di fissare il percorso di formazione degli strumenti
operativi fin dalla fase strutturale della pianificazione, e di stabilire, nello stesso PSC,
gli elementi (Disegno delle trasformazioni e Classi dei suoli) in grado di gestire tale
percorso. Ma ne deriva anche la necessità di un forte impegno dell'amministrazione
comunale nella gestione dei processi realizzativi della città. Un impegno che a partire
dal "disegno" preciso degli interventi strategici, comprenda anche la gestione della
sua realizzazione. Un impegno che, a partire dagli strumenti che propone il PSC,
coinvolga complessivamente la comunità di Ferrara nel governo del suo territorio.
|
|
6. La qualità diffusa. Alcune opportunità di costruire la città del
futuro.
|
Il PSC di Ferrara indaga la città esistente riconoscendone le opportunità, rintracciando
le opportunità e le potenzialità che consentono di immaginare e definire le forme
della città futura.
L'osservazione dei luoghi e dei processi di trasformazione della città, del rallentamento
dell'espansione urbana e della cospicua presenza di aree dismesse, suggerisce
di pensare ad una nuova articolazione degli spazi e delle funzioni urbane,
riconoscendo che la città non segue più una semplice e rigida gerarchia dei valori
decrescenti dal centro verso l'esterno. Propone inoltre di contenere l'espansione futura
della città, ipotizzando modelli di sviluppo basati sul riuso, la riqualificazione
e il completamento delle aree già parzialmente edificate piuttosto che sulla loro
espansione.
A partire da qui, il nuovo PSC di Ferrara si sforza di evidenziare gli elementi essenziali
e portanti della città, la sua struttura insediativa e ambientale, ma soprattutto
cerca di mettere a punto una strategia di sviluppo sostenibile, definendone le relative
procedure. Il PSC fa ciò senza pretendere di congelare la città in una forma definita,
ma cercando piuttosto di definirne l'ossatura portante attraverso uno schema
aperto che pone al centro dell'attenzione il tema delle connessioni: connessioni del
sistema ambientale, delle diverse parti urbane e dei luoghi di centralità.
La maggior parte delle procedure che il PSC si propone di utilizzare per essere operativo,
si caratterizzano come procedure partecipate e si pongono in continuità con
le forme di partecipazione già avviate e utilizzate durante la sua elaborazione. Infatti,
la redazione del PSC è stata caratterizzata costantemente dalla partecipazione
della società locale attraverso numerosi incontri con i suoi rappresentanti ed in particolare
con il forum di Agenda 21 locale. Gli incontri e i seminari tematici (settimana
del verde, seminario sul paesaggio, sulla gestione della città e sulla L.R. 20/2000),
i sopralluoghi sul territorio con le circoscrizioni, la presentazione di alcune fasi del
lavoro (incontro con Agenda 21 sulle proposizioni guida, visita guidata alla mostra
della bozza del preliminare e del quadro conoscitivo e la Conferenza di pianificazione)
sono state forse le più importanti.
A questa fase di partecipazione, legata all'individuazione di problemi e di temi e alla
prima verifica delle scelte, ora deve ovviamente seguire una fase più impegnativa,
riferita alla gestione e realizzazione del piano.
Le nuove richieste fatte al piano e la particolare congiuntura economica caratterizzata
da scarsità di risorse pubbliche rendono necessaria una precisa selezione
degli investimenti da parte della collettività e quindi la conoscenza e piena consapevolezza
delle opzioni di sviluppo possibili. Contemporaneamente, le stesse ragioni
di scarsità richiedono di immaginare scenari di attuazione adeguati, capaci di
superare le tradizionali modalità di realizzazione delle aree pubbliche e dei progetti,
attraverso un più deciso interessamento della società locale. Le recenti esperienze
di coinvolgimento dei soggetti privati nell'attuazione del piano, sia attraverso la realizzazione
diretta delle opere pubbliche che mediante la partecipazione a società
miste (Società di Trasformazione Urbana, Spa, ecc.), sono risultate particolarmente
efficaci soprattutto quando gli obiettivi pubblici e collettivi dei progetti erano chiaramente
predefiniti, non abbandonati ad un infinito processo di scambio. Questa
modalità di gestione del piano è percorribile soprattutto per la realizzazione di aree
per edilizia residenziale pubblica e per la trasformazione di parti urbane dismesse
in cui gli obiettivi collettivi intersecano gli interessi dei soggetti privati. In questo
caso, gli approfondimenti progettuali elaborati dal piano rientrano, come simulazioni
degli esiti delle operazioni immobiliari, nella formazione degli accordi tra pubblico
e privato.
Un differente aspetto gestionale riguarda poi la necessità di immaginare nuove modalità
di realizzazione del progetto ambientale previsto dal PSC. Tale progetto, per la
sua complessità e la molteplicità degli operatori coinvolti, rende plausibile il ricorso
ad uno specifico soggetto di riferimento, sia per la sua attuazione sia per la sua
gestione.
Il Piano propone di concentrare le competenze ambientali in una sorta di "authority
per il verde", attraverso cui avviare diverse e articolate modalità di realizzazione
delle previsioni e di ricerca delle risorse necessarie, ma anche di possibili operazioni
promozionali, puntando al necessario coinvolgimento di ulteriori soggetti.
Questa apertura verso la società locale (enti, privati, associazioni, ecc.) può rappresentare
una delle opportunità più innovative per la realizzazione del progetto
ambientale, ed essere letta come una sorta di implementazione concreta e non formale
delle azioni già previste da Agenda 21 locale. Alcuni ambiti della "città verde",
ad esempio, possono essere gestiti, sia per quel che riguarda la loro conformazione
fisica sia per le modalità di utilizzo, attraverso meccanismi di "autoregolamentazione"
dei comportamenti dei soggetti coinvolti (proprietari e utenti) che superino
l'attuale principio di acquisizione degli standard, puntando piuttosto sulla fruizione
degli spazi verdi e naturali. Tale ipotesi si ricollega alle recenti esperienze che associano
alla certificazione ambientale (Emas per la gestione del territorio, ecc.) un
"premio" per la corretta gestione di ambiti naturali.
Per raggiungere questi obiettivi risulta necessario mettere a punto specifiche modalità
di comunicazione degli obiettivi del PSC, in modo particolare per quanto riguarda
il progetto ambientale, cercando un'attiva partecipazione della società locale
alla sua realizzazione.
La sempre più rilevante complessità delle questioni legate al territorio, rendono
attuale la ricerca di strumenti innovativi che siano utilizzabili non solo per la formazione
di apparati conoscitivi ma anche e soprattutto per la comunicazione e
promozione delle proposte progettuali del piano. Le recenti esperienze degli Urban
Center sembrano muoversi nella direzione della messa a punto di tali strumenti.
L'opportunità di costituire un Urban Center a Ferrara, già verificata dall'amministrazione
comunale, sembra essere ulteriormente avvallata dalle questioni poste dalla
costruzione e gestione del nuovo Piano. Riconoscendo che anche la definizione più
precisa della sua struttura e forma, non può che avvenire nel tempo lungo, attraverso
processi in parte indipendente dalla costruzione di uno strumento urbanistico.
Ciò nonostante, alcune importanti riflessioni legate al nuovo piano possono diventare
spunti adatti alla sua realizzazione.
- Accanto alla necessaria acquisizione di dati e informazioni, avviata durante la fase iniziale di definizione del Piano, risulta sempre più importante garantire
continuità a tale attività d'indagine, in relazione sia al rilievo dei dati, sia all'osservazione
dell'attività edilizia, che al monitoraggio degli esiti degli strumenti urbanistici.
Questo apparato conoscitivo, se opportunamente organizzato, aggiornato e divulgato,
può rappresentare l'inizio di un sistema informativo tale da rappresentare un
importante patrimonio di conoscenza per la città.
- L'importanza che assume oggi la fase di implementazione del piano, richiede
l'introduzione di meccanismi adeguati a garantire la continuità tra la fase di
programmazione e quella di gestione dello strumento urbanistico.
- Le nuove esigenze di promozione del piano, rendono necessarie forme
di comunicazione che puntino ad un effettivo coinvolgimento della società locale
nella sua realizzazione. L'Urban Center può dare risposta a queste questioni grazie
al suo ruolo di possibile "interfaccia" tra lo strumento urbanistico e la città. Un'adeguata
struttura organizzativa e operativa può, infatti, colmare la distanza tra la società
locale e gli enti preposti al governo del territorio, attraverso la divulgazione e
gestione del sistema informativo territoriale, la costruzione di eventi riguardanti la
città ed il territorio, la definizione di strumenti ed elaborati utili per avviare e governare
la discussione su specifici temi e progetti di trasformazione urbana. Nell'ottica
della partecipazione, l'Urban Center può rappresentare il luogo dove sono depositati
i materiali della strumentazione urbanistica della città e, attraverso specifiche modalità,
può divenire il luogo dove l'implementazione del piano è monitorata e discussa
al fine di una sua costante verifica/rivisitazione. Esso può rappresentare anche
il luogo dove la città si espone ed espone i suoi progetti, al fine di renderli visibili e
verificabili, anche attraverso opportune tecniche di simulazione e di discussione
partecipata.
A partire da questi presupposti, diviene necessario approfondire quale RUOLO può
assumere il Piano Strutturale all'interno del più generale processo di governo del
territorio.
L'ipotesi è che il PSC rappresenti una sorta di regia. Uno strumento in grado di delineare,
a partire dalle scelte strutturali, anche una serie di questioni strategiche.
Il PSC di Ferrara interpreta questa ipotesi sia accollandosi l'onere di gestire i rapporti
e i contenuti delle diverse fasi della pianificazione, sia individuando alcune questioni
la cui gestione "strategica" è resa necessaria dalla complessità degli interventi.
Le note che seguono cercano di approfondire tali affermazioni nell'ottica di ridefinire
il ruolo del piano urbanistico.
La dimensione strategica del PSC di Ferrara prende avvio dall'individuazione e definizione
di alcune specifiche questioni territoriali che sembra necessario "governare
per sistemi".
Il presupposto di partenza è che la gestione della realizzazione di alcune scelte del
piano da parte di più soggetti interessati, attraverso strumenti di condivisione attiva,
possa rappresentare uno strumento di governo del territorio che completa quelli più
tradizionali dell'urbanistica. Da questo punto di vista il PSC "eredita" alcuni strumenti
strategici per la città già avviati al momento della sua definizione. Ne sono esempi:
l'accordo sottoscritto per l'area del Petrolchimico, il progetto finanziato per la trasformazione
dell'Idrovia e la realizzazione della Metropolitana di superficie. Tali progetti
strategici diventano parti integranti e importanti anticipazioni del PSC.
In continuità con l'opportunità di utilizzare tali strumenti di gestione del piano, il
PSC di Ferrara individua alcuni temi specifici, legati al buon funzionamento del territorio,
che necessitano di una gestione strategica (nel tempo) in grado di superare
i limiti propri degli strumenti di pianificazione, attraverso il coinvolgimento attivo
della comunità locale. Si tratta: del funzionamento del sistema idraulico, della realizzazione
e manutenzione della città verde, della rete della mobilità e dei trasporti,
della rete dei servizi ai cittadini, delle politiche abitative.
Nelle tavole "AZIONI DEL PIANO", il PSC riporta la "messa in rete" di questi temi che
diventano, quindi, obiettivi strutturali. Gli schemi di funzionamento proposti sono
costruiti con l'apporto di specifici tavoli tematici costituiti all'interno dell'UrbanCenter,
e avranno soprattutto nei piani operativi comunali (oltre che nella gestione ordinaria)
uno strumento importante per la loro realizzazione.
Più nel dettaglio, si prevede la costituzione dei seguenti tavoli tematici, alcuni dei
quali in continuità con quelli istituiti nella fase di costruzione del Quadro Conoscitivo:
- CASA. Tavolo dell'UrbanCenterFerrara che si pone l'obiettivo di programmare e gestire
le politiche abitative anche attraverso il monitoraggio del mercato immobiliare
con il coinvolgimento, oltre che dei soggetti istituzionali (Acer, comune, ecc.) anche
degli operatori di settore.
- VERDE. Tavolo dell'UrbanCenterFerrara che si pone l'obiettivo di realizzare e
gestire la rete della città verde con il coinvolgimento delle associazioni del mondo
agricolo e ambientale. L'elaborato di riferimento per questo tavolo, "RETE DEL VERDE"
|
|
"RETE DEL VERDE"
La tavola di gestione del verde
individua i differenti obiettivi
per tale tema e quindi le diverse
modalità di gestione:
- aree dei parchi urbani esistenti
e da realizzare (rispettivamente con
il colore verde chiaro e scuro);
- aree verdi interne al tessuto
urbano che possono diventare un
"sistema" articolato di spazi aperti
e servizi in grado di organizzare il
tessuto circostante (colore rosso
scuro);
- aree ed elementi vegetazionali
che rappresentano dei frammenti
isolati all'interno del tessuto urbano
e del territorio (colore celeste
chiaro);
- aree ed elementi vegetazionali
ai quali affidare il ruolo di
connessione e collegamento tra
le parti della città e del territorio
(colore verde oliva)
- aree per la compensazione
idraulica (colore bianco retinato);
- aree per per la mitigazione
ambientale (colore bleu).
|
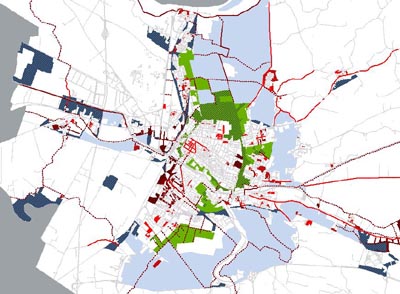 |
|
articola le diverse componenti del Sistema ambientale e dei servizi, in funzione
delle necessità di gestione:
- aree dei parchi urbani;
- sistemi di aree verdi all'interno del tessuto urbano;
- aree verdi che rappresentano dei frammenti isolati;
- aree ed elementi di connessione e collegamento:
- aree per la compensazione idraulica;
- aree per per la mitigazione ambientale.
- ACQUA. Tavolo dell'UrbanCenterFerrara che si pone l'obiettivo di realizzare
e gestire gli aspetti territoriali legati al funzionamento idraulico del territorio con il
coinvolgimento degli enti e delle amministrazioni competenti. Anche in questo caso
uno specifico elaborato del PSC stabilisce gli obiettivi strutturali rispetto al tema. Si
tratta dell'individuazione:
- delle opere strutturali necessarie al buon funzionamento del sistema di
scolo e irrigazione (ad.es.: vasche di compensazione lungo via Ferraresi, interventi
sul canale Boicelli, ecc.);
- degli obiettivi di funzionamento idraulico (autonomia di smaltimento, necessità
di collegamento alla rete, ecc.) delle aree di espansione e di trasformazione.
|
|
"RETE DELL'ACQUA"
La tavola di gestione dell'acqua
individua i differenti obiettivi che il
PSC indica rispetto a tale tema.
- l'individuazione delle opere
idrauliche alla scala territoriale
relative al buon funzionamento
idraulico dell'intero sistema (utilizzo
del Boicelli per collegare la rete
ad ovest con il fiume Po, aree di
espansione idraulica ad ovest
dell'insediamento di via Bologna e
ad est dell'insediamento delle aree
militari, la necessità di garantire lo
scolo della parte a nord dell'abitato
di Francolino, le opere necessarie al
funzionamento dell'area dedicata al
nuovo ospedale di Cona, ecc.);
- la definizione delle modalità
di smaltimento delle aree in cui
sono previsti i nuovi insediamenti
e le aree in cui collocare eventuali
ambiti di espansione idraulica.
|
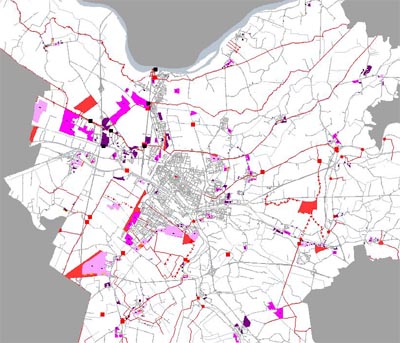 |
|
|
Questi obiettivi sono tradotti in una specifica Disciplina sulla "Gestione del Piano" fissata
nelle norme del PSC:
|
| |
capo ii - Gestione del piano
art. - Disposizioni generali
- Il PSC, oltre alle modalità di attuazione delle trasformazioni previste
nel capo i, definisce le modalità di gestione di alcune specifiche
linee d'azione, per la realizzazione degli obiettivi generali esposti.
- Le linee d'azione fanno riferimento a:
2.1 La città verde;
2.2 L'acqua come risorsa;
2.3 Abitare a Ferrara.
- Le linee d'azione si articolano a loro volta in comportamenti e
programmi che si realizzano secondo le modalità descritte negli
articoli seguenti.
art. - La città verde
- La linea d'azione "La città verde" persegue l'obiettivo di realizzare
e gestire gli spazi verdi, con particolare riguardo per gli ambiti
periurbani e gli spazi aperti pubblici, attraverso la partecipazione
di soggetti pubblici e privati.
- Essa si articola nella programmazione dei seguenti comportamenti:
- realizzare le previsioni del PSC per le aree della città verde;
- gestire le aree verdi pubbliche nella direzione della continuità del
sistema ambientale e della costruzione di un sistema a rete;
- promuovere e sostenere gli interventi sulle aree boscate di compensazione;
- promuovere e sostenere le politiche previste per le aree agricole
periurbane.
art. - L'acqua come risorsa
- La linea d'azione "L'acqua come risorsa" ha come obiettivo generale
l'ottimizzazione dell'uso della risorsa acqua anche in virtù di
un corretto funzionamento idraulico del territorio.
- Essa si articola nella programmazione dei seguenti comportamenti:
- promuovere l'uso turistico/ricreativo dei corsi d'acqua;
- razionalizzare e ottimizzare i consumi e gli scarichi urbani;
- gestire la qualità delle acque superficiali attraverso interventi sugli
scarichi e sui corsi d'acqua;
- realizzare le opere di adeguamento al funzionamento idraulico del territorio.
art. - Abitare a Ferrara
- La linea d'azione "Abitare a Ferrara" ha come obiettivo generale
la definizione e la gestione di adeguate politiche dell'abitare.
- Essa si articola nella programmazione dei seguenti comportamenti:
- gestire politiche per l'edilizia residenziale pubblica;
- promuovere un'idea di qualità dell'abitare che comprenda gli
aspetti legati alla sostenibilità degli interventi;
- promuovere l'uso residenziale del centro storico;
- monitorare l'attività edilizia in particolare attraverso i principali
andamenti del mercato immobiliare.
art. - Modalità attuative
- L'attuazione delle linee d'azione si fonda sul metodo della partecipazione
continua che ha caratterizzato la costruzione del Documento
Preliminare, del Quadro Conoscitivo e del Piano Strutturale.
- Essa avviene attraverso l'articolazione, il completamento e la
condivisione dei comportamenti previsti dall'amministrazione comunale
da parte di una rete di soggetti interessati che potrà costituirsi
come associazione/istituzione/agenzia/ente.
- La condivisione dei comportamenti dovrà essere espressa con
la sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa da parte dei soggetti
componenti le associazioni/istituzioni/agenzie/enti.
I Protocolli d'Intesa dovranno in particolare contenere gli impegni
dei soggetti per:
- il più ampio coinvolgimento per il raggiungimento degli obiettivi
previsti;
- programmare le attività per la realizzazione delle azioni previste;
- impostare le modalità per il recupero delle risorse necessarie alla
attuazione dei programmi;
- attivare consultazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei
programmi e sui risultati ottenuti.
- Le associazioni/istituzioni/agenzie/enti, oltre a realizzare gli
obiettivi/azioni previsti, hanno anche lo scopo di assicurare la
massima informazione sui risultati conseguiti sia verso i soggetti
coinvolti che verso la comunità locale.
- Le funzioni di promozione, formazione, costituzione delle associazioni/
istituzioni/agenzie/enti, e il loro coordinamento saranno
svolte dall'Urban Center. Lo stesso Urban Center svolgerà anche i
compiti di monitoraggio e verifica degli esiti, necessari ai lavori delle
associazioni/istituzioni/agenzie/enti.
art. - Urban center
- L'Urban Center rappresenta la struttura che il comune di Ferrara
prevede per la cooperazione alla gestione delle politiche sul territorio
da parte delle diverse componenti della società locale. A tale
scopo l'Urban Center assume il compito di promuovere la partecipazione
dei diversi soggetti locali alla discussione e alla valutazione
delle trasformazioni facilitando lo scambio delle risorse conoscitive
detenute dai diversi attori locali.
- L'Urban Center è costituito dal comune di Ferrara e comprende.......
- Le attività principali dell'Urban Center riguardano:
3.1. la promozione della discussione sui principali progetti per la
città;
3.2. l'informazione sull'uso degli strumenti urbanistici e sulle modalità
di attuazione degli interventi;
3.3. la promozione, il coordinamento e la formazione delle associazioni/
istituzioni/agenzie/enti, al fine della realizzazione degli
obiettivi strategici previsti dal PSC
3.4. il monitoraggio degli esiti del PSC e delle azioni previste.
- Al fine degli scopi previsti l'Urban Center si avvale del Sistema
Informativo Territoriale.
|
|
|
|
|
|
Nuovo piano urbanistico di Ferrara
Piano strutturale comunale
Gaetano Sateriale, sindaco
Raffaele Atti, assessore all'urbanistica e edilizia
Claudio Fedozzi, capo settore territorio esviluppo economico
Ufficio di Piano:
Antonio Barillari, coordinatore
Andrea Ansaloni, Andrea Chieregatti, Mario Lazzari, Paolo Padovani,
Paolo Perelli, Enrico Simoni
con
Franco Beneventi, Barbara Bonora, Anna Calzolari, Stefano De Biaggi,
Fabio De Luigi, Antonella Maggipinto, Valeria Manfredini, Patrizia
Masola, Cristiano Rinaldo, Sandra Sarasini.
ISP IUAV studi e progetti srl
Marino Folin, coordinatore Carlo Magnani, responsabile generale del Piano
con
Stefano Munarin, Daniele Paccone, Maria Chiara Tosi, consulenti generali e coordinatori del gruppo di lavoro
Mario Spinelli, direttore
Luca Borsa, Sebastiano Capasso, Michele D'accordi, Barbara Leoncin, Massimo Marchetti, Maria Rosaria Pastore, Sara Ragni, Marco Scanferlin.
Consulenze: specialistiche:
Analisi subsidenza Marco Gatti
Analisi geologiche Marco Bondesan
Analisi idrogeologiche Alessandro Gargini con
Andrea Messina, Monica Pasini,
Leonardo Piccinini, Arianna Zanella,
Federica Biavati, Igor Maccanti, Igor Villani.
Valutazione di Sostenibilità Ambientale Giovanni Campeol con
Sandra Carollo, Lisa Corte, Viviana Botta,
Cinzia Lodi Lancellotti
Analisi archeologiche Chiara Guarnieri, Claudio Negrelli con Dario Deserri.
Analisi socio-economiche Patrizio Bianchi con
Luigi Salmaso, Gianfranco Franz, Simona Boari,
Rosa Arboretti, Francesca Frassoldati
Analisi Agronomiche
Carlo Fiorenza
Aspetti giuridici
Federico Gualandi
|
|
|
 Comune di Ferrara
Comune di Ferrara Comune di Ferrara
Comune di Ferrara